Investire in base agli Obiettivi – Cos’è il Goal-Based Investing?
Qual è il reale motivo per cui investiamo? Massimizzare il rendimento o realizzare i nostri obiettivi? Parliamo di come nasce il modello del Goal Based Investing e di come impostare il portafoglio in funzione degli obiettivi della nostra vita.
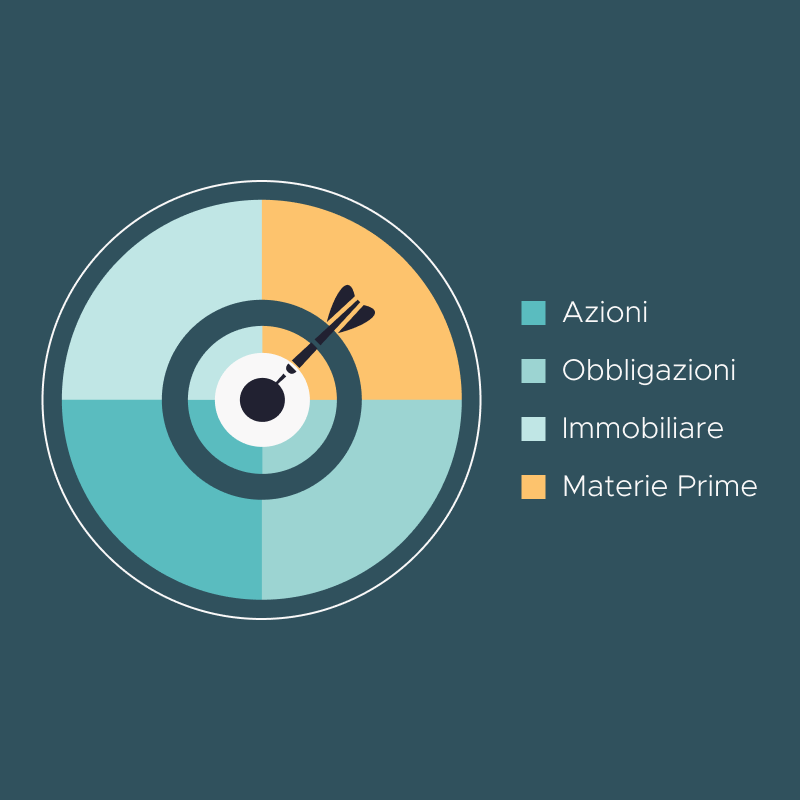
174. Investire in base agli Obiettivi – Cos’è il Goal-Based Investing?
Risorse
Punti Chiave
Il rischio per l'investitore privato è non raggiungere i propri obiettivi di vita, non la sola volatilità: focus sul Goal Based Investing.
Integrare i bias della finanza comportamentale (es.Mental Accounting) per costruire portafogli più adatti agli obiettivi personali e flessibili.
Trascrizione Episodio
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale
Anche quest’anno le festività ce le siamo lasciate alle spalle, mi auguro che abbiate fatto il pieno di panettoni e pandori — anche se da milanese per me il pandoro è come un errore dentro Matrix — e che oltre ai vostri stomaci per via degli eccessi alimentari, anche i vostri cuori si siano allargati di gioia nel tempo passati con i vostri cari.
Il mio stomaco non si è ancora ripreso — del resto, quando durante il pranzo di Natale il primo arriva in tavola alle 5 del pomeriggio, questo è un segnale inequivocabile che c’è stata un po’ di euforia irrazionale in colui che ha fatto la spesa, altro che il price earning ratio a 22 dell’S&P 500.
Però le festività Natalizie sono anche il classico momento di riflessione, uno di quei momenti in cui in qualche modo azzeriamo il contatore della nostra vita e ci ripromettiamo di partire nell’anno nuovo con qualche risoluzione destinata, almeno in teoria, a rivoltare in meglio il corso della nostra esistenza.
Se così è stato, se vi siete dati nuovi obiettivi per il 2025, cosa c’è di meglio se non un episodio dedicato a parlare di una famosa strategia di investimento chiamata appunto “Goal Based Investing”, ossia investire in base agli obiettivi?
Così come abbiamo fatto per l’episodio sul Retirement Portfolio, sul portafoglio per vivere di rendita, anche quest’episodio sarà un’introduzione al tema del Goal Based Investing, trattandosi di un ambito sconfinato e che ci richiederà di tornare più volte per inquadrarlo nelle sue diverse prospettive.
In realtà quella del Goal Based Investing è una filosofia alla base di buona parte di questo podcast, che pur parlando spesso degli aspetti più quantitativi dell’asset allocation e del comportamento delle varie asset class, nei fatti è guidato soprattutto dall’idea di adottare un approccio estremamente pragmatico alla costruzione del portafoglio.
Oggi cerchiamo di capire cosa intendo con questa cosa e come portare ad un livello successivo il modo in cui tutti noi ragioniamo per impostare nel modo migliore il nostro portafoglio NON TANTO in funzione della massimizzazione del rendimento atteso, quanto piuttosto in vista della realizzazione dei nostri obiettivi di vita.
La finanza personale ha certamente a che fare con i soldi.
Ed è pura piena di numeri, formule ed equazioni.
Ma ricordiamoci sempre che essa più che una scienza è un insieme di discipline comportamentali e decisionali che deve portarci a migliorare la nostra vita, incidendo in maniera positiva — o almeno così si spera — sulla risorsa più fungibile che abbiamo e che più di ogni altra permettere di progettare la nostra esistenza come meglio crediamo: la nostra ricchezza finanziaria.
Se sei il gestore di un fondo il tuo obiettivo quotidiano sarà prendere decisioni per costruire il portafoglio migliore dal punto di vista quantitativo. Ti interesserà lo Sharpe ratio, ti interesserà la sua volatilità, ti interesserà il suo rendimento e soprattutto ti interesserà di non fare danni per evitare che i clienti portino i soldi da un’altra parte.
Ma quando si tratta del nostro patrimonio personale, le logiche di investimento non sono esattamente le stesse di quello istituzionale.
All’investitore istituzionale interessa la massimizzazione del rendimento del portafoglio per unità di rischio assunta, mentre all’investitore individuale interesserà soprattutto realizzare i propri obiettivi di vita attraverso una crescita adeguata del patrimonio.
Per capire la differenza, direi di partire da uno dei concetti fondazionali dell’economia moderna, che è quello di “utilità marginale decrescente”, che già più volte abbiamo incontrato lungo il nostro pellegrinaggio bisettimanale.
L’idea di base è che l’utilità marginale, cioè il beneficio aggiuntivo ottenuto da un’unità supplementare di un bene o servizio tende a diminuire man mano che il consumo di quel bene o servizio aumenta.
Detta alla buona: la prima fetta di panettone con il mascarpone che mangerò a Natale sarà spaziale, mentre man mano che andrò avanti a mangiare fette aggiuntive il mio piacere e la mia soddisfazione incrementale diminuiranno.
In economia però vige questa sorta di contraddizione concettuale per cui l’agente economico — per esempio noi investitori — sarebbe interessato a massimizzare la propria utilità in senso assoluto, perché in effetti razionalmente questa è la cosa più sensata.
In realtà, se ci pensate, a noi interessa massimizzare l’utilità marginale fino al punto in cui questa diventa zero, cioè fino al punto in cui un consumo aggiuntivo non ci provoca alcun ulteriore beneficio.
Quando investiamo alla maggior parte di noi non interessa far sì che il nostro portafoglio raggiunga il più alto valore possibile.
A noi interessa che cresca fino al punto in cui la sua utilità marginale si annulla, cioè fino al punto in cui avere un euro in più non ci fa alcuna differenza.
Se io oggi avessi un portafoglio da cinque milioni di euro probabilmente il mio obiettivo non sarebbe massimizzare il rendimento atteso del mio portafoglio, ma conservare il più a lungo possibile quei 5 milioni così da finanziare tutti gli obiettivi della mia vita.
E probabilmente mi basterebbe molto meno di cinque milioni.
Poi ciascuno setta il punto dove l’utilità marginale si appiattisce dove gli pare.
Negli anni, per esempio, mi sono chiesto perché certi calciatori che guadagnavano magari 10 milioni netti all’anno litigassero con la società per avere un nuovo contratto da 12 o 15.
Cioè, ma con 10 milioni netti all’anno, ma davvero ti fanno la differenza quei 2 o 3 in più?
In fondo, senza arrivare alle superstar, un buon calciatore che gioca in una squadra che fa la Champions, nell’arco della sua carriera probabilmente oggi 20-30 milioni li porta a casa.
Con 20 milioni investiti in un portafoglio che rende il 5% all’anno puoi permetterti di spendere 50.000 euro al mese, adeguati all’inflazione, per tutta la tua vita senza mai esaurire il capitale.
Poi però mi sono ricordato due cose: la prima è che probabilmente sono gli agenti dei calciatori a spingere certe dinamiche, per interessi che poco hanno a che fare con quelli dei loro assistiti, quindi qui c’è mezza risposta.
L’altra è che più guadagni — e soprattutto più guadagni in mondi come quello — più il tuo standard di vita si alza e a quel punto la macchina bella non ti basta più, vuoi la Ferrari e la Lambo, poi vuoi lo yacht, poi vuoi l’aereo privato, poi vuoi una villa imperiale, poi vuoi un’isola intera e così via.
I soldi non bastano mai quando subentra la lifestyle inflation.
Divagazione calcistica a parte, il punto è che se siamo persone normali e non ci chiamiamo Lionel o Cristiano, noi non impostiamo il nostro portafoglio SEMPRE e SOLO per massimizzare il rendimento, ma più probabilmente per raggiungere ciò che serve a finanziare i nostri obiettivi.
Ed è sulla base di un ragionamento di questo tipo che ad un certo punto ci si è iniziati a chiedere se le teorie basate sulla massimizzazione del rendimento del portafoglio avessero senso anche per gli investitori retail o se invece non fossero più adeguate agli investitori istituzionali.
Prima di addentrarci però nel percorso che ha portato a quel che oggi sappiamo su come si fa un portafoglio, permettetemi di dirvi che anche quest’anno 4books accompagna questo podcast come suo sponsor per mettervi a disposizione oltre 1800 contenuti tra audioriassunti di libri bestseller, Podcast e corsi su temi chiave per la tua vita come investimenti, comunicazione, gestione dello stress, fitness, marketing, educazione dei figli e molti altri.
Con il link in descrizione oppure andando su www.4books.com/thebull potrete provare gratis 4books per 7 giorni e poi ricevere il 30% di sconto sull’abbonamento annuale, che sarà quindi di 69,99 € invece che 99,99.
Attenzione: ascoltare audioriassunti in 15 minuti di tutti i libri che avreste sempre voluto leggere e non avete mai avuto il tempo BARRA la voglia di prendere in mano genera dipendenza più del Trono di Spade.
Usare con cautela, l’uso eccessivo di 4books potrebbe rendere l’utente eccessivamente intelligente, acuirne pericolosamente lo spirito critico e fornirgli un minaccioso vantaggio competitivo nelle aree che più lo interessano.
Ah ovviamente il link è sponsorizzato, bla bla bla, se lo usate e vi abbonate 4books mi paga commissioni milionarie … solite cose … qua siamo avidi e non si fa niente per niente.
Dicevo: breve recap sulle origini di quei principi di base di asset allocation di cui parliamo sempre.
Prima del 1952 investire voleva dire: “individuare securities con buoni fondamentali ed un prezzo possibilmente sottovalutato che promettessero di massimizzare il ritorno sull’investimento attraverso i suoi flussi di cassa”.
Il tanto celebrato libro The Intelligent Investor di Ben Graham, il maestro di Warren Buffet, non aveva minimamente in mente che un portafoglio fosse un insieme di asset costruito in maniera tale che questi in qualche modo collaborassero tra loro.
Per lui investire era identificare società sottovalutate ed eventualmente rivenderle quando il prezzo fosse salito oltre un certo livello (e tra l’altro quest’ultimo è esattamente il punto su cui Buffet si è con successo distaccato dal maestro).
Nel 1952 invece Harry Markowitz cambia per sempre la storia della finanza con il paper “Portfolio Selection” che sancisce per convenzione la nascita della Teoria Moderna del Portafoglio, la Modern Portfolio Theory nota anche come MPT, basati sui concetti di mean-variance (cioè di media varianza), di frontiera efficiente e di rischio e rendimento.
In pratica in cosa consiste la rivoluzione di Markowitz?
Portfolio selection è in qualche modo il paper che introduce a livello definitivo il concetto di diversificazione del portafoglio.
Per Markowitz il portafoglio migliore è quello che massimizza il rendimento atteso rispetto ad un determinato livello di rischio combinando asset con una bassa co-varianza, che poi è il concetto statistico per definire la correlazione tra due asset.
Lo sappiamo bene no? Se mettiamo nel portafoglio anche una manciata di azioni americane tech non stiamo diversificando una cippa.
Se invece facciamo un portafoglio composto da azioni di diversi settori, regioni e dimensioni e di altri asset con una correlazione relativamente bassa come le obbligazioni, allora sì che abbiamo un portafoglio diversificato.
Prima di Markowitz il portafoglio migliore era quello con il miglior rendimento atteso.
Dopo Markowitz, il portafoglio migliore è quello che massimizza il rendimento rispetto al rischio assunto.
Questa idea rivoluzionaria incorpora già in parte il concetto secondo il quale cercare di ottenere un maggiore rendimento al costo di un’assunzione di rischio più che proporzionale va contro il principio di utilità marginale decrescente.
È come dire: se sono bravo a sciare e voglio divertirmi con piste più impegnative faccio quelle nere. Mentre sciare fuori pista comporta un rischio non compensato dal maggiore divertimento, perché l’upside è un po’ di adrenalina in più, il downside è che ci lasci le penne.
Quindi un portafoglio che rinuncia alla diversificazione per ottenere più rendimento comporta in media un rischio asimmetrico negativo, cioè ho più da perdere che da guadagnare.
Sull’idea di impostare un portafoglio basato sulla massimizzazione non tanto del rendimento, quanto del rapporto tra rischio e rendimento attraverso la diversificazione, si basa fondamentalmente la finanza moderna.
Il contributo decisivo al modello di Markowitz lo diede il suo allievo — e anche lui futuro premio Nobel — William Sharpe, che noi qui conosciamo tutti molto bene perché fu colui che elaborò il Capital Asset pricing Model e naturalmente lo Sharpe Ratio.
Sharpe fu colui che per primo formalizzò alcune delle idee che sono diventate dei pilastri di tutta la filosofia dell’investimento passivo di cui tanto parliamo qui.
Intanto introdusse il concetto di rischio sistematico, espresso attraverso il famoso BETA. Vi ricordate?
Il rendimento di un portafoglio è dato dal rendimento del mercato di riferimento meno il risk-free-rate moltiplicato appunto per BETA, che è questo valore maggiore o minore di 1 che esprime appunto la sensibilità del rendimento del portafoglio rispetto ai movimenti del mercato.
Per CAPM il rischio specifico non viene contemplato, nella misura in cui questo può essere sempre diversificato.
Nella sua versione estrema, il CAPM dice: il rendimento del tuo portafoglio, nella misura in cui è diversificato in maniera efficiente, è una funzione del BETA, ossia del rischio sistematico che si assume.
In realtà poi sappiamo che Beta non è sufficiente a render conto di tutto e infatti negli anni ’90 Eugene Fama e Ken French formalizzano i fattori Value, Small Caps, Profitability e Investment, mentre Jeegadesh e Titman introdussero il momentum, che effettivamente spiegavano una buona parte di quelle situazioni in cui l’extra rendimento sistematico non di un portafoglio non sembrava potesse essere ricondotto esclusivamente al fatto di avere un maggior Beta.
L’altro concetto fondamentale introdotto da Sharpe fu chiamato inizialmente Reward to Variability Ratio, nel 1966.
Il nome però ebbe poco successo e nel 1994 fu Sharpe stesso a chiamarlo Sharpe Ratio e da lì divenne Sharpe Ratio per tutti.
Lo Sharpe Ratio è la misura ufficiale del rapporto tra rischio e rendimento di un portafoglio.
L’indice di Sharpe è calcolato come Rendimento in eccesso del portafoglio rispetto al risk free rate diviso la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
Maggiore è il valore, maggiore è l’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento.
Poi qua non ci addentriamo in tutti i limiti dello Sharpe Ratio, che ovviamente come tutti i modelli è imperfetto per definizione, ma rappresenta se non altro un modo coerente per confrontare diversi portafogli tra loro con un criterio chiaro.
Rischio però, per Markowitz, Sharpe e per tutta la finanza classica, è appunto espresso come varianza, cioè come volatilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio di un asset e per motivi di praticità matematica, solitamente si usa la sua radice quadrata, che come tutti voi ben sapete si chiama deviazione standard.
Il rischio finanziario è quindi quanto si discosta il rendimento di un asset dal suo rendimento atteso, cioè dal suo rendimento medio, in un certo tempo.
Noi tutti sappiamo che, in linea di principio, i rendimenti tendono a regredire verso la loro media storica, quindi teoricamente il rischio finanziario inteso come volatilità si riduce man mano che l’orizzonte temporale si allunga.
Ora, per l’investitore istituzionale, la definizione di rischio come deviazione standard può anche andare bene per i suoi scopi ed effettivamente, giusta o sbagliata, è una misura oggettiva del rischio.
Però qui per noi investitori privati cominciano una serie di problemi.
PROBLEMA UNO: la deviazione standard presuppone che i rendimenti di un investimento siano distribuiti normalmente, cioè devono seguire la forma a campana della curva di Gauss.
Se simulate milioni di lanci di testa o croce avremo situazioni estreme con tante teste o tante croci consecutive mentre 2/3 delle simulazioni saranno concentrate attorno al centro, dove teoricamente si trova la situazione ideale di metà teste e metà croci.
Allo stesso modo sono distribuiti normalmente le altezze o i pesi degli esseri umani, dove pochissimi maschi adulti peseranno 300 kg o 30 kg mentre 2/3 si collocheranno intorno al valore medio che sarà, boh, 70-80 kg suppongo.
E così via.
I fatti della finanza invece non sono distribuiti normalmente, perché come si dice hanno “fat tail”, hanno code grasse, cioè gli eventi rari accadono più spesso di quel che la statistica prevedrebbe.
Infatti per esempio Nassim Taleb contesta pesantemente l’uso della statistica Gaussiana in finanza, preferendo altri modelli come ad esempio quello di Pareto, delle leggi di potenza e della distribuzione frattale dei rendimenti, utilizzati dal suo mito, genio della matematica e della finanza, Benoit Mandelbrot.
Al di là del dibattito accademico, il primo problema per noi investitori è che possiamo fare tutte le stime di questo mondo usando i rendimenti attesi e la loro varianza, ma UNO: i rendimenti attesi sono una stima che sì converge verso la media, ma resta pur sempre una stima e DUE: il rischio come varianza per noi è pericoloso perché in effetti potrebbero capitare cose molto più brutte di quel che i modelli descrivono, proprio perché in finanza capitano eventi rari e imprevedibili più spesso di quel che dovrebbero.
Quindi se noi facciamo tutta la nostra bella pianificazione e ci assumiamo un certo rischio come se le leggi della probabilità valessero tout court, ecco potremmo avere brutte sorprese.
E questo è il primo problema.
In media più o meno tutta la finanza classica ci prende, ma nel caso singolo rischio di farmi più male di quel che il modello aveva previsto.
Il PROBLEMA NUMERO DUE riguarda invece delle nostre deformazioni cognitive.
Kahneman e Tversky avevano scoperto, tra i vari, uno dei bias più importanti e gravi per un investitore, cioè il loss aversion, l’avversione alle perdite.
I due aveano dimostrato che a noi fa bruciare più il didietro perdere 100 poi ho bisogno in media di guadagnarne 200 per essere emotivamente in pari.
La Modern Portfolio Theory, il CAPM e la Efficient Market Hypothesis, che naturalmente è una conseguenza di questa linea di pensiero, non contemplano i bias degli investitori.
Eppure, efficiente o no che sia, poi quando prendiamo decisioni per il nostro portafoglio dobbiamo tenere conto del fatto che una perdita ci farà più male di un guadagno e quindi anche se razionalmente sarebbe meglio un certo portafoglio, a me singolo individuo bacato potrebbe andar meglio un portafoglio meno efficiente ma che mi fa stare meglio.
Richard Thaler poi negli anni ’80 introdusse il concetto di Mental Accounting, di contabilità mentale.
E questa roba è un altro bel problema per la finanza classica, che parte dal presupposto che il denaro sia fungibile, cioè 100 , a prescindere da come li hai guadagnati, da come li hai persi, dallo scopo che hanno e in generale dal significato che gli attribuisci.
Invece gli esseri umani, in media, non trattano il denaro come fungibile, ma gli attribuiscono etichette e valori differenti a seconda delle circostanze.
Se con fatica porto a casa determinati soldi con il mio duro lavoro, quei soldi li tratterò diversamente da quelli che invece potrei vincere in una scommessa o che potrei ricevere da un’eredità.
Razionalmente questa cosa non ha senso, ma sapete tutti bene che noi ragioniamo e agiamo così.
E quindi qual è il problema nella costruzione del portafoglio?
Il problema è che la finanza classica dice: costruisci il portafoglio che massimizza il rendimento per un certo livello di rischio.
Il singolo individuo invece tende ad assegnare ai vari pezzi del proprio capitale significati diversi in base allo scopo a cui sono destinati.
E questo per la finanza classica è completamente inefficiente.
Negli anni ’40 però Abrahm Maslow aveva introdotto la teoria della gerarchia dei bisogni umani, sostenendo che istintivamente l’uomo fosse portato a soddisfare PRIMA i bisogni primari fisiologici e di sicurezza e POI via via si muovesse verso quelli di autorealizzazione.
Riprendendo quest’idea, qualcuno ha cominciato a pensare a modelli alternativi di costruzione del portafoglio che rispondessero a questa gerarchia di bisogni che tutti noi ci portiamo dietro fin da quando nasciamo.
Se sono 174 episodi che vado predicando: “mi raccomando, PRIMA il fondo di emergenza che se succede qualcosa poi sono cazzi, e POI solo a quel punto investiamo come se non ci fosse un domani” è proprio perché “safety first”, la sicurezza prima di tutto e poi puntiamo alla libertà finanziaria.
Potete facilmente immaginare quanto ami Eugene Fama, l’idea dei mercati efficienti e tutto l’impianto della finanza classica, soprattutto dopo che è venuto da me nel podcast, però come essere umano in effetti per me la sicurezza e la pace psicologica pesano di più dello Sharpe Ratio e questo potrebbe portarmi a prendere decisioni meno efficienti.
Perché poi il grosso della distanza che separa il modello dei portafogli efficienti adatto agli investitori istituzionali da ciò che serve all’investitore privato è esattamente come definiamo il RISCHIO.
Per la finanza classica, il RISCHIO è la varianza dei rendimenti, la volatilità, la deviazione standard.
Per me singolo investitore, il RISCHIO è quello di non realizzare i miei obiettivi.
Io investo per uno scopo — o per più scopi.
Diventare ricco, proteggermi dall’inflazione, mandare i miei figli all’università, comprare la villa dei miei sogni, vivere di rendita, quello che vogliamo.
In quest’ottica, sticazzi la deviazione standard.
Il mio rischio più grande non è avere un portafoglio non efficiente.
Il mio rischio più grande è non realizzare gli obiettivi che danno un senso alla mia vita.
Ci sono stati tanti lavori di accademici e professionisti che hanno provato a sanare la questione.
Tra questi ci sono forse 3 passaggi decisivi.
Il primo è stato il lavoro di Shefrin e Statman, che hanno sviluppato la Behavioral Portfolio Theory, BPT.
La BPT, invece basarsi sull’idea di rischio come varianza suggerisce che il rischio sia la probabilità di non realizzare un certo rendimento minimo necessario per soddisfare un determinato obiettivo.
Cioè il rischio non è la deviazione standard dei rendimenti.
Il rischio è non realizzare il tuo goal.
Mentre negli anni ’50 Markowitz elaborava la MPT, un altro accademico di nome Andrew Roy formulò il concetto di Safety-First criterion, cioè il criterio “la sicurezza prima di tutto”.
Questa formula in pratica dice quanto è probabile che un certo portafoglio ci permetta di realizzare un determinato rendimento minimo.
Fate attenzione perché è interessante.
La formula è molto semplice:
– Rendimento atteso del portafoglio MENO
– Rendimento minimo che voglio ottenere DIVISO
– Deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
In base a questo criterio io non sceglierò tra due portafogli NÉ quello che ha il rendimento atteso maggiore, NÉ quello con il rapporto tra rischio e rendimento maggiore, lo Sharpe Ratio. Bensì quello che mi dà la maggiore probabilità di centrare l’obiettivo minimo.
Facciamo un esempio.
Prendiamo 3 portafogli:
– 100% MSCI World
– 60% MSCI world e 40% Obbligazioni governative globali e
– 40% MSCI world e 60% Obbligazioni governative globali
Ammettiamo che il rendimento atteso dei 3 portafogli sia rispettivamente 8% all’anno, 6% e 5% e che la loro deviazione standard sia 15%, 8,5% e 7,5%.
Ammettiamo inoltre che io voglia ottenere un rendimento minimo di almeno 3% all’anno.
Qual è il portafoglio migliore?
Secondo il Safety First Criterion le mie migliori chance sono con il portafoglio 60/40.
Se invece il mio obiettivo minimo fosse 4%, allora sarebbe il portafoglio 100% azionario a massimizzare le probabilità di successo.
Il Safty First Criterion è in qualche modo un’alternativa allo Sharpe Ratio e ha anche una forma simile, solo che invece che fare rendimento atteso meno risk free rate diviso deviazione standard, fa rendimento atteso meno rendimento minimo, diviso deviazione standard.
Mentre lo Sharpe ratio dà il portafoglio più efficiente, il criterio di Roy dà il portafoglio teoricamente più robusto per il mio obiettivo minimo.
Ora, è chiaro che anche qui ci sono delle limitazioni che sono un po’ sempre le stesse:
– Il rendimento atteso è una stima molto complicata da fare; e
– La deviazione standard ha le problematiche statistiche di cui abbiamo parlato.
Nel 2000 Hersh Shefrin e Meir Statman scrissero un paper dal titolo Behavioral Portfolio Theory in cui provarono a elaborare un’alternativa al modello di MArkowtiz introducendo il criterio di Roy.
Il punto di partenza era il cosiddetto paradosso di Friedman e Savage, che nel 1948 osservarono che razionalmente non avesse senso che le persone acquistassero sia le assicurazioni che i biglietti della lotteria, cosa che invece è comprensibile con l’idea di Mental Accounting.
Secondo Shefrin e Statman il modello di Markowitz è “inconsistent”, è incoerente e inconciliabile con questo paradosso e formularono un modello alternativo che in pratica porta a costruire portafogli a due strati, dove lo strato inferiore risponde all’idea di soddisfare il primario bisogno di sicurezza e di non finire poveri mentre quello superiore è finalizzato al piano aspirazionale, cioè a realizzare obiettivi che per noi sono desiderabili ma non vitali.
Nel 2010 poi Statman, Markowitz stesso e altri due produssero un lavoro dal titolo Portfolio Optimization with Mental Accounts e cercarono, come dire di mettere insieme le forze e unire la Modern Portfolio Theory con la Behavioral Portfolio Theory.
Per farla breve, nello studio si è cercato di creare un framework, cioè un modello di costruzione del portafoglio, composto da tre elementi:
– L’idea che il portafoglio abbia più strati destinati a diversi scopi;
– Una definizione di rischio come probabilità di non raggiungere un certo livello minimo di rendimento in ciascun account mentale, cioè in ciascuno strato del portafoglio e infine
– Una propensione al rischio diversa per ciascuno strato.
La soluzione, detta alla buona, sarebbe che l’investitore sceglie la massima probabilità di fallimento che è disposto ad accettare per ciascuno strato del portafoglio e quella probabilità viene tradotta in un determinato livello di avversione al rischio. A quel punto subentra il modello di Markowitz per impostare i diversi strati del portafoglio usando quel livello come soglia di rischio rispetto al quale costruire un portafoglio efficiente che massimizza il rendimento atteso.
Cioè il portafoglio efficiente non sarebbe più quello che massimizza il rendimento per un determinato livello di varianza, bensì per un determinato livello di rischio definito come probabilità massima accettabile di non realizzare un certo rendimento minimo.
Sulla scorta di questi lavori sarebbe poi nato il Goal Based Investing, che forse ha la sua espressione più strutturata nel libro di Jean Brunel dal titolo “Goal Based Wealth Management”, del 2015.
Rispetto al modello della finanza classica, l’investimento per obiettivi si basa su questi 4 presupposti:
– Raggiungere obiettivi personali;
– Il rischio è definito come probabilità di non raggiungere il rendimento minimo necessario;
– Il portafoglio ha più strati, ossia ha diverse allocation per ciascun obiettivo, chiamato Bucket, cioè per ogni obiettivo ci sarebbe metaforicamente un cestino dedicato, un conto mentale separato per ogni scopo;
– E infine tiene conto dei bias comportamentali.
Ovviamente questo modello non è esente da limiti.
– Intanto elaborare diversi sottoportafogli richiede un lavoro più complesso e più manutenzione rispetto ad un portafoglio buy and hold;
– In secondo luogo, non è banale stimare la probabilità di fallimento che sono disposto ad accettare rispetto ad un rendimento minimo necessario per un mio obiettivo, così come il rendimento atteso e la volatilità futura restano delle stime;
– Infine, per quanto sembri ovvio il contrario, in realtà è molto difficile sapere con grande anticipo quali saranno i miei obiettivi futuri:
– Oggi potrei pensare che tra 18 anni mi figlia andrà all’università, ma magari non vorrà farla;
– Oppure penso che tra 10 anni vorrò cambiare casa — e invece ciò potrebbe accadere tra 5 o mai;
– Per non parlare poi delle grandi incognite della vita, a volte molto belle, a volte molto brutte, che in un secondo possono stravolgere la migliore delle pianificazioni.
Se ci pensate, l’approccio che ho sempre suggerito in questo podcast e nel mio libro si basa più su questo approccio pragmatico e goal-based, che non sull’idea della finanza classica, che va benissimo per il gestore istituzionale, ma ha poco senso per quello privato.
Però non è così rigido da pensare al portafoglio in termini di “Bucket”, di singoli comparti in cui pezzi del portafoglio sono destinati a specifici obiettivi.
L’idea è piuttosto quella di costruire un’asset allocation flessibile e riadattarla periodicamente in base a come mutano le esigenze della vita.
Prendiamo il solito metodo che parte dalla formula di The Bull e che ho descritto nel dettaglio anche nel mio libro.
L’idea di partenza è certamente molto Markowitz, Sharpe, Fama: azioni e obbligazioni, replicando il mercato.
La percentuale di azioni di partenza può essere calcolata come 125 — i propri anni — il risk free rate * 5, almeno nella fase di accumulo, poi nella fase di Retirement è un altro discorso, come avevamo detto nell’episodio 169.
Facciamo il mio caso, ho 38 anni, il risk free rate in America è circa 4 virgola qualcosa %, Europa circa 3, facciamo 4 per semplicità e perché siamo più esposti agli Stati Uniti che all’Europa.
125 — 38 — 4*5 20 fa 67% azioni e 33% obbligazioni.
Però poi a questo punto però subentra l’idea semi “Goal based” diciamo così di adattare l’allocation a due cose:
– Ai miei obiettivi di vita e
– Alla mia tolleranza al rischio.
Il consiglio è proiettare la crescita del portafoglio nel tempo e verificare nelle varie fasi future della mia vita come cresceranno la parte azionaria ma soprattutto quella obbligazionaria e adattare il portafoglio di conseguenza.
Sappiamo che in ogni momento la parte azionaria potrebbe perdere tranquillamente il 50% del suo valore, mentre la parte obbligazionaria sarà mediamente più stabile.
Ok nel 22 le obbligazioni sono sprofondate, ma oggi i tassi sono al 3% e non a zero e se in futuro torneranno a zero chi ha ascoltato The Bull saprà già che riempirsi di obbligazioni a medio lungo termine con tassi molto bassi sarebbe un suicidio finanziario.
Tenendo conto di questi criteri di massima posso valutare, anno dopo anno e in base agli obiettivi che ho di fronte, se la mia allocation di partenza 67/33 va bene così, se sia meglio ridurre la quota azionaria perché ho degli obiettivi imprescindibili da realizzare che sono più importanti della massimizzazione del rendimento o al contrario se sia meglio aumentare la quota azionaria perché posso permettermi maggiore rischio o perché ho degli obiettivi aspirazionali che posso raggiungere solo puntando ad un maggiore rendimento atteso.
È chiaro che dal punto di vista dello Sharpe Ratio, c’è un portafoglio più efficiente e altri che lo sono meno.
Ma per quanto riguarda i miei obiettivi, io per esempio potrei voler allocare una parte del mio capitale in un’allocazione super safe, quasi cash, per mettermi al sicuro, e poi volermi prendere grandissimi rischi sapendo che se nel lungo termine va bene avrò fatto il botto, invece se non sarà andata così bene non è grave, perché il mio obiettivo di sicurezza era già al riparo mentre quello aspirazionale ne risulterà ridimensionato ma non sarà un problema grave.
Alla luce di tutto questo bel viaggio gli spunti che ne trarrei sono i seguenti:
PRIMO SPUNTO: non sprechiamo a tempo ed energie a trovare il portafoglio che “rende più”. Per la nostra felicità è meglio un portafoglio che assiste mediamente bene i nostri obiettivi, anche se non massimizza le performance o lo Sharpe Ratio.
Ricordiamoci che la matematica finanzaria suggerirebbe determinate cose, ma la nostra psicologia ne vorrebbe altre.
E alla fine noi conviviamo soprattutto con i nostri stati d’animo, non con i fogli excel.
Se ogni perdita ci costerà un dolore doppio alla soddisfazione di un guadagno, o impariamo ad anestetizzare questo bias, oppure teniamone conto per evitare di impostare un portafoglio troppo rischioso per noi che ci farà soffrire.
SECONDO SPUNTO: manteniamo un approccio pratico, riadattando periodicamente al portafoglio ai nostri obiettivi. Possiamo pensarlo come multi-strato, se vogliamo, così da immaginarsi le sue diverse porzioni destinate a diversi scopi.
Ma allo stesso non dimentichiamo che, per quanto la nostra testa ci dica il contrario, i soldi sono fungibili e contano tutti allo stesso modo.
1.000 € sono 1.000 € indipendentemente dal fatto che siano il guadagno veloce di una scommessina di trading che avete vinto o il capitale residuo di un ETF sulle energie rinnovabili in cui avete investito nel 2021 al picco e che oggi è spronfondato.
I soldi contano tutti allo stesso modo, indipendentemente dall’etichetta che gli mettete sopra.
La cosiddetta “sunk cost fallacy” ci fa pensare che certi costi o certe perdite che abbiamo subito vadano recuperate in qualche modo, solitamente provocando ulteriori costi e perdite.
In media invece conviene non considerare l’origine di ogni pezzetto del nostro capitale investito, è irrilevante se quell’euro arriva da un capital gain, mentre quell’altro è il valore residuo di un investimento in perdita.
I soldi contano tutti allo stesso modo e il portafoglio deve servire nel suo complesso gli obiettivi della nostra vita.
Quello conta che è il suo valore complessivo, non le singole parti di cui è composto, altrimenti tanto vale pensare ad un portafoglio come combinazione di asset diversificati e più o meno decorrelati.
TERZO SPUNTO: less is more.
Va bene adattare, va bene pianificare, va bene riallocare.
Ma richiamo di fare tanto lavoro per niente, perché sappiamo quanto il mercato può cambiare velocemente le carte in tavola.
Diamo massima importanza a proteggerci dai worst scenario.
Ma una volta che il nostro fondo di emergenza è a posto, l’asset allocation riflette il massimo possibile drawdown che vogliamo sopportare e in generale ha un rendimento atteso coerente con ciò che serve per realizzare i nostri obiettivi, ricordiamoci ancora una volta che, come dice sempre Nick Maggiulli, “more money are made between 9 am to 5 pm than between 9:30 am to 4 pm”. Facciamo più soldi attraverso la nostra professione e quindi grazie alla quantità risparmio che riusciamo ad investire che non grazie a quel che succede mentre le borse sono aperte.
In vent’anni di investimento, faremo più soldi versando ogni mese il doppio in un portafoglio che rende la metà, rispetto a che versando ogni mese la metà in un portafoglio che rende il doppio.
Per esempio investire mensilmente 600 € in un portafoglio che rende in media il 5% porta dopo vent’anni ad un risultato superiore (e molto più probabile) che non investire 300 € in un portafoglio che rende in media il 10%.
E dato che il rendimento non si può controllare, mentre il risparmio sì, l’1% del tempo va dedicato al portafoglio, il 99% a tutto ciò che serve per aumentare il reddito disponibile per alimentarlo.
Argomento ampio quello del goal based investing.
Oggi abbiamo abbozzato soprattutto le basi teoriche della questione, poi torneremo sicuramente nel corso dei prossimi mesi per provare a vedere qualche esempio pratico di pianificazione finanziaria basata sugli obiettivi.
Spero che quest’episodio vi sia piaciuto e che sia stato utile, ma soprattutto vi ringrazio per avermi seguito in tantissimi anche durante le vacanze di Natale, sintomo che la passione per questo incredibile mondo della finanza alla fine ha preso molti di voi tanto che lavorare sui vostri portafogli è diventato quasi più importante che fare la formazione del fantacalcio.
Restate con me anche in questo 2025 in cui ci saranno tantissime soprese che vi racconterò un po’ per volta, a partire da altri ospiti straordinari che abitano al di là dell’Atlantico che presto verranno a trovarci.
Non vi dico nulla, ma… stay tuned e presto svelerò tutto.
Nel frattempo, vi invito come sempre a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify, Apple Podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che settimana dopo settimana vi hanno insegnato a passare dallo spazzaneve a scendere in slalom speciale le piste nere della finanza sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova tappa della nostra scalata verso la vetta della consapevolezza finanziaria sempre qui naturalmente con The bull il tuo podcast di finanza personale.
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale
Anche quest’anno le festività ce le siamo lasciate alle spalle, mi auguro che abbiate fatto il pieno di panettoni e pandori — anche se da milanese per me il pandoro è come un errore dentro Matrix — e che oltre ai vostri stomaci per via degli eccessi alimentari, anche i vostri cuori si siano allargati di gioia nel tempo passati con i vostri cari.
Il mio stomaco non si è ancora ripreso — del resto, quando durante il pranzo di Natale il primo arriva in tavola alle 5 del pomeriggio, questo è un segnale inequivocabile che c’è stata un po’ di euforia irrazionale in colui che ha fatto la spesa, altro che il price earning ratio a 22 dell’S&P 500.
Però le festività Natalizie sono anche il classico momento di riflessione, uno di quei momenti in cui in qualche modo azzeriamo il contatore della nostra vita e ci ripromettiamo di partire nell’anno nuovo con qualche risoluzione destinata, almeno in teoria, a rivoltare in meglio il corso della nostra esistenza.
Se così è stato, se vi siete dati nuovi obiettivi per il 2025, cosa c’è di meglio se non un episodio dedicato a parlare di una famosa strategia di investimento chiamata appunto “Goal Based Investing”, ossia investire in base agli obiettivi?
Così come abbiamo fatto per l’episodio sul Retirement Portfolio, sul portafoglio per vivere di rendita, anche quest’episodio sarà un’introduzione al tema del Goal Based Investing, trattandosi di un ambito sconfinato e che ci richiederà di tornare più volte per inquadrarlo nelle sue diverse prospettive.
In realtà quella del Goal Based Investing è una filosofia alla base di buona parte di questo podcast, che pur parlando spesso degli aspetti più quantitativi dell’asset allocation e del comportamento delle varie asset class, nei fatti è guidato soprattutto dall’idea di adottare un approccio estremamente pragmatico alla costruzione del portafoglio.
Oggi cerchiamo di capire cosa intendo con questa cosa e come portare ad un livello successivo il modo in cui tutti noi ragioniamo per impostare nel modo migliore il nostro portafoglio NON TANTO in funzione della massimizzazione del rendimento atteso, quanto piuttosto in vista della realizzazione dei nostri obiettivi di vita.
La finanza personale ha certamente a che fare con i soldi.
Ed è pura piena di numeri, formule ed equazioni.
Ma ricordiamoci sempre che essa più che una scienza è un insieme di discipline comportamentali e decisionali che deve portarci a migliorare la nostra vita, incidendo in maniera positiva — o almeno così si spera — sulla risorsa più fungibile che abbiamo e che più di ogni altra permettere di progettare la nostra esistenza come meglio crediamo: la nostra ricchezza finanziaria.
Se sei il gestore di un fondo il tuo obiettivo quotidiano sarà prendere decisioni per costruire il portafoglio migliore dal punto di vista quantitativo. Ti interesserà lo Sharpe ratio, ti interesserà la sua volatilità, ti interesserà il suo rendimento e soprattutto ti interesserà di non fare danni per evitare che i clienti portino i soldi da un’altra parte.
Ma quando si tratta del nostro patrimonio personale, le logiche di investimento non sono esattamente le stesse di quello istituzionale.
All’investitore istituzionale interessa la massimizzazione del rendimento del portafoglio per unità di rischio assunta, mentre all’investitore individuale interesserà soprattutto realizzare i propri obiettivi di vita attraverso una crescita adeguata del patrimonio.
Per capire la differenza, direi di partire da uno dei concetti fondazionali dell’economia moderna, che è quello di “utilità marginale decrescente”, che già più volte abbiamo incontrato lungo il nostro pellegrinaggio bisettimanale.
L’idea di base è che l’utilità marginale, cioè il beneficio aggiuntivo ottenuto da un’unità supplementare di un bene o servizio tende a diminuire man mano che il consumo di quel bene o servizio aumenta.
Detta alla buona: la prima fetta di panettone con il mascarpone che mangerò a Natale sarà spaziale, mentre man mano che andrò avanti a mangiare fette aggiuntive il mio piacere e la mia soddisfazione incrementale diminuiranno.
In economia però vige questa sorta di contraddizione concettuale per cui l’agente economico — per esempio noi investitori — sarebbe interessato a massimizzare la propria utilità in senso assoluto, perché in effetti razionalmente questa è la cosa più sensata.
In realtà, se ci pensate, a noi interessa massimizzare l’utilità marginale fino al punto in cui questa diventa zero, cioè fino al punto in cui un consumo aggiuntivo non ci provoca alcun ulteriore beneficio.
Quando investiamo alla maggior parte di noi non interessa far sì che il nostro portafoglio raggiunga il più alto valore possibile.
A noi interessa che cresca fino al punto in cui la sua utilità marginale si annulla, cioè fino al punto in cui avere un euro in più non ci fa alcuna differenza.
Se io oggi avessi un portafoglio da cinque milioni di euro probabilmente il mio obiettivo non sarebbe massimizzare il rendimento atteso del mio portafoglio, ma conservare il più a lungo possibile quei 5 milioni così da finanziare tutti gli obiettivi della mia vita.
E probabilmente mi basterebbe molto meno di cinque milioni.
Poi ciascuno setta il punto dove l’utilità marginale si appiattisce dove gli pare.
Negli anni, per esempio, mi sono chiesto perché certi calciatori che guadagnavano magari 10 milioni netti all’anno litigassero con la società per avere un nuovo contratto da 12 o 15.
Cioè, ma con 10 milioni netti all’anno, ma davvero ti fanno la differenza quei 2 o 3 in più?
In fondo, senza arrivare alle superstar, un buon calciatore che gioca in una squadra che fa la Champions, nell’arco della sua carriera probabilmente oggi 20-30 milioni li porta a casa.
Con 20 milioni investiti in un portafoglio che rende il 5% all’anno puoi permetterti di spendere 50.000 euro al mese, adeguati all’inflazione, per tutta la tua vita senza mai esaurire il capitale.
Poi però mi sono ricordato due cose: la prima è che probabilmente sono gli agenti dei calciatori a spingere certe dinamiche, per interessi che poco hanno a che fare con quelli dei loro assistiti, quindi qui c’è mezza risposta.
L’altra è che più guadagni — e soprattutto più guadagni in mondi come quello — più il tuo standard di vita si alza e a quel punto la macchina bella non ti basta più, vuoi la Ferrari e la Lambo, poi vuoi lo yacht, poi vuoi l’aereo privato, poi vuoi una villa imperiale, poi vuoi un’isola intera e così via.
I soldi non bastano mai quando subentra la lifestyle inflation.
Divagazione calcistica a parte, il punto è che se siamo persone normali e non ci chiamiamo Lionel o Cristiano, noi non impostiamo il nostro portafoglio SEMPRE e SOLO per massimizzare il rendimento, ma più probabilmente per raggiungere ciò che serve a finanziare i nostri obiettivi.
Ed è sulla base di un ragionamento di questo tipo che ad un certo punto ci si è iniziati a chiedere se le teorie basate sulla massimizzazione del rendimento del portafoglio avessero senso anche per gli investitori retail o se invece non fossero più adeguate agli investitori istituzionali.
Prima di addentrarci però nel percorso che ha portato a quel che oggi sappiamo su come si fa un portafoglio, permettetemi di dirvi che anche quest’anno 4books accompagna questo podcast come suo sponsor per mettervi a disposizione oltre 1800 contenuti tra audioriassunti di libri bestseller, Podcast e corsi su temi chiave per la tua vita come investimenti, comunicazione, gestione dello stress, fitness, marketing, educazione dei figli e molti altri.
Con il link in descrizione oppure andando su www.4books.com/thebull potrete provare gratis 4books per 7 giorni e poi ricevere il 30% di sconto sull’abbonamento annuale, che sarà quindi di 69,99 € invece che 99,99.
Attenzione: ascoltare audioriassunti in 15 minuti di tutti i libri che avreste sempre voluto leggere e non avete mai avuto il tempo BARRA la voglia di prendere in mano genera dipendenza più del Trono di Spade.
Usare con cautela, l’uso eccessivo di 4books potrebbe rendere l’utente eccessivamente intelligente, acuirne pericolosamente lo spirito critico e fornirgli un minaccioso vantaggio competitivo nelle aree che più lo interessano.
Ah ovviamente il link è sponsorizzato, bla bla bla, se lo usate e vi abbonate 4books mi paga commissioni milionarie … solite cose … qua siamo avidi e non si fa niente per niente.
Dicevo: breve recap sulle origini di quei principi di base di asset allocation di cui parliamo sempre.
Prima del 1952 investire voleva dire: “individuare securities con buoni fondamentali ed un prezzo possibilmente sottovalutato che promettessero di massimizzare il ritorno sull’investimento attraverso i suoi flussi di cassa”.
Il tanto celebrato libro The Intelligent Investor di Ben Graham, il maestro di Warren Buffet, non aveva minimamente in mente che un portafoglio fosse un insieme di asset costruito in maniera tale che questi in qualche modo collaborassero tra loro.
Per lui investire era identificare società sottovalutate ed eventualmente rivenderle quando il prezzo fosse salito oltre un certo livello (e tra l’altro quest’ultimo è esattamente il punto su cui Buffet si è con successo distaccato dal maestro).
Nel 1952 invece Harry Markowitz cambia per sempre la storia della finanza con il paper “Portfolio Selection” che sancisce per convenzione la nascita della Teoria Moderna del Portafoglio, la Modern Portfolio Theory nota anche come MPT, basati sui concetti di mean-variance (cioè di media varianza), di frontiera efficiente e di rischio e rendimento.
In pratica in cosa consiste la rivoluzione di Markowitz?
Portfolio selection è in qualche modo il paper che introduce a livello definitivo il concetto di diversificazione del portafoglio.
Per Markowitz il portafoglio migliore è quello che massimizza il rendimento atteso rispetto ad un determinato livello di rischio combinando asset con una bassa co-varianza, che poi è il concetto statistico per definire la correlazione tra due asset.
Lo sappiamo bene no? Se mettiamo nel portafoglio anche una manciata di azioni americane tech non stiamo diversificando una cippa.
Se invece facciamo un portafoglio composto da azioni di diversi settori, regioni e dimensioni e di altri asset con una correlazione relativamente bassa come le obbligazioni, allora sì che abbiamo un portafoglio diversificato.
Prima di Markowitz il portafoglio migliore era quello con il miglior rendimento atteso.
Dopo Markowitz, il portafoglio migliore è quello che massimizza il rendimento rispetto al rischio assunto.
Questa idea rivoluzionaria incorpora già in parte il concetto secondo il quale cercare di ottenere un maggiore rendimento al costo di un’assunzione di rischio più che proporzionale va contro il principio di utilità marginale decrescente.
È come dire: se sono bravo a sciare e voglio divertirmi con piste più impegnative faccio quelle nere. Mentre sciare fuori pista comporta un rischio non compensato dal maggiore divertimento, perché l’upside è un po’ di adrenalina in più, il downside è che ci lasci le penne.
Quindi un portafoglio che rinuncia alla diversificazione per ottenere più rendimento comporta in media un rischio asimmetrico negativo, cioè ho più da perdere che da guadagnare.
Sull’idea di impostare un portafoglio basato sulla massimizzazione non tanto del rendimento, quanto del rapporto tra rischio e rendimento attraverso la diversificazione, si basa fondamentalmente la finanza moderna.
Il contributo decisivo al modello di Markowitz lo diede il suo allievo — e anche lui futuro premio Nobel — William Sharpe, che noi qui conosciamo tutti molto bene perché fu colui che elaborò il Capital Asset pricing Model e naturalmente lo Sharpe Ratio.
Sharpe fu colui che per primo formalizzò alcune delle idee che sono diventate dei pilastri di tutta la filosofia dell’investimento passivo di cui tanto parliamo qui.
Intanto introdusse il concetto di rischio sistematico, espresso attraverso il famoso BETA. Vi ricordate?
Il rendimento di un portafoglio è dato dal rendimento del mercato di riferimento meno il risk-free-rate moltiplicato appunto per BETA, che è questo valore maggiore o minore di 1 che esprime appunto la sensibilità del rendimento del portafoglio rispetto ai movimenti del mercato.
Per CAPM il rischio specifico non viene contemplato, nella misura in cui questo può essere sempre diversificato.
Nella sua versione estrema, il CAPM dice: il rendimento del tuo portafoglio, nella misura in cui è diversificato in maniera efficiente, è una funzione del BETA, ossia del rischio sistematico che si assume.
In realtà poi sappiamo che Beta non è sufficiente a render conto di tutto e infatti negli anni ’90 Eugene Fama e Ken French formalizzano i fattori Value, Small Caps, Profitability e Investment, mentre Jeegadesh e Titman introdussero il momentum, che effettivamente spiegavano una buona parte di quelle situazioni in cui l’extra rendimento sistematico non di un portafoglio non sembrava potesse essere ricondotto esclusivamente al fatto di avere un maggior Beta.
L’altro concetto fondamentale introdotto da Sharpe fu chiamato inizialmente Reward to Variability Ratio, nel 1966.
Il nome però ebbe poco successo e nel 1994 fu Sharpe stesso a chiamarlo Sharpe Ratio e da lì divenne Sharpe Ratio per tutti.
Lo Sharpe Ratio è la misura ufficiale del rapporto tra rischio e rendimento di un portafoglio.
L’indice di Sharpe è calcolato come Rendimento in eccesso del portafoglio rispetto al risk free rate diviso la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
Maggiore è il valore, maggiore è l’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento.
Poi qua non ci addentriamo in tutti i limiti dello Sharpe Ratio, che ovviamente come tutti i modelli è imperfetto per definizione, ma rappresenta se non altro un modo coerente per confrontare diversi portafogli tra loro con un criterio chiaro.
Rischio però, per Markowitz, Sharpe e per tutta la finanza classica, è appunto espresso come varianza, cioè come volatilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio di un asset e per motivi di praticità matematica, solitamente si usa la sua radice quadrata, che come tutti voi ben sapete si chiama deviazione standard.
Il rischio finanziario è quindi quanto si discosta il rendimento di un asset dal suo rendimento atteso, cioè dal suo rendimento medio, in un certo tempo.
Noi tutti sappiamo che, in linea di principio, i rendimenti tendono a regredire verso la loro media storica, quindi teoricamente il rischio finanziario inteso come volatilità si riduce man mano che l’orizzonte temporale si allunga.
Ora, per l’investitore istituzionale, la definizione di rischio come deviazione standard può anche andare bene per i suoi scopi ed effettivamente, giusta o sbagliata, è una misura oggettiva del rischio.
Però qui per noi investitori privati cominciano una serie di problemi.
PROBLEMA UNO: la deviazione standard presuppone che i rendimenti di un investimento siano distribuiti normalmente, cioè devono seguire la forma a campana della curva di Gauss.
Se simulate milioni di lanci di testa o croce avremo situazioni estreme con tante teste o tante croci consecutive mentre 2/3 delle simulazioni saranno concentrate attorno al centro, dove teoricamente si trova la situazione ideale di metà teste e metà croci.
Allo stesso modo sono distribuiti normalmente le altezze o i pesi degli esseri umani, dove pochissimi maschi adulti peseranno 300 kg o 30 kg mentre 2/3 si collocheranno intorno al valore medio che sarà, boh, 70-80 kg suppongo.
E così via.
I fatti della finanza invece non sono distribuiti normalmente, perché come si dice hanno “fat tail”, hanno code grasse, cioè gli eventi rari accadono più spesso di quel che la statistica prevedrebbe.
Infatti per esempio Nassim Taleb contesta pesantemente l’uso della statistica Gaussiana in finanza, preferendo altri modelli come ad esempio quello di Pareto, delle leggi di potenza e della distribuzione frattale dei rendimenti, utilizzati dal suo mito, genio della matematica e della finanza, Benoit Mandelbrot.
Al di là del dibattito accademico, il primo problema per noi investitori è che possiamo fare tutte le stime di questo mondo usando i rendimenti attesi e la loro varianza, ma UNO: i rendimenti attesi sono una stima che sì converge verso la media, ma resta pur sempre una stima e DUE: il rischio come varianza per noi è pericoloso perché in effetti potrebbero capitare cose molto più brutte di quel che i modelli descrivono, proprio perché in finanza capitano eventi rari e imprevedibili più spesso di quel che dovrebbero.
Quindi se noi facciamo tutta la nostra bella pianificazione e ci assumiamo un certo rischio come se le leggi della probabilità valessero tout court, ecco potremmo avere brutte sorprese.
E questo è il primo problema.
In media più o meno tutta la finanza classica ci prende, ma nel caso singolo rischio di farmi più male di quel che il modello aveva previsto.
Il PROBLEMA NUMERO DUE riguarda invece delle nostre deformazioni cognitive.
Kahneman e Tversky avevano scoperto, tra i vari, uno dei bias più importanti e gravi per un investitore, cioè il loss aversion, l’avversione alle perdite.
I due aveano dimostrato che a noi fa bruciare più il didietro perdere 100 poi ho bisogno in media di guadagnarne 200 per essere emotivamente in pari.
La Modern Portfolio Theory, il CAPM e la Efficient Market Hypothesis, che naturalmente è una conseguenza di questa linea di pensiero, non contemplano i bias degli investitori.
Eppure, efficiente o no che sia, poi quando prendiamo decisioni per il nostro portafoglio dobbiamo tenere conto del fatto che una perdita ci farà più male di un guadagno e quindi anche se razionalmente sarebbe meglio un certo portafoglio, a me singolo individuo bacato potrebbe andar meglio un portafoglio meno efficiente ma che mi fa stare meglio.
Richard Thaler poi negli anni ’80 introdusse il concetto di Mental Accounting, di contabilità mentale.
E questa roba è un altro bel problema per la finanza classica, che parte dal presupposto che il denaro sia fungibile, cioè 100 , a prescindere da come li hai guadagnati, da come li hai persi, dallo scopo che hanno e in generale dal significato che gli attribuisci.
Invece gli esseri umani, in media, non trattano il denaro come fungibile, ma gli attribuiscono etichette e valori differenti a seconda delle circostanze.
Se con fatica porto a casa determinati soldi con il mio duro lavoro, quei soldi li tratterò diversamente da quelli che invece potrei vincere in una scommessa o che potrei ricevere da un’eredità.
Razionalmente questa cosa non ha senso, ma sapete tutti bene che noi ragioniamo e agiamo così.
E quindi qual è il problema nella costruzione del portafoglio?
Il problema è che la finanza classica dice: costruisci il portafoglio che massimizza il rendimento per un certo livello di rischio.
Il singolo individuo invece tende ad assegnare ai vari pezzi del proprio capitale significati diversi in base allo scopo a cui sono destinati.
E questo per la finanza classica è completamente inefficiente.
Negli anni ’40 però Abrahm Maslow aveva introdotto la teoria della gerarchia dei bisogni umani, sostenendo che istintivamente l’uomo fosse portato a soddisfare PRIMA i bisogni primari fisiologici e di sicurezza e POI via via si muovesse verso quelli di autorealizzazione.
Riprendendo quest’idea, qualcuno ha cominciato a pensare a modelli alternativi di costruzione del portafoglio che rispondessero a questa gerarchia di bisogni che tutti noi ci portiamo dietro fin da quando nasciamo.
Se sono 174 episodi che vado predicando: “mi raccomando, PRIMA il fondo di emergenza che se succede qualcosa poi sono cazzi, e POI solo a quel punto investiamo come se non ci fosse un domani” è proprio perché “safety first”, la sicurezza prima di tutto e poi puntiamo alla libertà finanziaria.
Potete facilmente immaginare quanto ami Eugene Fama, l’idea dei mercati efficienti e tutto l’impianto della finanza classica, soprattutto dopo che è venuto da me nel podcast, però come essere umano in effetti per me la sicurezza e la pace psicologica pesano di più dello Sharpe Ratio e questo potrebbe portarmi a prendere decisioni meno efficienti.
Perché poi il grosso della distanza che separa il modello dei portafogli efficienti adatto agli investitori istituzionali da ciò che serve all’investitore privato è esattamente come definiamo il RISCHIO.
Per la finanza classica, il RISCHIO è la varianza dei rendimenti, la volatilità, la deviazione standard.
Per me singolo investitore, il RISCHIO è quello di non realizzare i miei obiettivi.
Io investo per uno scopo — o per più scopi.
Diventare ricco, proteggermi dall’inflazione, mandare i miei figli all’università, comprare la villa dei miei sogni, vivere di rendita, quello che vogliamo.
In quest’ottica, sticazzi la deviazione standard.
Il mio rischio più grande non è avere un portafoglio non efficiente.
Il mio rischio più grande è non realizzare gli obiettivi che danno un senso alla mia vita.
Ci sono stati tanti lavori di accademici e professionisti che hanno provato a sanare la questione.
Tra questi ci sono forse 3 passaggi decisivi.
Il primo è stato il lavoro di Shefrin e Statman, che hanno sviluppato la Behavioral Portfolio Theory, BPT.
La BPT, invece basarsi sull’idea di rischio come varianza suggerisce che il rischio sia la probabilità di non realizzare un certo rendimento minimo necessario per soddisfare un determinato obiettivo.
Cioè il rischio non è la deviazione standard dei rendimenti.
Il rischio è non realizzare il tuo goal.
Mentre negli anni ’50 Markowitz elaborava la MPT, un altro accademico di nome Andrew Roy formulò il concetto di Safety-First criterion, cioè il criterio “la sicurezza prima di tutto”.
Questa formula in pratica dice quanto è probabile che un certo portafoglio ci permetta di realizzare un determinato rendimento minimo.
Fate attenzione perché è interessante.
La formula è molto semplice:
– Rendimento atteso del portafoglio MENO
– Rendimento minimo che voglio ottenere DIVISO
– Deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
In base a questo criterio io non sceglierò tra due portafogli NÉ quello che ha il rendimento atteso maggiore, NÉ quello con il rapporto tra rischio e rendimento maggiore, lo Sharpe Ratio. Bensì quello che mi dà la maggiore probabilità di centrare l’obiettivo minimo.
Facciamo un esempio.
Prendiamo 3 portafogli:
– 100% MSCI World
– 60% MSCI world e 40% Obbligazioni governative globali e
– 40% MSCI world e 60% Obbligazioni governative globali
Ammettiamo che il rendimento atteso dei 3 portafogli sia rispettivamente 8% all’anno, 6% e 5% e che la loro deviazione standard sia 15%, 8,5% e 7,5%.
Ammettiamo inoltre che io voglia ottenere un rendimento minimo di almeno 3% all’anno.
Qual è il portafoglio migliore?
Secondo il Safety First Criterion le mie migliori chance sono con il portafoglio 60/40.
Se invece il mio obiettivo minimo fosse 4%, allora sarebbe il portafoglio 100% azionario a massimizzare le probabilità di successo.
Il Safty First Criterion è in qualche modo un’alternativa allo Sharpe Ratio e ha anche una forma simile, solo che invece che fare rendimento atteso meno risk free rate diviso deviazione standard, fa rendimento atteso meno rendimento minimo, diviso deviazione standard.
Mentre lo Sharpe ratio dà il portafoglio più efficiente, il criterio di Roy dà il portafoglio teoricamente più robusto per il mio obiettivo minimo.
Ora, è chiaro che anche qui ci sono delle limitazioni che sono un po’ sempre le stesse:
– Il rendimento atteso è una stima molto complicata da fare; e
– La deviazione standard ha le problematiche statistiche di cui abbiamo parlato.
Nel 2000 Hersh Shefrin e Meir Statman scrissero un paper dal titolo Behavioral Portfolio Theory in cui provarono a elaborare un’alternativa al modello di MArkowtiz introducendo il criterio di Roy.
Il punto di partenza era il cosiddetto paradosso di Friedman e Savage, che nel 1948 osservarono che razionalmente non avesse senso che le persone acquistassero sia le assicurazioni che i biglietti della lotteria, cosa che invece è comprensibile con l’idea di Mental Accounting.
Secondo Shefrin e Statman il modello di Markowitz è “inconsistent”, è incoerente e inconciliabile con questo paradosso e formularono un modello alternativo che in pratica porta a costruire portafogli a due strati, dove lo strato inferiore risponde all’idea di soddisfare il primario bisogno di sicurezza e di non finire poveri mentre quello superiore è finalizzato al piano aspirazionale, cioè a realizzare obiettivi che per noi sono desiderabili ma non vitali.
Nel 2010 poi Statman, Markowitz stesso e altri due produssero un lavoro dal titolo Portfolio Optimization with Mental Accounts e cercarono, come dire di mettere insieme le forze e unire la Modern Portfolio Theory con la Behavioral Portfolio Theory.
Per farla breve, nello studio si è cercato di creare un framework, cioè un modello di costruzione del portafoglio, composto da tre elementi:
– L’idea che il portafoglio abbia più strati destinati a diversi scopi;
– Una definizione di rischio come probabilità di non raggiungere un certo livello minimo di rendimento in ciascun account mentale, cioè in ciascuno strato del portafoglio e infine
– Una propensione al rischio diversa per ciascuno strato.
La soluzione, detta alla buona, sarebbe che l’investitore sceglie la massima probabilità di fallimento che è disposto ad accettare per ciascuno strato del portafoglio e quella probabilità viene tradotta in un determinato livello di avversione al rischio. A quel punto subentra il modello di Markowitz per impostare i diversi strati del portafoglio usando quel livello come soglia di rischio rispetto al quale costruire un portafoglio efficiente che massimizza il rendimento atteso.
Cioè il portafoglio efficiente non sarebbe più quello che massimizza il rendimento per un determinato livello di varianza, bensì per un determinato livello di rischio definito come probabilità massima accettabile di non realizzare un certo rendimento minimo.
Sulla scorta di questi lavori sarebbe poi nato il Goal Based Investing, che forse ha la sua espressione più strutturata nel libro di Jean Brunel dal titolo “Goal Based Wealth Management”, del 2015.
Rispetto al modello della finanza classica, l’investimento per obiettivi si basa su questi 4 presupposti:
– Raggiungere obiettivi personali;
– Il rischio è definito come probabilità di non raggiungere il rendimento minimo necessario;
– Il portafoglio ha più strati, ossia ha diverse allocation per ciascun obiettivo, chiamato Bucket, cioè per ogni obiettivo ci sarebbe metaforicamente un cestino dedicato, un conto mentale separato per ogni scopo;
– E infine tiene conto dei bias comportamentali.
Ovviamente questo modello non è esente da limiti.
– Intanto elaborare diversi sottoportafogli richiede un lavoro più complesso e più manutenzione rispetto ad un portafoglio buy and hold;
– In secondo luogo, non è banale stimare la probabilità di fallimento che sono disposto ad accettare rispetto ad un rendimento minimo necessario per un mio obiettivo, così come il rendimento atteso e la volatilità futura restano delle stime;
– Infine, per quanto sembri ovvio il contrario, in realtà è molto difficile sapere con grande anticipo quali saranno i miei obiettivi futuri:
– Oggi potrei pensare che tra 18 anni mi figlia andrà all’università, ma magari non vorrà farla;
– Oppure penso che tra 10 anni vorrò cambiare casa — e invece ciò potrebbe accadere tra 5 o mai;
– Per non parlare poi delle grandi incognite della vita, a volte molto belle, a volte molto brutte, che in un secondo possono stravolgere la migliore delle pianificazioni.
Se ci pensate, l’approccio che ho sempre suggerito in questo podcast e nel mio libro si basa più su questo approccio pragmatico e goal-based, che non sull’idea della finanza classica, che va benissimo per il gestore istituzionale, ma ha poco senso per quello privato.
Però non è così rigido da pensare al portafoglio in termini di “Bucket”, di singoli comparti in cui pezzi del portafoglio sono destinati a specifici obiettivi.
L’idea è piuttosto quella di costruire un’asset allocation flessibile e riadattarla periodicamente in base a come mutano le esigenze della vita.
Prendiamo il solito metodo che parte dalla formula di The Bull e che ho descritto nel dettaglio anche nel mio libro.
L’idea di partenza è certamente molto Markowitz, Sharpe, Fama: azioni e obbligazioni, replicando il mercato.
La percentuale di azioni di partenza può essere calcolata come 125 — i propri anni — il risk free rate * 5, almeno nella fase di accumulo, poi nella fase di Retirement è un altro discorso, come avevamo detto nell’episodio 169.
Facciamo il mio caso, ho 38 anni, il risk free rate in America è circa 4 virgola qualcosa %, Europa circa 3, facciamo 4 per semplicità e perché siamo più esposti agli Stati Uniti che all’Europa.
125 — 38 — 4*5 20 fa 67% azioni e 33% obbligazioni.
Però poi a questo punto però subentra l’idea semi “Goal based” diciamo così di adattare l’allocation a due cose:
– Ai miei obiettivi di vita e
– Alla mia tolleranza al rischio.
Il consiglio è proiettare la crescita del portafoglio nel tempo e verificare nelle varie fasi future della mia vita come cresceranno la parte azionaria ma soprattutto quella obbligazionaria e adattare il portafoglio di conseguenza.
Sappiamo che in ogni momento la parte azionaria potrebbe perdere tranquillamente il 50% del suo valore, mentre la parte obbligazionaria sarà mediamente più stabile.
Ok nel 22 le obbligazioni sono sprofondate, ma oggi i tassi sono al 3% e non a zero e se in futuro torneranno a zero chi ha ascoltato The Bull saprà già che riempirsi di obbligazioni a medio lungo termine con tassi molto bassi sarebbe un suicidio finanziario.
Tenendo conto di questi criteri di massima posso valutare, anno dopo anno e in base agli obiettivi che ho di fronte, se la mia allocation di partenza 67/33 va bene così, se sia meglio ridurre la quota azionaria perché ho degli obiettivi imprescindibili da realizzare che sono più importanti della massimizzazione del rendimento o al contrario se sia meglio aumentare la quota azionaria perché posso permettermi maggiore rischio o perché ho degli obiettivi aspirazionali che posso raggiungere solo puntando ad un maggiore rendimento atteso.
È chiaro che dal punto di vista dello Sharpe Ratio, c’è un portafoglio più efficiente e altri che lo sono meno.
Ma per quanto riguarda i miei obiettivi, io per esempio potrei voler allocare una parte del mio capitale in un’allocazione super safe, quasi cash, per mettermi al sicuro, e poi volermi prendere grandissimi rischi sapendo che se nel lungo termine va bene avrò fatto il botto, invece se non sarà andata così bene non è grave, perché il mio obiettivo di sicurezza era già al riparo mentre quello aspirazionale ne risulterà ridimensionato ma non sarà un problema grave.
Alla luce di tutto questo bel viaggio gli spunti che ne trarrei sono i seguenti:
PRIMO SPUNTO: non sprechiamo a tempo ed energie a trovare il portafoglio che “rende più”. Per la nostra felicità è meglio un portafoglio che assiste mediamente bene i nostri obiettivi, anche se non massimizza le performance o lo Sharpe Ratio.
Ricordiamoci che la matematica finanzaria suggerirebbe determinate cose, ma la nostra psicologia ne vorrebbe altre.
E alla fine noi conviviamo soprattutto con i nostri stati d’animo, non con i fogli excel.
Se ogni perdita ci costerà un dolore doppio alla soddisfazione di un guadagno, o impariamo ad anestetizzare questo bias, oppure teniamone conto per evitare di impostare un portafoglio troppo rischioso per noi che ci farà soffrire.
SECONDO SPUNTO: manteniamo un approccio pratico, riadattando periodicamente al portafoglio ai nostri obiettivi. Possiamo pensarlo come multi-strato, se vogliamo, così da immaginarsi le sue diverse porzioni destinate a diversi scopi.
Ma allo stesso non dimentichiamo che, per quanto la nostra testa ci dica il contrario, i soldi sono fungibili e contano tutti allo stesso modo.
1.000 € sono 1.000 € indipendentemente dal fatto che siano il guadagno veloce di una scommessina di trading che avete vinto o il capitale residuo di un ETF sulle energie rinnovabili in cui avete investito nel 2021 al picco e che oggi è spronfondato.
I soldi contano tutti allo stesso modo, indipendentemente dall’etichetta che gli mettete sopra.
La cosiddetta “sunk cost fallacy” ci fa pensare che certi costi o certe perdite che abbiamo subito vadano recuperate in qualche modo, solitamente provocando ulteriori costi e perdite.
In media invece conviene non considerare l’origine di ogni pezzetto del nostro capitale investito, è irrilevante se quell’euro arriva da un capital gain, mentre quell’altro è il valore residuo di un investimento in perdita.
I soldi contano tutti allo stesso modo e il portafoglio deve servire nel suo complesso gli obiettivi della nostra vita.
Quello conta che è il suo valore complessivo, non le singole parti di cui è composto, altrimenti tanto vale pensare ad un portafoglio come combinazione di asset diversificati e più o meno decorrelati.
TERZO SPUNTO: less is more.
Va bene adattare, va bene pianificare, va bene riallocare.
Ma richiamo di fare tanto lavoro per niente, perché sappiamo quanto il mercato può cambiare velocemente le carte in tavola.
Diamo massima importanza a proteggerci dai worst scenario.
Ma una volta che il nostro fondo di emergenza è a posto, l’asset allocation riflette il massimo possibile drawdown che vogliamo sopportare e in generale ha un rendimento atteso coerente con ciò che serve per realizzare i nostri obiettivi, ricordiamoci ancora una volta che, come dice sempre Nick Maggiulli, “more money are made between 9 am to 5 pm than between 9:30 am to 4 pm”. Facciamo più soldi attraverso la nostra professione e quindi grazie alla quantità risparmio che riusciamo ad investire che non grazie a quel che succede mentre le borse sono aperte.
In vent’anni di investimento, faremo più soldi versando ogni mese il doppio in un portafoglio che rende la metà, rispetto a che versando ogni mese la metà in un portafoglio che rende il doppio.
Per esempio investire mensilmente 600 € in un portafoglio che rende in media il 5% porta dopo vent’anni ad un risultato superiore (e molto più probabile) che non investire 300 € in un portafoglio che rende in media il 10%.
E dato che il rendimento non si può controllare, mentre il risparmio sì, l’1% del tempo va dedicato al portafoglio, il 99% a tutto ciò che serve per aumentare il reddito disponibile per alimentarlo.
Argomento ampio quello del goal based investing.
Oggi abbiamo abbozzato soprattutto le basi teoriche della questione, poi torneremo sicuramente nel corso dei prossimi mesi per provare a vedere qualche esempio pratico di pianificazione finanziaria basata sugli obiettivi.
Spero che quest’episodio vi sia piaciuto e che sia stato utile, ma soprattutto vi ringrazio per avermi seguito in tantissimi anche durante le vacanze di Natale, sintomo che la passione per questo incredibile mondo della finanza alla fine ha preso molti di voi tanto che lavorare sui vostri portafogli è diventato quasi più importante che fare la formazione del fantacalcio.
Restate con me anche in questo 2025 in cui ci saranno tantissime soprese che vi racconterò un po’ per volta, a partire da altri ospiti straordinari che abitano al di là dell’Atlantico che presto verranno a trovarci.
Non vi dico nulla, ma… stay tuned e presto svelerò tutto.
Nel frattempo, vi invito come sempre a mettere segui e attivare le notifiche su Spotify, Apple Podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che settimana dopo settimana vi hanno insegnato a passare dallo spazzaneve a scendere in slalom speciale le piste nere della finanza sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova tappa della nostra scalata verso la vetta della consapevolezza finanziaria sempre qui naturalmente con The bull il tuo podcast di finanza personale.
Recensioni
Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!
Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.
Andrea V., 22 Set 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai
Francesca B., 6 Apr 2024Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.
Giulia N., 11 Ago 2025Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva
Gianluca G., 11 Set 2025Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai
Matteo C., 3 Set 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!
Massimiliano, 29 Mag 2024Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!
Giorgia R., 23 Gen 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!
Luca G. 10 Ott 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente
Amalia A., 17 Set 2025












