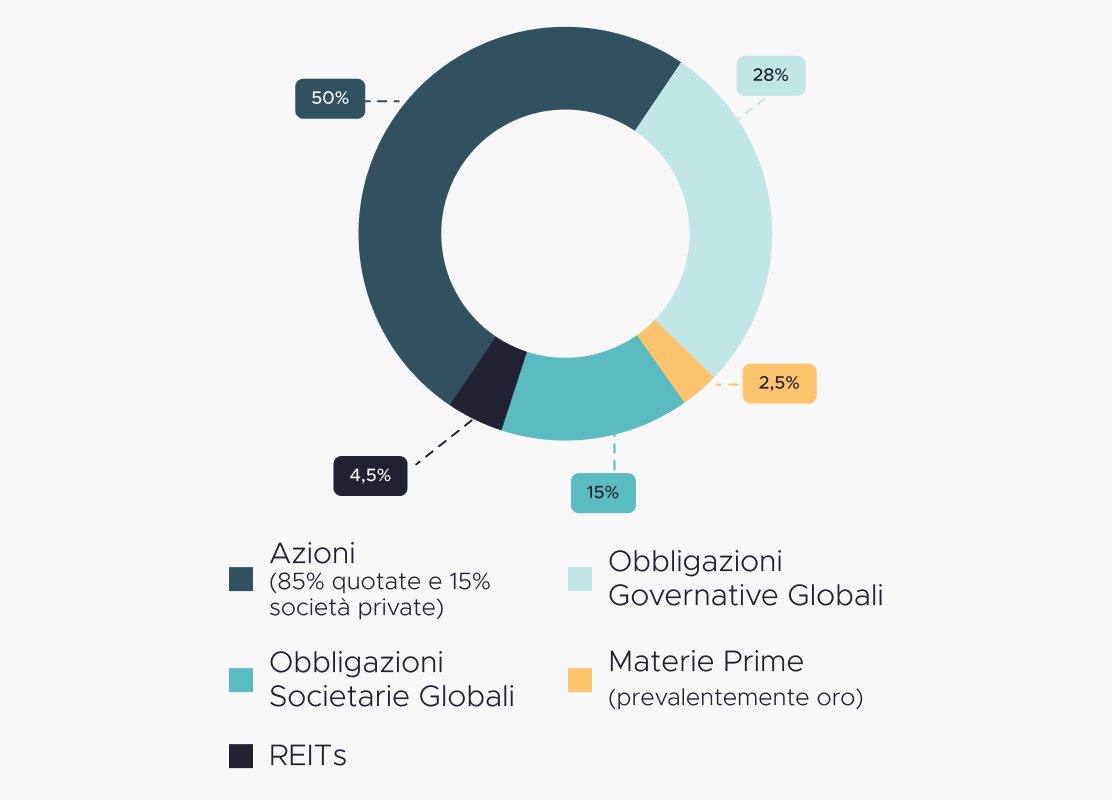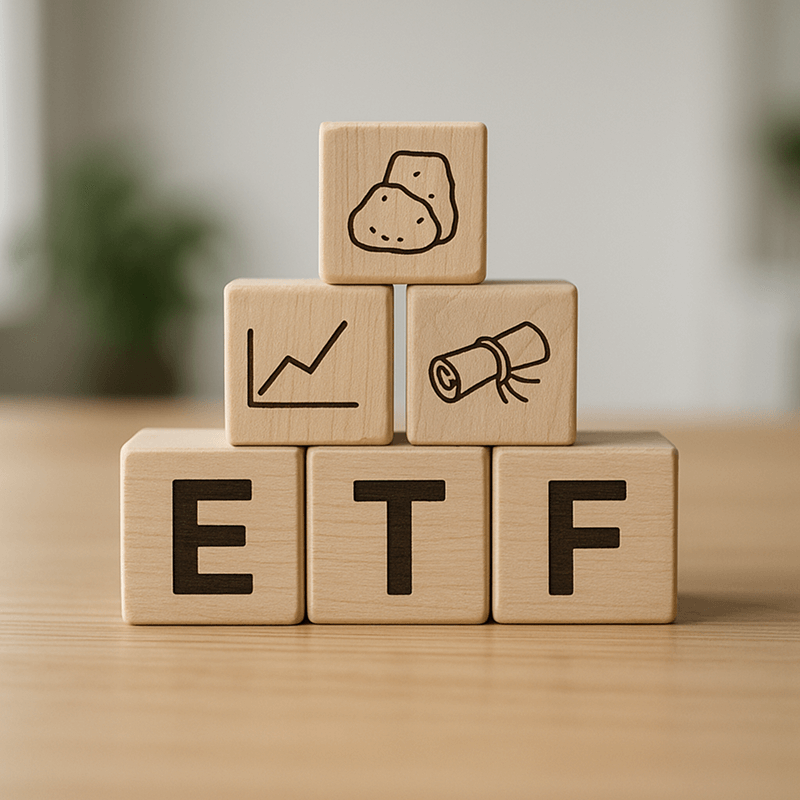4 principi per diventare un investitore migliore
In questo episodio di The Bull, scopriamo i 4 principi fondamentali che possono cambiare il tuo modo di investire, raccontati attraverso gli aforismi di Morgan Housel, autore di The Psychology of Money. Dalle previsioni impossibili alla regressione verso la media, fino all’importanza di ottimismo e semplicità negli investimenti: un viaggio tra lezioni di finanza e filosofia per migliorare la propria mentalità da investitore.

264. 4 principi per diventare un investitore migliore
Risorse
Punti Chiave
La guida ai mercati più bella che esista
Capitolo 1: l’assurdità delle previsioni
Capitolo 2: la regressione verso la media
Capitolo 3: il pessimismo vince le battaglie. l’ottimismo vince le guerre
Capitolo 4: negli investimenti la semplicità batte la complessità
Trascrizione Episodio
Bentornati a The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Intanto con questo episodio ho già battuto ogni record con il titolo più lungo di tutti i tempi che sicuramente YouTube mi segnerà.
Però il concetto che volevo esprimere era questo: mi sono imbattuto in una raccolta di decine e decine di aforismi dello straordinario e immenso Morgan Housel, autore tra gli altri del best seller galattico multi mega milionario The Psychology of Money, ciascuno dei quali avrebbe meritato un episodio a sé.
Ma non volevo neanche allungare il brodo – in fondo la potenza degli aforismi è proprio quella di trasmettere dei contenuti complessi in forma semplice, imprimendoli nel nostro cervello in maniera indelebile, e possibilmente trasformando il nostro sistema di convinzioni e comportamenti.
La storia è costellata di personaggi straordinari a cui vengono attribuite – più o meno correttamente – delle frasi leggendarie, depositarie di una saggezza universale che aspettavano solo che una mente brillante le mettesse in parole in maniera incisiva: Seneca, Oscar Wilde, Mark Twain, Winston Churchill sono solo alcuni dei più noti e prolifici produttori di aforismi memorabili, tanto più potenti ed efficaci, quanto più sintetici ed evocativi.
Ma il più grande di tutti, è uno soltanto, per distanza siderale rispetto a chiunque altro per la totale inconsapevolezza con cui regalò al mondo delle perle imperiture.
Lo scoprii anni fa leggendo i libri di Nassim Taleb, che affiancò il suo genio a quello di Karl Popper, Friedrich von Hayek e Benoit Mandelbrot.
Stiamo parlando del leggendario giocatore e poi allenatore dei New York Yankees: Yogi Berra.
Le mi 5 preferite di tutti i tempi:
“Non è finita finché non è finita.”
“Partecipa sempre ai funerali degli altri; altrimenti loro non verranno al tuo.”
“Se non sai dove stai andando, potresti finire da un’altra parte.”
“Il futuro non è più quello di una volta.”
E per concludere la frase più bella del mondo, che con il suo evidente paradosso logico esprime in realtà una verità esistenziale che spesso dimentichiamo e che se invece incorporassimo nel sistema dei nostri principi guida, beh, vivremo tutti molto meglio.
“Se il mondo fosse perfetto, non lo sarebbe.”
Rest in peace Yogi.
Morgan Housel non è all’altezza di Yogi Berra, probabilmente perché i suoi aforismi li pensa e li sviluppa intenzionalmente.
La spontanea e ingenua inconsapevolezza di Berra invece non ce l’ha nessun altro.
Però quando si tratta di finanza personale, beh, Housel, resta comunque il mio preferito.
Ok a volte semplifica un po’ troppo e non è davvero un esperto di finanza duro e puro.
Ma la straordinaria capacità con cui riesce a mettere a terra concetti complessi con 10 parole è una cosa che gli invidio parecchio.
Forse perché io invece sono un po’ logorroico.
Allora ho pensato di fare questa cosa.
Negli ultimi episodi abbiamo visto: equazioni, descrizioni matematiche delle dinamiche dei mercati, paper, report, grafici, dati e tutta roba che – insomma – secondo me super super super interessante, ma non troppo rilassante per il cervello.
Oggi invece mettetevi comodi che in questo episodio ci portiamo a casa due obiettivi:
Il PRIMO è mettere insieme quattro principi guida che tocchiamo spesso, ma che chiaramente nella forma data dagli aforismi di Housel hanno tutt’un altro impatto. Come dire: i concetti probabilmente vi saranno in parte noti, ma credo che il modo in cui housel li mette giù possa portare una diversa consapevolezza e modificare parzialmente il nostro sguardo su questi temi.
Il SECONDO è ancora più importante. Cioè ma avete presente quanto sembrate smart quando state facendo una discussione di finanza con qualcuno che non ci capisce un cazzo, che per spiegargli le cose dovreste star lì tre ore dirgli tutto e invece – sbam! – frase ad effetto di 5 secondi, mic drop, game, set, match, tutti a casa e nessuno si azzardi più a dibattere di finanza con gli ascoltatori di The Bull che sanno le cose sia in versione lunga che in versione bacio perugina.
Allora come sarà strutturato l’episodio.
Girerà intorno a 4 concetti principali, che sono:
L’assurdità delle PREVISIONI
La REGRESSIONE VERSO LA MEDIA
L’OTTIMISMO come prerequisito anche solo per partecipare a questo gioco e infine
La SUPERIORITA’ della Semplicità nell’investimento
Per ciascuno di questi principi guida commenteremo una manciata tra gli aforismi di Housel che secondo me rendono molto bene il concetto.
A conclusione di ogni blocco, cercherò di formulare una sintesi unificante.
Pronti?
Cominciamo.
SPONSOR FINECO
[mettere una dissolvenza]
[Capitolo UNO: L’assurdità delle previsioni]
Capitolo UNO: L’assurdità delle previsioni.
1° aforisma:
La storia è guidata da eventi sorprendenti mentre le previsioni sono guidate da eventi ovvi.
Se ci pensate questo è uno dei vari paradossi legati alla nostra indispensabile esigenza di provare a prevedere il futuro e all’irrazionalità a cui ci attacchiamo in questo vano tentativo.
La crisi del 29, lo shock petrolifero degli anni ’70, il 19 ottobre del 1987, l’11/9, il fallimento di Lehman Brothers, il Covid e una miriade di altri eventi dirompenti che hanno avuto un impatto massivo sul corso della storia dei mercati – e della storia in generale se vogliamo – sono stati dei Cigni Neri, eventi non previsti al tempo e con impatto su larga scala.
E quindi il paradosso è: ma se i grandi snodi della storia sono stati determinati da eventi che non potevano essere previsti, qual è il punto di fare stime sul futuro come se il futuro fosse fatto da eventi largamente prevedibili?
2° aforisma:
Ogni valutazione del mercato è un numero di oggi moltiplicato per una storia sul domani.
Avete presente quando spiego come è composto il rendimento di un asset finanziario?
Ecco la versione difficile è questa:
Da cosa è composto il rendimento di un titolo di stato decennale?
Da tre cose:
Inflazione attesa
Aspettativa sui tassi reali a breve termine e
Premio al rischio per la duration.
Per fare un esempio con i nostri BTP:
L’inflazione attesa è leggermente sotto al 2%
L’aspettativa sui tassi reali, cioè tassi della BCE meno inflazione, è circa 0,2%
Mentre infine il premio al rischio è grossomodo 1,6%
Il totale dà il rendimento sul decennale.
Per chi sta vedendo il video il grafico che è comparso è preso dall’8° capitolo della serie di Antti Ilmanen, Understanding Return Expectation, forse la cosa più bella in cui mi sono imbattuto da quanto consumo più articoli di finanza che carboidrati.
Invece da cosa è composto il rendimento azionario?
Anche qui da tre cose:
Dal rendimento da dividendo, cioè dividendi diviso prezzo;
Dalla crescita (o decrescita) degli utili per azione e infine
Dalla variazione del rapporto tra prezzo e utili:
Quando aumenta c’è generalmente una maggior fiducia e una minore percezione del rischio futuro;
Quando diminuisce c’è invece maggior sfiducia e maggiore percezione del rischio futuro.
Vedete che i prezzi di un asset che oggi vediamo sul mercato e a cui oggi compriamo sono composti da un elemento più o meno oggettivo: i tassi di interesse e l’inflazione di oggi per i bond, utili e dividendi per le azioni, e da un elemento soggettivo: le aspettative sull’inflazione, sul rischio e sulla crescita futura.
In parole tecniche, la decomposizione dei rendimenti è questa.
Ma per arrivare dritto al punto, Housel ha ragione al 100%: i prezzi che osserviamo ogni giorno sulla nostra app di market watch preferita sono esattamente un numero di oggi moltiplicato per una storia sul domani.
Quali sono oggi le due grandi storie principali:
Per le obbligazioni, direi principalmente le paure sulla sostenibilità dei debiti pubblici, parzialmente limate dalla convinzione che i governi applicheranno “ dominance”, repressione fiscale, per contenere i rendimenti;
Per le azioni, ovviamente, la grande storia è l’intelligenza artificiale.
3° aforisma:
Circa una volta ogni decennio la gente si dimentica che le bolle si formano e scoppiano circa una volta ogni decennio.
Beh, questa è poesia.
Solo per prendere la storia recente:
1988-1999: formazione della grande bolla di internet;
2000-2002: conflagrazione della grande bolla di internet;
1995-2006: formazione della grande bolla immobiliare;
2007-2009: conflagrazione della grande bolla immobiliare;
2010-2021: formazione della grande bolla dei tassi a zero, delle meme stock, del private equity, degli SPAC, delle IPO di società sgangherate, ICO, NFT, shitcoin, insomma tutte quelle follie che abbiamo visto soprattutto nell’anno successivo al covid;
2022: conflagrazione della bolla del denaro gratis e ritorno alla realtà, fatto di inflazione, tassi di interesse più elevati e tutto quel che sapete.
Nel 2022 è anche nato ChatGPT.
Chissà, magari abbiamo ancora 6-7 anni prima che la bolla si gonfi del tutto.
Però Housel coglie perfettamente il punto ancora una volta.
Veniamo continuamente colti di sorpresa da dinamiche che invece sono sorprendentemente ripetitive.
E vedremo che questo tema, in altre salse e da altre prospettive, ritornerà più volte nell’episodio di oggi.
4° e ultimo aforisma sul tema previsioni:
Ogni crollo del passato oggi lo vediamo come un’opportunità mentre ogni crollo futuro lo vediamo come un rischio.
L’ho messo nella categoria previsioni, anche se forse ha più a che fare con il nostro bipolarismo quando investiamo governati più dalla pancia che dalla testa.
Però ha certamente a che fare anche con il modo in cui le nostre previsioni bacate condizionano le nostre decisioni future.
Se oggi guardiamo al febbraio 2009, all’aprile 2020 o all’ottobre del 2022, facciamo tutti un po’ gli spacconi dicendo: “eh quelli che si che erano dei momenti ideali per investire! Ah se solo avessi avuto del cash da buttare dentro in quei momenti che bei soldi che avrei fatto”.
Stiamo parlando sicuramente di grandi “buying opportunity” dopo le voragini in cui è precipitato il mercato.
Assolutamente verissimo:
Da marzo del 2009 a gennaio 2020, un investimento sull’MSCI ACWI si sarebbe quadruplicato
Da aprile 2020 a gennaio 2022 sarebbe cresciuto del 60%
E infine da ottobre 2022 a settembre di quest’anno sarebbe cresciuto di un altro 50%.
E allora appare paradossale la nostra umana, troppo umana paura delle crisi future.
Perché un’ecatombe come il 2008 la vediamo come un’opportunità mentre la prossima crisi come una tragedia?
Ovviamente perché in quei casi sappiamo come è andata a finire, mentre non possiamo essere certi che la prossima crisi finirà con un trionfo come nel passato.
E magari ci sono ottimi motivi per pensare che la prossima volta sarà diverso e arriverà la più grande crisi finanziaria della storia dell’uomo da cui nessuno più si riprenderà, come abilmente ha predetto il mio collega di scaffale nelle librerie Robert Kijosaki,
talmente abilmente che ne ha già previste circa una decina prima ancora che la prima crisi epocale cominci.
L’ultima straordinaria chiamata del nostro grande veggente è stata il 4 aprile di quest’anno, il secondo terribile giorno di emorragia dei mercati dopo l’annuncio dei dazi al Rose Garden della casabianca con l’ormai mitologico cartellone da tombola di Trump.
Cito testuale:
Non dovrei dirlo perché non è una cosa cool dire “ve l’avevo detto”. Però ve l’avevo detto.
Nel mio libro “la profezia del padre ricco” avvisavo che il più grande crollo nella storia dei mercati avrebbe spazzato via la sicurezza finanziaria di milioni di investitori, specialmente della mia generazione: i baby boomers.
Il crollo è arrivato oggi. Siamo definitivamente in una recessione e più probabilmente in una depressione.
Preso in pieno.
Dal suo ve l’avevo detto anche se non è fico dirlo agli ultimi massimi dell’S&P 500, più 33%.
Ragazzi seguite il buon Robert su X perché ogni volta che ne spara una, quello è il momento di vendervi anche le mutande per avere soldi da investire.
E la cosa che mi fa più incazzare è che quando avrà detto la 46ma puttanata magari sarà la volta buona che ci prende davvero e tutti si ricorderanno di come ha predetto la più grande crisi della nostra era e non delle altre 45 minchiate che ha detto negli anni.
Però appunto, come dicevo, ci potranno essere tanti motivi per cui la prossima crisi sarà molto dura, psicologicamente e magari finanziariamente difficile da affrontare.
Ma la verità è che anche quelle del passato sono state esattamente così.
E anche durante quelle del passato il pensiero dominante era: questa volta è davvero finita.
Come dice il buon dott. Ed Yardeni, ci sono bolle lì fuori.
E scoppieranno, perché è quello che fanno le bolle.
Ma queste diventeranno buying opportunity, esattamente come lo sono state tutte le bolle scoppiate nel passato.
Conclusione del primo capitolo.
Housel ha assolutamente ragione: prevedere, soprattutto prevedere il comportamento a breve termine dei mercati e dell’economia è impossibile. Non possiamo smettere di provare a farlo perché è nella nostra natura. Ma resta una sfida impossibile da vincere.
Eppure non è del tutto impossibile prevedere il lungo termine.
Nel lungo termine i nostri asset varranno di più di quel che valgono oggi.
Quelli più costosi scenderanno, quelli più economici saliranno.
Ma in quest’imprevedibile alternanza tra boom e bust, tra ascese e crolli, l’unica previsione che conta e che noi il nostro noi investitore di domani sarà più ricco di quanto lo è oggi.
E questa è una buona notizia.
Questa buona notizia è però composta da due elementi, che sono l’oggetto dei prossimi due capitoli.
[CAPITOLO 2: La regressione verso la media]
CAPITOLO 2: La regressione verso la media.
1° Aforisma: Niente di troppo positivo o troppo negativo persiste per sempre, perché i buoni periodi piantano i semi della loro stessa distruzione attraverso la compiacenza e la leva, mentre i cattivi periodi piantano i semi della loro rinascita attraverso la creazione di opportunità e lo sviluppo della nostra attitudine al problem-solving mosso dal panico.
OK questo è uno dei più lunghi, non esattamente una frase memorabile.
Ma le verità che contiene sono enormi.
Noi parliamo spesso di regressione verso la media.
I mercati attraverso cicli di 1-2 decenni di grande, lenta e lunga crescita inframezzati da bruschi, rapidi e violenti crolli.
La risposta tecnica al motivo per cui ciò accade l’abbiamo provata a dare più volte: variano i tassi di sconto del mercato, perché variano la percezione del rischio, le abitudini di consumo e le preferenze soggettive degli investitori, in un complesso equilibrio che intreccia la dimensione individuale di ogni singolo investitore con la cornice macroeconomica in cui è inserito, che di volta in volta sarà determinata da diversi livelli di inflazione, tassi di interesse, disoccupazione, prodouttività e così via.
Quando i tassi di sconto scendono, cioè quando diminuisce il rendimento richiesto dagli investitori, quando si contrae il premio al rischio, i prezzi salgono;
Quando i tassi di sconto salgono, invece, perché aumenta il rendimento richiesto dagli investitori e il premio al rischio si dilata, i prezzi scendono.
Si può discutere sui motivi profondi di questa dinamica.
Ma non sulla dinamica stessa.
Da questa non si scappa.
Housel però dà una lettura comportamentale potente.
Quando le cose vanno bene tendiamo a sederci, ad abbassare le antenne, a prenderci più rischi del dovuto, a usare la leva, a pensare che ciò che è salito fino ad oggi continuerà a salire per sempre. Queste sono le premesse della formazione del momento di minsky,
quando un ciclo di mercato raggiunge un culmine insostenibile e poi collassa.
Ma al contrario durante le crisi tiriamo fuori le nostre caratteristiche migliori.
L’uomo non è fatto per accettare la sconfitta – e più è messo alle strette, più cerca soluzioni straordinarie per risolvere i problemi.
Dalle ceneri della crisi degli anni ’30 e della seconda guerra mondiale abbiamo avuto un miracolo economico e finanziario in tutti i paesi sviluppati;
Dal disastro dell’iperinflazione e delle tensioni geopolitiche durante la guerra fredda abbiamo avuto gli anni 80 e 90 pieni di entusiasmo, crescita e innovazione;
Dalle macerie del decennio perduto è partito il più lungo bull market di tutti i tempi e alcune delle più grandi innovazioni senza le quali non potremmo immaginarci le nostre vite sono nate esattamente in quel periodo nero:
Facebook è stata creata nel 2004;
Nello stesso anno Google si quotò in borsa e Chrome e Android nacquero nel 2008, durante il pieno della crisi immobiliare;
Sempre nel 2004 Musk entrò in Tesla, per farne la più grande impresa innovativa di sempre e SpaceX lancio il primo razzo privato nello spazio nel 2008;
Aws, il vero motivo per cui Amazon fa soldi, nacque nel 2006;
L’oggetto più iconico della nostra era, l’iPhone, nacque nel 2007;
Bitcoin nacque nel 2009;
E potrei citarne tantissime altre.
Siamo portati a vedere le crisi come fenomeni negativi.
Cosa che sicuramente sono.
Ma la storia dell’uomo è la storia di crisi risolte e ogni innovazione che oggi migliora la nostra vita il più delle volte è stata la risposta che qualche genio visionario ha voluto dare, non accettando la sconfitta di fronte ad uno status quo negativo.
Per nostra natura, abbiamo bisogno di stimoli per andare oltre, per fare cose inimmaginabili.
Quando le cose vanno bene per troppo tempo gli uomini finiscono per darsi la zappa sui piedi da soli.
Messi alle strette, invece, lì di solito cominciano le nostre riscosse.
Come dissi tante altre volte citando uno dei più film di questo secolo : la notte è più buia subito prima dell’alba.
L’avreste mai detto che il cavaliere oscuro ci avrebbe dato una delle più grandi lezioni di market timing di sempre?
Anche se in realtà la frase non la disse Batman ma Harvey Dent, il personaggio peggiore di quel capolavoro straordinario.
2° Aforisma, direttamente collegato al primo: ottimismo e pessimismo vanno sempre troppo oltre perché è l’unico modo per conoscerne i limiti è superarli.
Anche questa è una logica perfettamente umana che permea completamente le dinamiche dei mercati finanziari.
In fondo è l’interpretazione del filone accademico comportamentale della finanza – come ci aveva raccontato il grande prof. Gennaioli, a proposito della sua ricerca con Shleifer.
I mercati avrebbero una componente prevedibilmente irrazionale – e questo vale sia nella serie temporale dei mercati presi nel loro complesso, sia a livello trasversale quando andiamo a guardare i fattori.
Sistematicamente tendiamo ad essere troppo ottimisti sulla capacità delle società che hanno performato meglio nel recente passato di continuare a generare utili abnormi nel futuro; e sempre
Sistematicamente tendiamo ad essere troppo pessimisti sulle società che hanno fatto peggio.
Questo porterebbe due conseguenze:
I mercati raggiungerebbero valutazioni eccessive fino al punto di innescare delusioni che provocano dei crolli, o comunque dei repricing verso il basso; e al contrario valutazioni troppo basse preparano la strada per future sorprese che innescano repricing verso l’altro;
L’altra conseguenza riguarda il motivo per cui società con prezzi bassi rispetto ai fondamentali tendono a generare extra performance persistenti: le società value, quality, low volatilty per certi versi, sarebbero sistematicamente sottoprezzate (e le società opposte sovraprezzate).
Conclusione:
la storia dei mercati è una storia di alternanza di ottimismo e pessimismo, di fiducia eccessiva e di grande resilienza. È la storia di una tensione sistematica tra due opposti, che sono due opposti che in fin dei conti abitano il nostro animo.
Ma con due caveat:
Il primo è sapere che esiste questa tensione, permette di prendere decisioni migliori. Non permette di fare market timing, ma permette di non essere ingenui. Mercati cari preludono a rendimenti futuri inferiori – e quindi ciascuno può decidere fino a che punto vale la pena prendersi certi rischi – mentre mercati economici, depressi, annientati da una crisi, preludono a rendimenti futuri maggiori – e anche qui ciascuno può scegliere se farsi trascinare dalla depressione o agire razionalmente per cogliere quelle che in futuro saranno poi ricordate come buying opportunity.
Senza essere troppo sofisticati, avere una regola di ribilanciamento tipo: quando un’asset class drifta del 10-20% dall’asset allocation originaria ribilancio, solitamente è un modo per assecondare quello che abbiamo appena detto in maniera meccanica.
Il secondo caveat è che ottimismo e pessimismo lottano costantemente.
Ma questo scontro ha una componente intertemporale e asincrona.
Nel breve termine il pessimismo tende quasi sempre ad avere ragione; fai il kiyosaki di turno e prima o poi qualche crisi la becchi per forza, matematico;
Ma nel lungo termine è l’ottimismo che vince. Non si può proprio investire senza essere guidati da un ottimismo di fondo.
Ed è questo il tema del prossimo capitolo.
CAPITOLO 3: IL PESSIMISMO VINCE LE BATTAGLIE. L’OTTIMISMO VINCE LE GUERRE
Capitolo 3: Il pessimismo vince le battaglie. L’ottimismo vince le guerre.
1° aforisma: il pessimismo sembra sempre più smart dell’ottimismo, perché l’ottimismo fa pensare che qualcuno ti voglia vedere qualcosa, mentre il pessimismo fa pensare a qualcuno che sta cercando di aiutarti.
Fate un esercizio mentale.
Oggi attira di più la vostra attenzione qualcuno che vi dice:
Attenzione, questi sono i motivi per il mercato rischia un collasso, oppure
Attenzione, io non so una cippa lippa di niente ma penso solo che in qualche modo alla fine andrà tutto bene.
Ok, il primo atteggiamento sembra strutturato, analitico, consapevole e animato da una ragionevole prudenza.
Il secondo sembra scriteriato, ingenuo, inconsapevole e guidato da wishful thinking come si dice.
Eppure la finanza è uno di quei rari ambiti dell’esperienza umano in cui quello che ammette di non sapere niente ed è semplicemente animato da un’apparentemente immotivata fiducia nel futuro disintegra quello competente a minuzioso.
Ma la verità è che c’è un motivo di fondo alla base di tutto questo.
Pur con tutti cazzi che ci sono ogni giorno, globalmente la ricchezza aumenta nel tempo.
E benché inframezzata da mille crisi, la sua traiettoria è invariabilmente verso l’alto, perché è in quella direzione che è puntata l’ambizione che solleva ogni mattina dal letto quasi ciascuno di noi, come dice molto bene Housel con il suo
2° aforisma su questo: Più gente si alza ogni mattina intenta a risolvere problemi di quanta se ne alzi intenta a fare danni. Però la gente che fa danni ottiene più attenzione. Di conseguenza un lento progresso in mezzo ad una fanfara di cattive notizie è il normale stato delle cose.
Purtroppo non ho trovato un report cha vada troppo indietro nel tempo, ma sono certo che anche andando indietro di un secolo il trend sarebbe coerente.
La ricchezza globale aumenta.
Secondo lo UBS global Wealth report del 2025, la ricchezza netta personale dal 2000 ad oggi è quasi triplicata, al netto dell’inflazione.
E sarebbe quasi quintuplicata in termini nominali, passando dai 100 miliardi di dollari del 2000 ai quasi 500 miliardi di oggi.
Poi ovviamente non è cresciuta in modo eguale ovunque e per chiunque, ci sarebbe molto da dire se guardiamo la distribuzione nel dettaglio.
Ma resta il fatto che investire nella crescita dell’economia globale, rappresentata dalle sue società di volta in volta più di successo, che sono quelle rappresentate negli indici globali, è una scommessa con un valore atteso positivo.
Non sempre positivo.
Ma complessivamente positivo.
E questo sono sempre sorprendente alle orecchie dei più, perché la tendenza più comune è quella di pensare che i bei tempi sono andati e che ormai il presente e il futuro sono solo una merda.
Chiedete a chiunque conosciate e il 90% di loro vi dirà che oggi si sta peggio che in passato.
Ma la verità è tutt’altra.
Se consideriamo gli ultimi 35 anni, poco meno di tutta la mia permanenza su questa Terra sino ad ora,
L’aspettativa di vita media è passata da 64 a 73 anni;
La povertà estrema, meno di 2 dollari a parità di potere d’acquisto al giorno, è passata dal 36% della popolazione all’8%;
Il PIL pro capite, sempre a parità di potere d’acquisto, è passato da 9.000 a 21.000 dollari.
Il tasso di mortalità infantile è sceso del 70%;
L’alfabetizzazione è passata da tre quarti della popolazione a nove su 10 abitanti del pianeta;
La denutrizione si è quasi dimezzata;
Il tasso di omicidi è sceso di un terzo;
L’accesso all’elettricità è aumentato di quasi il 30%;
L’accesso a internet è passato da praticamente zero negli anni 90 a due terzi della popolazione oggi – con tutti i benefici che ciò può portare.
Potrei sbrodolare altri mille numeri sui progressi della medicina, delle energie rinnovabili, delle tecnologie produttive e tante altre cose ancora.
Il problema è che queste cose sono il risultato di lunghi processi che non fanno alcuna notizia.
Mentre sul caso di cronaca nera del tizio che accoltella l’altro tizio perché gli aveva rubato il parcheggio i telegiornali e i talk show ci fanno settimane di contenuti.
Eppure la verità della storia dell’uomo è tutt’altra.
E di nuovo il nostro Morgan Housel non avrebbe potuto sintetizzare meglio l’intrinseca tendenza al miglioramento strutturale della storia dell’umanità di quanto ha fatto con il
3° aforisma dedicato all’ottimismo: una grande lezione dalla storia economica è che il passato non era così positivo come ce lo ricordiamo, il presente non è così male come pensiamo e soprattutto il futuro sarà meglio di quel che ci aspettiamo.
La storia dei mercati finanziari è probabilmente la rappresentazione quantitativa nel tempo della sistematica vittoria dell’ottimismo sul pessimismo.
Ok.
E quindi, come si traduce tutto ciò in termini pratici per l’investitore?
Beh, sia chiaro, non sto per darvi nessuna ricetta innovativa.
Ma ancora una volta l’obiettivo è usare il potere degli aforismi perché consolidare le nostre convinzioni su alcune abitudini, soprattutto mentali, che dovrebbero diventare parte integrante del modo in cui oggi, tra 10 anni, tra 30 anni e tra 50 anni ci approcciamo ai nostir investimenti.
[CAPITOLO 4: NEGLI INVESTIMENTI LA SEMPLICITÀ BATTE LA COMPLESSITÀ]
Capitolo 4: negli investimenti, la semplicità batte la complessità, soprattutto se supportata dalla pazienza e dalla capacità della nostra ragione di governare le nostre emozioni.
1° Aforisma: la definizione di Napoleone di genio militare era “l’uomo che si comporta nella media quando ciascun altro intorno a lui va fuori di testa”. E questa è la stessa cosa negli affari e negli investimenti.
Suona familiare?
In effetti noi cresciamo con l’idea che la mediocrità e la mancanza di azione siano aspetti negativi.
E probabilmente nella maggior parte degli ambiti della nostra esperienza di vita è così.
Ma la finanza è un altro discorso.
La sua dimensione competitiva estrema fa sì che l’interazione tra tutti gli investitori del mondo bilanci le varie forze in gioco livellando i vantaggi competitivi.
Il rendimento del mercato corrisponde al rendimento medio di tutti gli investitori attivi meno i costi.
Puntare “passivamente” a questa media, tuttavia, è un’attività anch’essa.
Richiede due specifiche decisioni estremamente attive:
La prima è quella di rinunciare a fare scommesse specifiche, discrezionali, nel tentativo di battere il mercato, perché sappiamo bene che le probabilità sono tutte più sbilanciate dal lato della sottoperformance, che non della sovraperformance – soprattutto a lungo termine.
Quindi decidere di essere “medi”, di puntare al rendimento medio, è una decisione di investimento consapevole e per certi versi essa stessa attiva.
La seconda decisione, ancora più complessa, è quella di mantenere questa disciplina di investimento in ogni circostanza – quando invece il nostro stomaco ci porterebbe a fare altro.
Vedete, vi svelo una verità con cui tutti noi prima o poi ci confronteremo.
Investire in ETF copiano l’MSCI ACWI o il vostro indice che vi pare, dal 2009 ad oggi, è stato facilissimo.
Certo nessuno lo sapeva ex ante.
Ma investire quando fondamentalmente le cose peggiori che sono successe sono stati un brutto trimestre nel 2018, due mesi drammatici nel 2020 e nove mesi di graduale discesa nel 2022, beh, grazie al cazzo direi.
È facile.
Investi con il pilota automatico.
Ti porti a casa un rendimento astronomico.
Sembra il migliore dei mondi possibili.
Ma la sfida vera sarà al primo ciclo secolare negativo.
Quando magari si dovrà convivere per anni con un mercato costantemente con il segno rosso.
Essere “passivi” lì sarà difficile al quadrato.
Perché nelle situazioni difficili noi esseri umani siamo programmati per reagire e agire.
Dobbiamo fare qualcosa.
Non è nella nostra natura “non fare niente e aspettare che la tempesta passi”.
Ci fa diventare matti questa cosa.
La pazienza e la fiducia che nel futuro le cose andranno a posto non sono caratteristiche che fanno parte delle nostre impostazioni di fabbrica. Le dobbiamo sviluppare con grande fatica.
Noi sappiamo bene che mantenere la barra dritta, ribilanciare, continuare ad investire secondo i piani e così via è la ricetta giusta da seguire.
Ma improvvisamente, al primo momento di crisi vera, ci dimenticheremo di tutto questo e VORREMO FARE QUALCOSA – perché anche se quello di The Bull ha menato sto torrone per centinaia di ore, niente, noi ci dimenticheremo che l’approccio “passivo” vale anche nei momenti negativi e andremo fuori di testa nel vano tentativo di intervenire per mettere qualche pezza al tracollo dei nostri portafogli.
Ci dimenticheremo che quei tracolli non sono un tragico errore, ma parte integrante del programma “investire a lungo termine”.
Certo, sarebbe bello prendersi solo i bull market e saltare i bear market.
Però a parte una manciata di consulenti bancari che fanno corsi a pagamento per insegnare a prevedere tutte le crisi e vincere sempre – che io invidio tantissimo e mi chiedo ancora perché non siano multimiliardari e nessuno li abbia chiamati da Stoccolma per il Nobel – la verità è che nessuno sa davvero come fare.
Se investi nel mercato, del mercato ti prendi le belle e le brutte stagioni.
Come nella vita vera, impari a convivere con l’inverno, la pioggia e il freddo, non è che smetti di vivere per tre mesi perché ti piacciono solo le altre 3 stagioni.
Ma perché facciamo questo?
Perché sarà maledettamente difficile mantenere la rotta proprio nei momenti più critici, quando mantenere la rotta diventerà ancora più importante?
Perché razionalmente sappiamo cosa fare, ma l’emotività potrebbe prendere il sopravvento?
Perché non fa parte della nostra natura attendere con pazienza che i mercati facciano il loro corso naturale?
La risposta a queste ultime due domande in particolare la danno i prossimi 2 aforismi di questo capitolo.
Numero 2: Le emozioni possono prevalere su qualunque livello di intelligenza.
E
Numero 3: La maggior parte degli errori finanziari arrivano quando si cerca di forzare le cose ad andare più velocemente del dovuto. Al rendimento composto non piace quando provi a barare. Non avere FOMO potrebbe essere la competenza più importante quando si investe.
Le ho messe assieme perché sono due modi di vedere la stessa cosa.
Noi siamo impazienti per natura.
E vogliamo “fare qualcosa” nel tentativo di accelerare il decorso di un fenomeno di cui ci interessa il risultato finale.
Messe insieme queste due nostre attitudini compongono una combinazione esplosiva.
La FOMO nei momenti positivi e il suo alter-ego la FOL, la fear of losing, che si presenta nei momenti negativi, rappresentano esattamente il trionfo delle emozioni sulla ragione.
Ed entrambe queste emozioni rappresentano delle forze centrifughe che ci portano alla deriva rispetto al corso che dovrebbero avere i nostri investimenti.
Quello che invece siamo più portati a fare è seguire l’eccesso di fiducia quando le cose vanno bene, dimenticarci perché è importante ribilanciare, farci prendere dal panico quando i mercati crollano, dimenticarsi nuovamente perché è importante ribilanciare e via all’infinito finché non combiniamo tutti i disastri possibili e immaginabili.
E questa non è una prerogativa di investitori stupidi.
Questa è la prerogativa di tutti noi – e forse soprattutto di chi è più competente e intelligente e quindi comprensibilmente cerca di sfruttare le proprie capacità per trarne un vantaggio competitivo.
Ma i mercati finanziari sono dei grandi equalizzatori.
Non guardano in faccia a nessuno e puniscono quasi chiunque provi ad accelerare i suoi processi naturali e a dribblare le sue dinamiche meno piacevoli.
La duplice decisione di stare nella media e di rimanere nella media anche quando le cose vanno male sarà quindi per la maggior parte di noi comuni mortali il modo per essere, in effetti, degli investitori sopra la media.
Ultimo aforisma, perfetta conclusione di quello che abbiamo detto e una delle mie frasi preferite di Housel, una delle più memorabili e decisamente uno dei più potenti principi guida che qualunque individuo adulto percettore di un reddito e con una minima capacità di risparmio dovrebbe fare proprio.
La maggior parte delle persone possono permettersi di non essere grandi investitori, ma non possono permettersi di essere dei cattivi investitori.
Boom, la mia arma segreta quando mi trovo all’angolo in qualche conversazione senza speranza con ottusi scettici nei confronti di ciò che vado predicando.
Possiamo permetterci non di essere grandi investitori:
Non dobbiamo puntare ad essere delle superstar della finanza
Non dobbiamo cercare di prevedere il corso futuro dei mercati
Non dobbiamo evitare i momenti di crollo
Seguendo Napoleone, dobbiamo fare di tutto per essere nella media e rimanere nella media.
Ma proprio per questo, proprio perché il miglior consiglio di base che si può dare al comune risparmiatore è di investire puntando alla media e non all’eccellenza
Non possiamo permetterci di essere cattivi investitori:
Non dobbiamo farci prendere dalla FOMO e dalla FOL
Non dobbiamo peccare di eccessiva sicurezza
Non dobbiamo prenderci più rischi di ciò che abbiamo previsto all’interno di una pianificazione di buon senso, consapevolmente coraggiosa e non ingenuamente spregiudicata.
Investire è troppo importante per la nostra vita.
E’ la ricetta per farlo bene è nota.
Non siamo fatti per investire.
Ma proprio per questo, non possiamo permetterci di non farlo.
Fine amici miei.
Grazie alla partecipazione involontaria di Morgan Housel che sta facendo troppe interviste e per ora a The Bull non riesce a venire, ma vedrete che prima o poi riusciremo ad averlo con noi.
Spero che quest’episodio un po’ particolare vi sia piaciuto – e anche se non vi è piaciuto come minimo vi siete portati a casa una sfilza di frasi ad effetto che vi faranno sembrare più smart con amici, parenti e conoscenti quando parlerete con loro di finanza e la conversazione si incaglia.
Come sempre a questo punto arrivati vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su Spotfy, apple podcast e iscrivervi al canale YouTube per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che potrei lasciare una linea di cioccolatini con la nocciola dentro e un sacco di frasi ad effetto fuori sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Bentornati a The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Intanto con questo episodio ho già battuto ogni record con il titolo più lungo di tutti i tempi che sicuramente YouTube mi segnerà.
Però il concetto che volevo esprimere era questo: mi sono imbattuto in una raccolta di decine e decine di aforismi dello straordinario e immenso Morgan Housel, autore tra gli altri del best seller galattico multi mega milionario The Psychology of Money, ciascuno dei quali avrebbe meritato un episodio a sé.
Ma non volevo neanche allungare il brodo – in fondo la potenza degli aforismi è proprio quella di trasmettere dei contenuti complessi in forma semplice, imprimendoli nel nostro cervello in maniera indelebile, e possibilmente trasformando il nostro sistema di convinzioni e comportamenti.
La storia è costellata di personaggi straordinari a cui vengono attribuite – più o meno correttamente – delle frasi leggendarie, depositarie di una saggezza universale che aspettavano solo che una mente brillante le mettesse in parole in maniera incisiva: Seneca, Oscar Wilde, Mark Twain, Winston Churchill sono solo alcuni dei più noti e prolifici produttori di aforismi memorabili, tanto più potenti ed efficaci, quanto più sintetici ed evocativi.
Ma il più grande di tutti, è uno soltanto, per distanza siderale rispetto a chiunque altro per la totale inconsapevolezza con cui regalò al mondo delle perle imperiture.
Lo scoprii anni fa leggendo i libri di Nassim Taleb, che affiancò il suo genio a quello di Karl Popper, Friedrich von Hayek e Benoit Mandelbrot.
Stiamo parlando del leggendario giocatore e poi allenatore dei New York Yankees: Yogi Berra.
Le mi 5 preferite di tutti i tempi:
“Non è finita finché non è finita.”
“Partecipa sempre ai funerali degli altri; altrimenti loro non verranno al tuo.”
“Se non sai dove stai andando, potresti finire da un’altra parte.”
“Il futuro non è più quello di una volta.”
E per concludere la frase più bella del mondo, che con il suo evidente paradosso logico esprime in realtà una verità esistenziale che spesso dimentichiamo e che se invece incorporassimo nel sistema dei nostri principi guida, beh, vivremo tutti molto meglio.
“Se il mondo fosse perfetto, non lo sarebbe.”
Rest in peace Yogi.
Morgan Housel non è all’altezza di Yogi Berra, probabilmente perché i suoi aforismi li pensa e li sviluppa intenzionalmente.
La spontanea e ingenua inconsapevolezza di Berra invece non ce l’ha nessun altro.
Però quando si tratta di finanza personale, beh, Housel, resta comunque il mio preferito.
Ok a volte semplifica un po’ troppo e non è davvero un esperto di finanza duro e puro.
Ma la straordinaria capacità con cui riesce a mettere a terra concetti complessi con 10 parole è una cosa che gli invidio parecchio.
Forse perché io invece sono un po’ logorroico.
Allora ho pensato di fare questa cosa.
Negli ultimi episodi abbiamo visto: equazioni, descrizioni matematiche delle dinamiche dei mercati, paper, report, grafici, dati e tutta roba che – insomma – secondo me super super super interessante, ma non troppo rilassante per il cervello.
Oggi invece mettetevi comodi che in questo episodio ci portiamo a casa due obiettivi:
Il PRIMO è mettere insieme quattro principi guida che tocchiamo spesso, ma che chiaramente nella forma data dagli aforismi di Housel hanno tutt’un altro impatto. Come dire: i concetti probabilmente vi saranno in parte noti, ma credo che il modo in cui housel li mette giù possa portare una diversa consapevolezza e modificare parzialmente il nostro sguardo su questi temi.
Il SECONDO è ancora più importante. Cioè ma avete presente quanto sembrate smart quando state facendo una discussione di finanza con qualcuno che non ci capisce un cazzo, che per spiegargli le cose dovreste star lì tre ore dirgli tutto e invece – sbam! – frase ad effetto di 5 secondi, mic drop, game, set, match, tutti a casa e nessuno si azzardi più a dibattere di finanza con gli ascoltatori di The Bull che sanno le cose sia in versione lunga che in versione bacio perugina.
Allora come sarà strutturato l’episodio.
Girerà intorno a 4 concetti principali, che sono:
L’assurdità delle PREVISIONI
La REGRESSIONE VERSO LA MEDIA
L’OTTIMISMO come prerequisito anche solo per partecipare a questo gioco e infine
La SUPERIORITA’ della Semplicità nell’investimento
Per ciascuno di questi principi guida commenteremo una manciata tra gli aforismi di Housel che secondo me rendono molto bene il concetto.
A conclusione di ogni blocco, cercherò di formulare una sintesi unificante.
Pronti?
Cominciamo.
SPONSOR FINECO
[mettere una dissolvenza]
[Capitolo UNO: L’assurdità delle previsioni]
Capitolo UNO: L’assurdità delle previsioni.
1° aforisma:
La storia è guidata da eventi sorprendenti mentre le previsioni sono guidate da eventi ovvi.
Se ci pensate questo è uno dei vari paradossi legati alla nostra indispensabile esigenza di provare a prevedere il futuro e all’irrazionalità a cui ci attacchiamo in questo vano tentativo.
La crisi del 29, lo shock petrolifero degli anni ’70, il 19 ottobre del 1987, l’11/9, il fallimento di Lehman Brothers, il Covid e una miriade di altri eventi dirompenti che hanno avuto un impatto massivo sul corso della storia dei mercati – e della storia in generale se vogliamo – sono stati dei Cigni Neri, eventi non previsti al tempo e con impatto su larga scala.
E quindi il paradosso è: ma se i grandi snodi della storia sono stati determinati da eventi che non potevano essere previsti, qual è il punto di fare stime sul futuro come se il futuro fosse fatto da eventi largamente prevedibili?
2° aforisma:
Ogni valutazione del mercato è un numero di oggi moltiplicato per una storia sul domani.
Avete presente quando spiego come è composto il rendimento di un asset finanziario?
Ecco la versione difficile è questa:
Da cosa è composto il rendimento di un titolo di stato decennale?
Da tre cose:
Inflazione attesa
Aspettativa sui tassi reali a breve termine e
Premio al rischio per la duration.
Per fare un esempio con i nostri BTP:
L’inflazione attesa è leggermente sotto al 2%
L’aspettativa sui tassi reali, cioè tassi della BCE meno inflazione, è circa 0,2%
Mentre infine il premio al rischio è grossomodo 1,6%
Il totale dà il rendimento sul decennale.
Per chi sta vedendo il video il grafico che è comparso è preso dall’8° capitolo della serie di Antti Ilmanen, Understanding Return Expectation, forse la cosa più bella in cui mi sono imbattuto da quanto consumo più articoli di finanza che carboidrati.
Invece da cosa è composto il rendimento azionario?
Anche qui da tre cose:
Dal rendimento da dividendo, cioè dividendi diviso prezzo;
Dalla crescita (o decrescita) degli utili per azione e infine
Dalla variazione del rapporto tra prezzo e utili:
Quando aumenta c’è generalmente una maggior fiducia e una minore percezione del rischio futuro;
Quando diminuisce c’è invece maggior sfiducia e maggiore percezione del rischio futuro.
Vedete che i prezzi di un asset che oggi vediamo sul mercato e a cui oggi compriamo sono composti da un elemento più o meno oggettivo: i tassi di interesse e l’inflazione di oggi per i bond, utili e dividendi per le azioni, e da un elemento soggettivo: le aspettative sull’inflazione, sul rischio e sulla crescita futura.
In parole tecniche, la decomposizione dei rendimenti è questa.
Ma per arrivare dritto al punto, Housel ha ragione al 100%: i prezzi che osserviamo ogni giorno sulla nostra app di market watch preferita sono esattamente un numero di oggi moltiplicato per una storia sul domani.
Quali sono oggi le due grandi storie principali:
Per le obbligazioni, direi principalmente le paure sulla sostenibilità dei debiti pubblici, parzialmente limate dalla convinzione che i governi applicheranno “ dominance”, repressione fiscale, per contenere i rendimenti;
Per le azioni, ovviamente, la grande storia è l’intelligenza artificiale.
3° aforisma:
Circa una volta ogni decennio la gente si dimentica che le bolle si formano e scoppiano circa una volta ogni decennio.
Beh, questa è poesia.
Solo per prendere la storia recente:
1988-1999: formazione della grande bolla di internet;
2000-2002: conflagrazione della grande bolla di internet;
1995-2006: formazione della grande bolla immobiliare;
2007-2009: conflagrazione della grande bolla immobiliare;
2010-2021: formazione della grande bolla dei tassi a zero, delle meme stock, del private equity, degli SPAC, delle IPO di società sgangherate, ICO, NFT, shitcoin, insomma tutte quelle follie che abbiamo visto soprattutto nell’anno successivo al covid;
2022: conflagrazione della bolla del denaro gratis e ritorno alla realtà, fatto di inflazione, tassi di interesse più elevati e tutto quel che sapete.
Nel 2022 è anche nato ChatGPT.
Chissà, magari abbiamo ancora 6-7 anni prima che la bolla si gonfi del tutto.
Però Housel coglie perfettamente il punto ancora una volta.
Veniamo continuamente colti di sorpresa da dinamiche che invece sono sorprendentemente ripetitive.
E vedremo che questo tema, in altre salse e da altre prospettive, ritornerà più volte nell’episodio di oggi.
4° e ultimo aforisma sul tema previsioni:
Ogni crollo del passato oggi lo vediamo come un’opportunità mentre ogni crollo futuro lo vediamo come un rischio.
L’ho messo nella categoria previsioni, anche se forse ha più a che fare con il nostro bipolarismo quando investiamo governati più dalla pancia che dalla testa.
Però ha certamente a che fare anche con il modo in cui le nostre previsioni bacate condizionano le nostre decisioni future.
Se oggi guardiamo al febbraio 2009, all’aprile 2020 o all’ottobre del 2022, facciamo tutti un po’ gli spacconi dicendo: “eh quelli che si che erano dei momenti ideali per investire! Ah se solo avessi avuto del cash da buttare dentro in quei momenti che bei soldi che avrei fatto”.
Stiamo parlando sicuramente di grandi “buying opportunity” dopo le voragini in cui è precipitato il mercato.
Assolutamente verissimo:
Da marzo del 2009 a gennaio 2020, un investimento sull’MSCI ACWI si sarebbe quadruplicato
Da aprile 2020 a gennaio 2022 sarebbe cresciuto del 60%
E infine da ottobre 2022 a settembre di quest’anno sarebbe cresciuto di un altro 50%.
E allora appare paradossale la nostra umana, troppo umana paura delle crisi future.
Perché un’ecatombe come il 2008 la vediamo come un’opportunità mentre la prossima crisi come una tragedia?
Ovviamente perché in quei casi sappiamo come è andata a finire, mentre non possiamo essere certi che la prossima crisi finirà con un trionfo come nel passato.
E magari ci sono ottimi motivi per pensare che la prossima volta sarà diverso e arriverà la più grande crisi finanziaria della storia dell’uomo da cui nessuno più si riprenderà, come abilmente ha predetto il mio collega di scaffale nelle librerie Robert Kijosaki,
talmente abilmente che ne ha già previste circa una decina prima ancora che la prima crisi epocale cominci.
L’ultima straordinaria chiamata del nostro grande veggente è stata il 4 aprile di quest’anno, il secondo terribile giorno di emorragia dei mercati dopo l’annuncio dei dazi al Rose Garden della casabianca con l’ormai mitologico cartellone da tombola di Trump.
Cito testuale:
Non dovrei dirlo perché non è una cosa cool dire “ve l’avevo detto”. Però ve l’avevo detto.
Nel mio libro “la profezia del padre ricco” avvisavo che il più grande crollo nella storia dei mercati avrebbe spazzato via la sicurezza finanziaria di milioni di investitori, specialmente della mia generazione: i baby boomers.
Il crollo è arrivato oggi. Siamo definitivamente in una recessione e più probabilmente in una depressione.
Preso in pieno.
Dal suo ve l’avevo detto anche se non è fico dirlo agli ultimi massimi dell’S&P 500, più 33%.
Ragazzi seguite il buon Robert su X perché ogni volta che ne spara una, quello è il momento di vendervi anche le mutande per avere soldi da investire.
E la cosa che mi fa più incazzare è che quando avrà detto la 46ma puttanata magari sarà la volta buona che ci prende davvero e tutti si ricorderanno di come ha predetto la più grande crisi della nostra era e non delle altre 45 minchiate che ha detto negli anni.
Però appunto, come dicevo, ci potranno essere tanti motivi per cui la prossima crisi sarà molto dura, psicologicamente e magari finanziariamente difficile da affrontare.
Ma la verità è che anche quelle del passato sono state esattamente così.
E anche durante quelle del passato il pensiero dominante era: questa volta è davvero finita.
Come dice il buon dott. Ed Yardeni, ci sono bolle lì fuori.
E scoppieranno, perché è quello che fanno le bolle.
Ma queste diventeranno buying opportunity, esattamente come lo sono state tutte le bolle scoppiate nel passato.
Conclusione del primo capitolo.
Housel ha assolutamente ragione: prevedere, soprattutto prevedere il comportamento a breve termine dei mercati e dell’economia è impossibile. Non possiamo smettere di provare a farlo perché è nella nostra natura. Ma resta una sfida impossibile da vincere.
Eppure non è del tutto impossibile prevedere il lungo termine.
Nel lungo termine i nostri asset varranno di più di quel che valgono oggi.
Quelli più costosi scenderanno, quelli più economici saliranno.
Ma in quest’imprevedibile alternanza tra boom e bust, tra ascese e crolli, l’unica previsione che conta e che noi il nostro noi investitore di domani sarà più ricco di quanto lo è oggi.
E questa è una buona notizia.
Questa buona notizia è però composta da due elementi, che sono l’oggetto dei prossimi due capitoli.
[CAPITOLO 2: La regressione verso la media]
CAPITOLO 2: La regressione verso la media.
1° Aforisma: Niente di troppo positivo o troppo negativo persiste per sempre, perché i buoni periodi piantano i semi della loro stessa distruzione attraverso la compiacenza e la leva, mentre i cattivi periodi piantano i semi della loro rinascita attraverso la creazione di opportunità e lo sviluppo della nostra attitudine al problem-solving mosso dal panico.
OK questo è uno dei più lunghi, non esattamente una frase memorabile.
Ma le verità che contiene sono enormi.
Noi parliamo spesso di regressione verso la media.
I mercati attraverso cicli di 1-2 decenni di grande, lenta e lunga crescita inframezzati da bruschi, rapidi e violenti crolli.
La risposta tecnica al motivo per cui ciò accade l’abbiamo provata a dare più volte: variano i tassi di sconto del mercato, perché variano la percezione del rischio, le abitudini di consumo e le preferenze soggettive degli investitori, in un complesso equilibrio che intreccia la dimensione individuale di ogni singolo investitore con la cornice macroeconomica in cui è inserito, che di volta in volta sarà determinata da diversi livelli di inflazione, tassi di interesse, disoccupazione, prodouttività e così via.
Quando i tassi di sconto scendono, cioè quando diminuisce il rendimento richiesto dagli investitori, quando si contrae il premio al rischio, i prezzi salgono;
Quando i tassi di sconto salgono, invece, perché aumenta il rendimento richiesto dagli investitori e il premio al rischio si dilata, i prezzi scendono.
Si può discutere sui motivi profondi di questa dinamica.
Ma non sulla dinamica stessa.
Da questa non si scappa.
Housel però dà una lettura comportamentale potente.
Quando le cose vanno bene tendiamo a sederci, ad abbassare le antenne, a prenderci più rischi del dovuto, a usare la leva, a pensare che ciò che è salito fino ad oggi continuerà a salire per sempre. Queste sono le premesse della formazione del momento di minsky,
quando un ciclo di mercato raggiunge un culmine insostenibile e poi collassa.
Ma al contrario durante le crisi tiriamo fuori le nostre caratteristiche migliori.
L’uomo non è fatto per accettare la sconfitta – e più è messo alle strette, più cerca soluzioni straordinarie per risolvere i problemi.
Dalle ceneri della crisi degli anni ’30 e della seconda guerra mondiale abbiamo avuto un miracolo economico e finanziario in tutti i paesi sviluppati;
Dal disastro dell’iperinflazione e delle tensioni geopolitiche durante la guerra fredda abbiamo avuto gli anni 80 e 90 pieni di entusiasmo, crescita e innovazione;
Dalle macerie del decennio perduto è partito il più lungo bull market di tutti i tempi e alcune delle più grandi innovazioni senza le quali non potremmo immaginarci le nostre vite sono nate esattamente in quel periodo nero:
Facebook è stata creata nel 2004;
Nello stesso anno Google si quotò in borsa e Chrome e Android nacquero nel 2008, durante il pieno della crisi immobiliare;
Sempre nel 2004 Musk entrò in Tesla, per farne la più grande impresa innovativa di sempre e SpaceX lancio il primo razzo privato nello spazio nel 2008;
Aws, il vero motivo per cui Amazon fa soldi, nacque nel 2006;
L’oggetto più iconico della nostra era, l’iPhone, nacque nel 2007;
Bitcoin nacque nel 2009;
E potrei citarne tantissime altre.
Siamo portati a vedere le crisi come fenomeni negativi.
Cosa che sicuramente sono.
Ma la storia dell’uomo è la storia di crisi risolte e ogni innovazione che oggi migliora la nostra vita il più delle volte è stata la risposta che qualche genio visionario ha voluto dare, non accettando la sconfitta di fronte ad uno status quo negativo.
Per nostra natura, abbiamo bisogno di stimoli per andare oltre, per fare cose inimmaginabili.
Quando le cose vanno bene per troppo tempo gli uomini finiscono per darsi la zappa sui piedi da soli.
Messi alle strette, invece, lì di solito cominciano le nostre riscosse.
Come dissi tante altre volte citando uno dei più film di questo secolo : la notte è più buia subito prima dell’alba.
L’avreste mai detto che il cavaliere oscuro ci avrebbe dato una delle più grandi lezioni di market timing di sempre?
Anche se in realtà la frase non la disse Batman ma Harvey Dent, il personaggio peggiore di quel capolavoro straordinario.
2° Aforisma, direttamente collegato al primo: ottimismo e pessimismo vanno sempre troppo oltre perché è l’unico modo per conoscerne i limiti è superarli.
Anche questa è una logica perfettamente umana che permea completamente le dinamiche dei mercati finanziari.
In fondo è l’interpretazione del filone accademico comportamentale della finanza – come ci aveva raccontato il grande prof. Gennaioli, a proposito della sua ricerca con Shleifer.
I mercati avrebbero una componente prevedibilmente irrazionale – e questo vale sia nella serie temporale dei mercati presi nel loro complesso, sia a livello trasversale quando andiamo a guardare i fattori.
Sistematicamente tendiamo ad essere troppo ottimisti sulla capacità delle società che hanno performato meglio nel recente passato di continuare a generare utili abnormi nel futuro; e sempre
Sistematicamente tendiamo ad essere troppo pessimisti sulle società che hanno fatto peggio.
Questo porterebbe due conseguenze:
I mercati raggiungerebbero valutazioni eccessive fino al punto di innescare delusioni che provocano dei crolli, o comunque dei repricing verso il basso; e al contrario valutazioni troppo basse preparano la strada per future sorprese che innescano repricing verso l’altro;
L’altra conseguenza riguarda il motivo per cui società con prezzi bassi rispetto ai fondamentali tendono a generare extra performance persistenti: le società value, quality, low volatilty per certi versi, sarebbero sistematicamente sottoprezzate (e le società opposte sovraprezzate).
Conclusione:
la storia dei mercati è una storia di alternanza di ottimismo e pessimismo, di fiducia eccessiva e di grande resilienza. È la storia di una tensione sistematica tra due opposti, che sono due opposti che in fin dei conti abitano il nostro animo.
Ma con due caveat:
Il primo è sapere che esiste questa tensione, permette di prendere decisioni migliori. Non permette di fare market timing, ma permette di non essere ingenui. Mercati cari preludono a rendimenti futuri inferiori – e quindi ciascuno può decidere fino a che punto vale la pena prendersi certi rischi – mentre mercati economici, depressi, annientati da una crisi, preludono a rendimenti futuri maggiori – e anche qui ciascuno può scegliere se farsi trascinare dalla depressione o agire razionalmente per cogliere quelle che in futuro saranno poi ricordate come buying opportunity.
Senza essere troppo sofisticati, avere una regola di ribilanciamento tipo: quando un’asset class drifta del 10-20% dall’asset allocation originaria ribilancio, solitamente è un modo per assecondare quello che abbiamo appena detto in maniera meccanica.
Il secondo caveat è che ottimismo e pessimismo lottano costantemente.
Ma questo scontro ha una componente intertemporale e asincrona.
Nel breve termine il pessimismo tende quasi sempre ad avere ragione; fai il kiyosaki di turno e prima o poi qualche crisi la becchi per forza, matematico;
Ma nel lungo termine è l’ottimismo che vince. Non si può proprio investire senza essere guidati da un ottimismo di fondo.
Ed è questo il tema del prossimo capitolo.
CAPITOLO 3: IL PESSIMISMO VINCE LE BATTAGLIE. L’OTTIMISMO VINCE LE GUERRE
Capitolo 3: Il pessimismo vince le battaglie. L’ottimismo vince le guerre.
1° aforisma: il pessimismo sembra sempre più smart dell’ottimismo, perché l’ottimismo fa pensare che qualcuno ti voglia vedere qualcosa, mentre il pessimismo fa pensare a qualcuno che sta cercando di aiutarti.
Fate un esercizio mentale.
Oggi attira di più la vostra attenzione qualcuno che vi dice:
Attenzione, questi sono i motivi per il mercato rischia un collasso, oppure
Attenzione, io non so una cippa lippa di niente ma penso solo che in qualche modo alla fine andrà tutto bene.
Ok, il primo atteggiamento sembra strutturato, analitico, consapevole e animato da una ragionevole prudenza.
Il secondo sembra scriteriato, ingenuo, inconsapevole e guidato da wishful thinking come si dice.
Eppure la finanza è uno di quei rari ambiti dell’esperienza umano in cui quello che ammette di non sapere niente ed è semplicemente animato da un’apparentemente immotivata fiducia nel futuro disintegra quello competente a minuzioso.
Ma la verità è che c’è un motivo di fondo alla base di tutto questo.
Pur con tutti cazzi che ci sono ogni giorno, globalmente la ricchezza aumenta nel tempo.
E benché inframezzata da mille crisi, la sua traiettoria è invariabilmente verso l’alto, perché è in quella direzione che è puntata l’ambizione che solleva ogni mattina dal letto quasi ciascuno di noi, come dice molto bene Housel con il suo
2° aforisma su questo: Più gente si alza ogni mattina intenta a risolvere problemi di quanta se ne alzi intenta a fare danni. Però la gente che fa danni ottiene più attenzione. Di conseguenza un lento progresso in mezzo ad una fanfara di cattive notizie è il normale stato delle cose.
Purtroppo non ho trovato un report cha vada troppo indietro nel tempo, ma sono certo che anche andando indietro di un secolo il trend sarebbe coerente.
La ricchezza globale aumenta.
Secondo lo UBS global Wealth report del 2025, la ricchezza netta personale dal 2000 ad oggi è quasi triplicata, al netto dell’inflazione.
E sarebbe quasi quintuplicata in termini nominali, passando dai 100 miliardi di dollari del 2000 ai quasi 500 miliardi di oggi.
Poi ovviamente non è cresciuta in modo eguale ovunque e per chiunque, ci sarebbe molto da dire se guardiamo la distribuzione nel dettaglio.
Ma resta il fatto che investire nella crescita dell’economia globale, rappresentata dalle sue società di volta in volta più di successo, che sono quelle rappresentate negli indici globali, è una scommessa con un valore atteso positivo.
Non sempre positivo.
Ma complessivamente positivo.
E questo sono sempre sorprendente alle orecchie dei più, perché la tendenza più comune è quella di pensare che i bei tempi sono andati e che ormai il presente e il futuro sono solo una merda.
Chiedete a chiunque conosciate e il 90% di loro vi dirà che oggi si sta peggio che in passato.
Ma la verità è tutt’altra.
Se consideriamo gli ultimi 35 anni, poco meno di tutta la mia permanenza su questa Terra sino ad ora,
L’aspettativa di vita media è passata da 64 a 73 anni;
La povertà estrema, meno di 2 dollari a parità di potere d’acquisto al giorno, è passata dal 36% della popolazione all’8%;
Il PIL pro capite, sempre a parità di potere d’acquisto, è passato da 9.000 a 21.000 dollari.
Il tasso di mortalità infantile è sceso del 70%;
L’alfabetizzazione è passata da tre quarti della popolazione a nove su 10 abitanti del pianeta;
La denutrizione si è quasi dimezzata;
Il tasso di omicidi è sceso di un terzo;
L’accesso all’elettricità è aumentato di quasi il 30%;
L’accesso a internet è passato da praticamente zero negli anni 90 a due terzi della popolazione oggi – con tutti i benefici che ciò può portare.
Potrei sbrodolare altri mille numeri sui progressi della medicina, delle energie rinnovabili, delle tecnologie produttive e tante altre cose ancora.
Il problema è che queste cose sono il risultato di lunghi processi che non fanno alcuna notizia.
Mentre sul caso di cronaca nera del tizio che accoltella l’altro tizio perché gli aveva rubato il parcheggio i telegiornali e i talk show ci fanno settimane di contenuti.
Eppure la verità della storia dell’uomo è tutt’altra.
E di nuovo il nostro Morgan Housel non avrebbe potuto sintetizzare meglio l’intrinseca tendenza al miglioramento strutturale della storia dell’umanità di quanto ha fatto con il
3° aforisma dedicato all’ottimismo: una grande lezione dalla storia economica è che il passato non era così positivo come ce lo ricordiamo, il presente non è così male come pensiamo e soprattutto il futuro sarà meglio di quel che ci aspettiamo.
La storia dei mercati finanziari è probabilmente la rappresentazione quantitativa nel tempo della sistematica vittoria dell’ottimismo sul pessimismo.
Ok.
E quindi, come si traduce tutto ciò in termini pratici per l’investitore?
Beh, sia chiaro, non sto per darvi nessuna ricetta innovativa.
Ma ancora una volta l’obiettivo è usare il potere degli aforismi perché consolidare le nostre convinzioni su alcune abitudini, soprattutto mentali, che dovrebbero diventare parte integrante del modo in cui oggi, tra 10 anni, tra 30 anni e tra 50 anni ci approcciamo ai nostir investimenti.
[CAPITOLO 4: NEGLI INVESTIMENTI LA SEMPLICITÀ BATTE LA COMPLESSITÀ]
Capitolo 4: negli investimenti, la semplicità batte la complessità, soprattutto se supportata dalla pazienza e dalla capacità della nostra ragione di governare le nostre emozioni.
1° Aforisma: la definizione di Napoleone di genio militare era “l’uomo che si comporta nella media quando ciascun altro intorno a lui va fuori di testa”. E questa è la stessa cosa negli affari e negli investimenti.
Suona familiare?
In effetti noi cresciamo con l’idea che la mediocrità e la mancanza di azione siano aspetti negativi.
E probabilmente nella maggior parte degli ambiti della nostra esperienza di vita è così.
Ma la finanza è un altro discorso.
La sua dimensione competitiva estrema fa sì che l’interazione tra tutti gli investitori del mondo bilanci le varie forze in gioco livellando i vantaggi competitivi.
Il rendimento del mercato corrisponde al rendimento medio di tutti gli investitori attivi meno i costi.
Puntare “passivamente” a questa media, tuttavia, è un’attività anch’essa.
Richiede due specifiche decisioni estremamente attive:
La prima è quella di rinunciare a fare scommesse specifiche, discrezionali, nel tentativo di battere il mercato, perché sappiamo bene che le probabilità sono tutte più sbilanciate dal lato della sottoperformance, che non della sovraperformance – soprattutto a lungo termine.
Quindi decidere di essere “medi”, di puntare al rendimento medio, è una decisione di investimento consapevole e per certi versi essa stessa attiva.
La seconda decisione, ancora più complessa, è quella di mantenere questa disciplina di investimento in ogni circostanza – quando invece il nostro stomaco ci porterebbe a fare altro.
Vedete, vi svelo una verità con cui tutti noi prima o poi ci confronteremo.
Investire in ETF copiano l’MSCI ACWI o il vostro indice che vi pare, dal 2009 ad oggi, è stato facilissimo.
Certo nessuno lo sapeva ex ante.
Ma investire quando fondamentalmente le cose peggiori che sono successe sono stati un brutto trimestre nel 2018, due mesi drammatici nel 2020 e nove mesi di graduale discesa nel 2022, beh, grazie al cazzo direi.
È facile.
Investi con il pilota automatico.
Ti porti a casa un rendimento astronomico.
Sembra il migliore dei mondi possibili.
Ma la sfida vera sarà al primo ciclo secolare negativo.
Quando magari si dovrà convivere per anni con un mercato costantemente con il segno rosso.
Essere “passivi” lì sarà difficile al quadrato.
Perché nelle situazioni difficili noi esseri umani siamo programmati per reagire e agire.
Dobbiamo fare qualcosa.
Non è nella nostra natura “non fare niente e aspettare che la tempesta passi”.
Ci fa diventare matti questa cosa.
La pazienza e la fiducia che nel futuro le cose andranno a posto non sono caratteristiche che fanno parte delle nostre impostazioni di fabbrica. Le dobbiamo sviluppare con grande fatica.
Noi sappiamo bene che mantenere la barra dritta, ribilanciare, continuare ad investire secondo i piani e così via è la ricetta giusta da seguire.
Ma improvvisamente, al primo momento di crisi vera, ci dimenticheremo di tutto questo e VORREMO FARE QUALCOSA – perché anche se quello di The Bull ha menato sto torrone per centinaia di ore, niente, noi ci dimenticheremo che l’approccio “passivo” vale anche nei momenti negativi e andremo fuori di testa nel vano tentativo di intervenire per mettere qualche pezza al tracollo dei nostri portafogli.
Ci dimenticheremo che quei tracolli non sono un tragico errore, ma parte integrante del programma “investire a lungo termine”.
Certo, sarebbe bello prendersi solo i bull market e saltare i bear market.
Però a parte una manciata di consulenti bancari che fanno corsi a pagamento per insegnare a prevedere tutte le crisi e vincere sempre – che io invidio tantissimo e mi chiedo ancora perché non siano multimiliardari e nessuno li abbia chiamati da Stoccolma per il Nobel – la verità è che nessuno sa davvero come fare.
Se investi nel mercato, del mercato ti prendi le belle e le brutte stagioni.
Come nella vita vera, impari a convivere con l’inverno, la pioggia e il freddo, non è che smetti di vivere per tre mesi perché ti piacciono solo le altre 3 stagioni.
Ma perché facciamo questo?
Perché sarà maledettamente difficile mantenere la rotta proprio nei momenti più critici, quando mantenere la rotta diventerà ancora più importante?
Perché razionalmente sappiamo cosa fare, ma l’emotività potrebbe prendere il sopravvento?
Perché non fa parte della nostra natura attendere con pazienza che i mercati facciano il loro corso naturale?
La risposta a queste ultime due domande in particolare la danno i prossimi 2 aforismi di questo capitolo.
Numero 2: Le emozioni possono prevalere su qualunque livello di intelligenza.
E
Numero 3: La maggior parte degli errori finanziari arrivano quando si cerca di forzare le cose ad andare più velocemente del dovuto. Al rendimento composto non piace quando provi a barare. Non avere FOMO potrebbe essere la competenza più importante quando si investe.
Le ho messe assieme perché sono due modi di vedere la stessa cosa.
Noi siamo impazienti per natura.
E vogliamo “fare qualcosa” nel tentativo di accelerare il decorso di un fenomeno di cui ci interessa il risultato finale.
Messe insieme queste due nostre attitudini compongono una combinazione esplosiva.
La FOMO nei momenti positivi e il suo alter-ego la FOL, la fear of losing, che si presenta nei momenti negativi, rappresentano esattamente il trionfo delle emozioni sulla ragione.
Ed entrambe queste emozioni rappresentano delle forze centrifughe che ci portano alla deriva rispetto al corso che dovrebbero avere i nostri investimenti.
Quello che invece siamo più portati a fare è seguire l’eccesso di fiducia quando le cose vanno bene, dimenticarci perché è importante ribilanciare, farci prendere dal panico quando i mercati crollano, dimenticarsi nuovamente perché è importante ribilanciare e via all’infinito finché non combiniamo tutti i disastri possibili e immaginabili.
E questa non è una prerogativa di investitori stupidi.
Questa è la prerogativa di tutti noi – e forse soprattutto di chi è più competente e intelligente e quindi comprensibilmente cerca di sfruttare le proprie capacità per trarne un vantaggio competitivo.
Ma i mercati finanziari sono dei grandi equalizzatori.
Non guardano in faccia a nessuno e puniscono quasi chiunque provi ad accelerare i suoi processi naturali e a dribblare le sue dinamiche meno piacevoli.
La duplice decisione di stare nella media e di rimanere nella media anche quando le cose vanno male sarà quindi per la maggior parte di noi comuni mortali il modo per essere, in effetti, degli investitori sopra la media.
Ultimo aforisma, perfetta conclusione di quello che abbiamo detto e una delle mie frasi preferite di Housel, una delle più memorabili e decisamente uno dei più potenti principi guida che qualunque individuo adulto percettore di un reddito e con una minima capacità di risparmio dovrebbe fare proprio.
La maggior parte delle persone possono permettersi di non essere grandi investitori, ma non possono permettersi di essere dei cattivi investitori.
Boom, la mia arma segreta quando mi trovo all’angolo in qualche conversazione senza speranza con ottusi scettici nei confronti di ciò che vado predicando.
Possiamo permetterci non di essere grandi investitori:
Non dobbiamo puntare ad essere delle superstar della finanza
Non dobbiamo cercare di prevedere il corso futuro dei mercati
Non dobbiamo evitare i momenti di crollo
Seguendo Napoleone, dobbiamo fare di tutto per essere nella media e rimanere nella media.
Ma proprio per questo, proprio perché il miglior consiglio di base che si può dare al comune risparmiatore è di investire puntando alla media e non all’eccellenza
Non possiamo permetterci di essere cattivi investitori:
Non dobbiamo farci prendere dalla FOMO e dalla FOL
Non dobbiamo peccare di eccessiva sicurezza
Non dobbiamo prenderci più rischi di ciò che abbiamo previsto all’interno di una pianificazione di buon senso, consapevolmente coraggiosa e non ingenuamente spregiudicata.
Investire è troppo importante per la nostra vita.
E’ la ricetta per farlo bene è nota.
Non siamo fatti per investire.
Ma proprio per questo, non possiamo permetterci di non farlo.
Fine amici miei.
Grazie alla partecipazione involontaria di Morgan Housel che sta facendo troppe interviste e per ora a The Bull non riesce a venire, ma vedrete che prima o poi riusciremo ad averlo con noi.
Spero che quest’episodio un po’ particolare vi sia piaciuto – e anche se non vi è piaciuto come minimo vi siete portati a casa una sfilza di frasi ad effetto che vi faranno sembrare più smart con amici, parenti e conoscenti quando parlerete con loro di finanza e la conversazione si incaglia.
Come sempre a questo punto arrivati vi invito a mettere segui e attivare le notifiche su Spotfy, apple podcast e iscrivervi al canale YouTube per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che potrei lasciare una linea di cioccolatini con la nocciola dentro e un sacco di frasi ad effetto fuori sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento assieme, sempre qui naturalmente con The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Recensioni
Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!
Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.
Andrea V., 22 Set 2025Riccardo mi ha letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire che amo la finanza, ho ascoltato il podcast già due volte e non mi stufo mai di ascoltarlo, parla in modo semplice e chiaro
Massimo D., 23 Set 2025Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva
Gianluca G., 11 Set 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!
Luca G. 10 Ott 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai
Francesca B., 6 Apr 2024Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente
Amalia A., 17 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.
Lorenzo, 13 Mar 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!
Massimiliano, 29 Mag 2024Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.
Giulia N., 11 Ago 2025