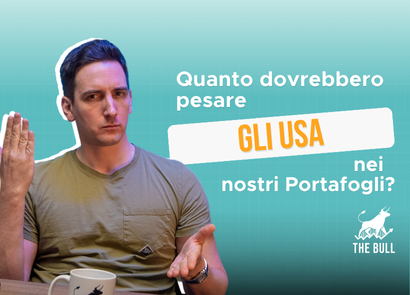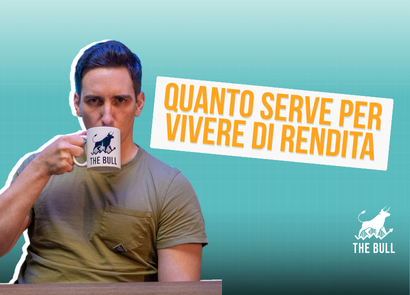La domanda più importante di tutte: quanto investire in azioni
La domanda più importante di tutte: quanto del proprio patrimonio investire in azioni? In questa puntata spieghiamo come bilanciare rischio, rendimento e orizzonte temporale per definire la giusta quota di azioni nel proprio portafoglio. Una guida pratica basata sulla teoria del portafoglio di Merton e adattata alla realtà dell’investitore comune.
Risorse
Punti Chiave
La domanda fondamentale è: quanto investire in azioni per massimizzare l'utilità della ricchezza nel tempo (Equity Allocation).
L'approccio dinamico adatta la quota azionaria alle variazioni nei rendimenti attesi (inversamente correlati ai prezzi attuali).
La formula di Merton (Merton Share) fornisce un modello per ottimizzare la quota azionaria, bilanciando rendimento atteso, volatilità e profilo di rischio soggettivo.
Contenuti del video
- 00:00 Quanto investire in azioni
- 01:20 La domanda fondamentale
- 02:40 Approccio statico
- 07:00 Approccio dinamico
- 07:33 La “prevedibilità dei rendimenti futuri”
- 15:10 La formula di Merton
- 18:30 Determinare i rendimenti attesi
- 22:51 Determinare il rischio oggettivo
- 24.25 Determinare il nostro profilo di rischio
- 28:20 Il ruolo del capitale umano
- 30:15 Quando variare il portafoglio in base ai rendimenti attesi
- 37:45 Conclusioni
- 00:00 Quanto investire in azioni
- 01:20 La domanda fondamentale
- 02:40 Approccio statico
- 07:00 Approccio dinamico
- 07:33 La “prevedibilità dei rendimenti futuri”
- 15:10 La formula di Merton
- 18:30 Determinare i rendimenti attesi
- 22:51 Determinare il rischio oggettivo
- 24.25 Determinare il nostro profilo di rischio
- 28:20 Il ruolo del capitale umano
- 30:15 Quando variare il portafoglio in base ai rendimenti attesi
- 37:45 Conclusioni
Trascrizione Video
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale
Se dovessi dire qual è il video che contiene il concetto più importante di tutti per un investitore — diciamo — fatto e finito, beh direi che il video è questo.
Quindi: fortunelli che lo state guardando.
Non che senza di esso tutto il resto non starebbe in piedi.
LA DOMANDA FONDAMENTALE
Però c’è una domanda a cui bisogna rispondere prima di cominciare ad investire che è molto più importante di qualunque altra — ossia: QUANTO DEL MIO RISPARMIO VOGLIO, POSSO, DEVO INVESTIRE IN AZIONI?
Con un po’ di esagerazione potremmo dire che tutte le decisioni di asset allocation, tutto ciò che mi porta a dire “il mio portafoglio avrà un po’ di questo, un po’ di quello e un po’ di quell’altro” è una conseguenza di questa prima decisione fondamentale.
In altri termini la domanda delle domande è: quanto del mio risparmio posso permettermi di mettere a rischio per massimizzare l’utilità della mia ricchezza nel tempo.
Il problema però è che questa si può prendere usando due approcci:
– Uno statico, cioè prendo un portafoglio e lo tengo più o meno stabile nel tempo, adattandolo magari unicamente all’avanzare dell’età — quando andò via via a ridurre la quota di azioni
– L’altro invece è dinamico, è si base sull’idea che il nostro portafoglio dovrebbe massimizzare la nostra esposizione alla sua parte più rischiosa nel continuum della nostra vita, durante la quale ci sono tante variabili che cambiano:
– Alcune riguardano il mercato, come ed esempio i rendimenti attesi o i tassi di interesse;
– Alcune sono invece soggettive, come la nostra tolleranza al rischio e all’orizzonte temporale die nostri obiettivi;
– Altre ancora hanno a che fare con aspetto non strettamente finanziari, ma per esempio con il nostro capitale umano e la nostra salute.
Questo secondo approccio, chiaramente più complesso, mira però a costruire un portafoglio che cerca di ottimizzare non solo il rendimento aggiustato per il rischio in un certo momento x, come nella teoria finanziaria classica, ma di ottimizzare la mia creazione di ricchezza nel tempo in relazione alle esigenze di consumo a lungo termine della mia vita e in base a come cambiano le variabili che dicevamo prima.
Sì lo so sembra che sto facendo una supercazzola ma, tranquilli, tra meno di mezz’ora sarà tutto perfettamente chiaro e molto molto pratico — con tanto di file da scaricare.
APPROCCIO STATICO
Mettiamola così.
Quando si inizia a comprendere il mondo della finanza personale, non c’è niente di meglio del framework classico dell’investimento passivo, quello portato avanti da mostri sacri come Burton Malkiel, Charles Ellis, Rick Ferri, William Bernstein, Jason Zweig, Jeremy Siegel e via dicendo.
In quello che dicono questi giganti c’è già compreso forse il 90% di quel che è opportuno sapere sull’investimento di buon senso:
– Usa strumenti indicizzati a basso costo come index fund e ETF
– Adatta l’asset allocation al tuo profilo di rischio e generalmente all’età
– Continua a investire in maniera costante in tutte le condizioni di mercato per tutta la vita
– Ribilancia periodicamente per mantenere l’asset allocation allineata alla tua pianificazione evitando che il portafoglio drifti troppo, tipicamente verso l’azionario.
Se schiatto domani, fate scrivere questo sulla mia lapide a futura memoria.
Faccio fatica ad immaginarmi una serie di consigli generali più di buon senso.
Per quale investitore va bene quest’approccio?
Diciamo che quello che ho appena detto è probabilmente tutto ciò che vi serve sapere se rientrate in uno di questi 4 casi:
– Se vuoi dedicare al tuo portafoglio il minor tempo possibile;
– Se hai un capitale investito ancora piuttosto contenuto, di poche decine di migliaia di euro;
– Se la quota di investimento mensile incide ancora tanto sul capitale totale — e quindi conta di più quanto risparmi e investi di quanto sia ben ottimizzato il portafoglio; o infine
Attenzione che questo è il discorso si fa un filo più tecnico — ma è il cuore di tutto
– Se non rientri in uno dei tre casi sopra ma pensi che il premio al rischio del mercato azionario sia costante, cioè che il rendimento in eccesso delle azioni rispetto ad esempio ai titoli di stato ad alto rating come Bund o Treasuries, sia uniforme nel tempo — ecco allora che un portafoglio statico, tipo 60/40, golden butterfly o quello che volete, catturerà in media tutto il rendimento che c’è da prendersi sul mercato.
Se invece si pensa che il premio al rischio vari nel tempo, nel corso delle diverse fasi dei cicli di mercato, allora le cose cambiano perché io investitore vorrò sempre adattare la quantità di rischio a cui mi espongo investendo in azioni in base ai rendimenti attesi nel futuro; per fare questo sarò portato ad adottare un’asset allocation dinamica.
Attenzione che questa non è una pippa teorica per soddisfare i perversi desideri di chi come me si emoziona leggendo un paper di finanza — no no no! — in base al punto di vista su questo argomento cambierà in maniera significativa il modo in cui gestirai il tuo portafoglio.
Attenzione però a non cadere in un facile fraintendimento: l’idea di gestire in maniera dinamica l’asset allocation del portafoglio non ha nulla a che fare con il market timing.
– Market timing si basa su decisioni idiosincratiche, specifiche, che presuppongono il fatto che il mercato stia prezzando male qualcosa e quindi che io ne possa approfittare. Ma ciò richiede che io sappia qualcosa che il mercato non sa o che sia mediamente più smart della media degli altri investitori. Breve memorandum: la maggior parte delle persone NON E’ meglio della media. Pensi di essere meglio della media degli investitori? Forse sì, ma la probabilità di base è che non lo sei. Senza offesa eh…
– Gestione dinamica significa invece prendere decisioni sistematiche, basate su regole, che riflettono la variazione dei rendimenti attesi nel futuro. Questo non richiede essere più smart della media, ma assumere una prospettiva di lungo termine e un atteggiamento che il più delle volte non sarà quello dell’investitore medio. In qualche modo — come capiremo a breve — l’approccio dinamico richiede più pazienza, più disciplina, una qualche comprensione della teoria finanziaria e soprattutto molta resistenza alle mode che in certe fasi dilagano sui mercati.
Come dire: se la gestione dinamica dà un vantaggio in termini di rendimento atteso del portafoglio, questo vantaggio non è gratis, ma il prezzo è soprattutto comportamentale.
Cmq teniamo buona solo la prima parte del concetto, cioè Gestione dinamica del portafoglio NON E’ market timing.
APPROCCIO DINAMICO
La spiegazione arriva tra poco.
Come abbiamo citato i sostenitori del passive investing duro e puro, cito alcuni eminenti personaggi di spicco che invece credono fermamente, supportati dai dati, che il premio al rischio sia variabile e che quindi abbia senso una gestione dinamica del portafoglio. Alcuni esempi sono Cliff Asness e Antti Ilmanen di AQR, Victor Haghani, Meb Faber, Rob Arnott e se andiamo nel mondo accademico abbiamo i nostri amici John Cochrane e John Campbell, Robert Shiller, Richard Thaler, Andrei Shleifer e, per certi versi, lo stesso Gene Fama.
LA “PREVEDIBILITÀ DEI RENDIMENTI FUTURI”
Già in un paper del 1988 Fama e French mostrarono che il rapporto tra prezzi e dividendi (o tra prezzi e utili) è inversamente correlato con i rendimenti futuri.
Nello stesso numero del Journal of Finance del 1988, Poterba e Summers mostrarono che
Le variazioni nel rapporto tra prezzi e utili “predicono”, tra molte virgolette, che nel breve termine i mercati tendono a seguire dei trend, cioè sono autocorrelati positivamente: se sono cresciuti continuano a crescere per un po’, se sono scesi continuano a scendere per unpo’, mentre nel lungo termine sono autocorrelati negativamente: dopo anni di rendimenti elevati seguono anni di rendimenti mediocri e viceversa.
È stata poi decisiva la ricerca di John Campbell, Robert Shiller e John Cochrane, per citare i più importanti, che ha chiarito una cosa fondamentale: quando noi investiamo in un asset, un’azione, un’obbligazione o quant’altro che produce flussi di reddito, l’andamento futuro del suo prezzo sarà determinato sempre da due componenti:
– Da come variano appunto i flussi di cassa che riceverà l’investitore, come per esempio quanti dividendi mi aspetto di ricevere in futuro grazie ai profitti che farà la società e
– Da come variano i tassi di sconto — o per dirla in un modo più semplice: da come variano i rendimenti richiesti dagli investitori per accettare di investire in quella roba lì a un certo determinato prezzo.
Se vi ricordate, se ci chiediamo, quanto “vale” un’azione?
Noi in realtà ci stiamo chiedendo: quanto sono disposto a pagare una certa azione in cambio del flusso di redditi che mi promette.
La risposta astratta è sempre questa
Ma che poi in pratica vuol dire che devo prendere i flussi di reddito che mi aspetto di ricevere nel futuro e “scontarli” nel presente, cioè dire: quanto valgono OGGI quei soldi che FORSE, assumendomi un certo rischio più o meno grande, riceverò domani?
Fino agli anni ’80 si pensava che i prezzi delle azioni sui mercati si muovessero soprattutto in base a come cambiavano le aspettative degli investitori rispetto ai flussi di cassa futuri.
La società farà più utili? Bene, allora sarò disposto a pagarla di più.
La società farà meno utili? Mmmh, non bene per acquistare la sua azione voglio pagarla di meno.
Giusto? Ha senso no?
Cioè si pensava che fossero le variazioni nella capacità di una certa società di generare utili nel futuro — e quindi di pagare dividendi — che determinava le variazioni dei prezzi.
Cioè il numeratore della formula
In realtà è poi saltato fuori che questa cosa incide molto poco.
Quello che conta molto di più è invece il denominatore, il tasso di sconto
Cioè quello che muove davvero i mercati non è tanto quanto pagherà una certa azienda in dividendi nel futuro, ma quanto vale OGGI un certo flusso di dividendi futuri.
E questa roba si può tradurre con: qual è il rendimento medio richiesto dagli investitori OGGI per investire in un certo asset.
Perché a volte vale di più e a volte di meno?
Perché a volte i prezzi salgono e altre volte scendono?
Ci sono varie interpretazioni, alcune più razionali, altre più comportamentali.
In generale diciamo che è un mix delle due cose:
– Quando gli investitori sono molto ottimisti, percepiscono un basso rischio nell’investire o semplicemente sono tutti pecoroni e seguono la moda del momento, allora i prezzi salgono perché il rendimento richiesto per investire diminuisce: accetterò di pagare di più per lo stesso flusso di redditi futuri.
– Quando invece sono pessimisti, percepiscono un alto rischio o sono sempre pecoroni però al contrario, se la fanno tutti sotto uno più dell’altro, allora i prezzi scendono perché il rendimento richiesto per investire aumenta: accetterò un certo flusso di redditi ad un prezzo inferiore.
Guardate questo grafico
La linea azzurra è l’andamento dell’S&P 500 negli ultimi 10 anni.
Quella nera è l’andamento degli utili attesi nei 12 mesi successivi in ciascun punto.
Vedete che vanno ovviamente nella stessa direzione, ma il prezzo dell’S&P 500 si muove molto di più.
Sono i tassi di sconto, ossia le variazioni nei rendimenti attesi, dei rendimenti richiesti dalla media degli investitori in ogni fase di mercato a determinare l’andamento del mercato stesso, non tanto le variazioni degli utili futuri.
Ora, che ci frega di tutta sta roba potreste chiedermi?
Beh, questa roba in realtà fondamentale perché ci dice due cose molto importanti:
– La prima è che i rendimenti attesi dell’investimento azionario variano nel tempo, non sono fissi;
– La seconda è che variano in maniera relativamente prevedibile — perlomeno su cicli lunghi. Gli utili futuri generati dalle società quotate non è che variano così tanto. Noi sappiamo invece che variano di parecchio i tassi di sconto, i rendimenti richiesti, e che lo fanno secondo uno schema ricorrente:
– Nel breve hanno un’autocorrelazione positiva, cioè creano dei trend di crescita o di declino;
– Nel medio-lungo termine hanno invece un’autocorrelazione negativa, cioè regrediscono verso la media.
I prezzi salgono salgono salgono sempre di più finché il rendimento atteso diventa bassissimo e poi ad un certo punto puff, per qualche motivo iniziano a scendere scendere scendere sempre di più finché il rendimento atteso diventa altissimo e via con un nuovo giro.
La storia dei mercati è la storia di quest’alternanza.
E il Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio inventato da Bob Shiller e da John Campbell negli anni ’80 spiega questa cosa molto bene.
Vedete?
Man mano che i prezzi rispetto agli utili salgono — che è la linea arancione — minori sono i rendimenti dei 10 anni successivi (linea blu). E viceversa.
Ovviamente per far venire la stessa forma ai due andamenti ho messo i rendimenti futuri al contrario, negativi in alto e positivi in basso.
Regia facciamo vedere un’altra volta il grafico.
Ok visto?
La parte a destra è al contrario.
Alla fine degli anni ’80 i prezzi erano bassi e i rendimenti degli anni 90 sono stati pazzeschi. Nel 1999 i prezzi erano folli e i rendimenti degli anni 2000 sono stati un disastro, addirittura negativi. I prezzi poi nel 2009 sono tornati di nuovo molto bassi e i rendimenti degli anni 2010 fantastici.
Oggi?
Boh…
Oggi con le azioni americane siamo qui
Non ancora al picco del 2000 ma poco ci manca.
Questo non vuol dire assolutamente né che non si possa superare quel picco, né che ci aspetta un decennio perduto.
Ma ci dice semplicemente che i rendimenti futuri saranno probabilmente più bassi, perché molto banalmente i prezzi sono via via cresciuti di più di quanto non siano cresciuti i profitti.
Ora, in questo podcast noi professiamo in lungo e in largo l’utilizzo di strumenti indicizzati, passivi tra molte virgolette, come gli ETF.
Strumenti che copiano il mercato.
E da qui non si scappa.
Ma un conto è usare uno strumento passivo.
Un conto è prendere decisioni su: a quali mercati ci esponiamo e quanto.
È questa invece non è un’adozione passiva, ma una decisione dinamica basata su regole perlopiù indipendenti dal nostro punto di vista soggettivo.
L’approccio dinamico alla costruzione del portafoglio si basa quindi sull’utilizzo di regole sistematiche per adattare l’asset allocation nel tempo.
LA FORMULA DI MERTON
Se ci pensate, già due anni fa, quando introdussi la formula di The Bull già c’era questa idea dietro.
Cosa dice la regola di The bull?
Durante la fase di accumulo investi in azioni una percentuale del portafoglio equivalente a
125 — i tuoi anni — il tasso risk-free moltiplicato per 5
L’idea era aumentare l’esposizione azionaria con tassi bassi e alzarla con tassi alti, perché intuitivamente mi sembrava più sensato che il premio al rischio fosse variabile nel tempo e che quindi avesse senso adattare il portafoglio di conseguenza.
La regola di The Bull è però incompleta perché non tiene conto di due cose:
– Di come variano i rendimenti attesi del mercato azionario (o meglio, ne tiene conto solo in parte considerando i tassi di interesse che salgono e scendono);
– E poi non tiene conto del mio profilo di rischio soggettivo che ha un ruolo importante nelle mie decisioni di asset allocation.
Nel 1969 il premio Nobel Rober Merton pubblicò questo paper
e arrivò ad una bellissima formula di asset allocation che superava i limiti della teoria moderna del portafoglio e del CAPM, che erano modelli molto astratti e generici, e forniva un modello per ottimizzare l’asset allocation dell’investitore tenendo conto delle tre variabili che dicevamo prima:
– Il rendimento atteso dal mercato azionario, aggiustato per il rischio
– Il mio personale profilo di rischio e
– Il valore della parte non finanziaria del mio capitale, ossia il mio capitale umano.
Attenzione che l’obiettivo non era ottimizzare il rendimento del portafoglio, ma ottimizzare il portafoglio in modo continuo nel tempo per massimizzare la sua utilità per me come investitore nel corso della vita.
E ovviamente per fare questo bisogna anche tenere in considerazione aspetti soggettivi che determinano quanto rischio posso permettermi di prendere in ciascuna fase.
La bellissima formula è questa qua:
che però poi è più generalmente nota così
Quanto dovremmo voler investire in azioni è dunque direttamente proporzionale al rendimento atteso dalle azioni in eccesso al tasso senza rischio e inversamente proporzionale al rischio del mercato azionario e al mio profilo di rischio soggettivo, aggiustato per gli aspetti non finanziari della mia vita, come il mio reddito, i miei debiti e il mio capitale umano
Adesso spieghiamo come funziona tutto l’ambaradan, poi alla fine vi faccio vedere come funziona un File in Google Sheet in cui potete divertirvi da soli a creare il vostro portafoglio ottimizzato a la Merton.
Come sempre, non mandatemi la richiesta di diventare editor, ogni volta che metto un file in condivisione ne ricevo centinaia.
Dovete scaricare una copia del file e poi lavorarci sopra.
Qual era l’idea della formula?
Adesso senza diventare pazzi con la parte matematica il ragionamento intuitivo dietro la formula per calcolare quanto della propria ricchezza totale è da investire in azioni è fatto di questo 4 step, ammettendo per esempio per semplicità che il nostro asset rischioso sia l’MSCI ACWI:
DETERMINARE I RENDIMENTI ATTESI
PRIMO STEP: qual è il rendimento atteso a lungo termine dell’MSCI ACWI? Ci sono tanti modi per stimarlo, ma un punto di partenza piuttosto comune è l’inverso del CAPE Ratio, noto come Cyclically Adjusted Earnings Yield (CAEY).
Se oggi il CAPE ratio dell’MSCI ACWI è un po’ più di 27, il suo inverso è 1/27 uguale 3,7%.
Questo dovrebbe essere il rendimento reale atteso futuro.
Ciò però presuppone un’assunzione semplificativa: corrisponderebbe al rendimento reale nel futuro se tutti gli utili venissero distribuiti come dividendi o se la parte non distribuita venisse reinvestita allo stesso tasso di rendimento.
In realtà tanti studi, come questo di Victor hagahni e James White
hanno mostrato che questo metodo tende a sottostimare i rendimenti attesi perché sottostima la capacità degli utili reinvestiti di far crescere i profitti della società nel tempo.
Va beh, non è importante capire più di tanto sta roba, il punto è sapere che è una metrica un po’ conservativa.
Ognuno si è inventato poi il suo metodo più o meno complicato per stimare i rendimenti futuri.
Per esempio uno dei più grandi hedge fund del mondo AQR usa questa formula
Ok non si capisce niente, anche se è più semplice di quel che sembra.
Però a noi frega il giusto essere così precisi, quindi facciamola breve.
Il rapporto prezzo utili possiamo guardarlo in tre modi:
– Uno è il rapporto tra il prezzo di oggi e gli utili degli ultimi 12 mesi, chiamato trailing P/E ratio — che però non se lo incla mai nessuno;
– Un altro è appunto il CAPE ratio, che fa prezzo diviso la media degli utili degli ultimi 12 anni aggiustata per inflazione, quindi è una metrica che guarda indietro nel passato; e
– Infine c’è il forward P/E ratio, cioè prezzo di oggi diviso gli utili attesi nei prossimi 12 mesi, che ovviamente è una misura che guarda al futuro.
Il CAPE, abbiamo, detto è conservativo per quel motivo tecnico di cui sopra.
Il forward P/E è invece solitamente molto ottimistico, perché gli analisti che stimano gli utili futuri sparano sempre un po’ troppo in alto.
Farei una salomonica via di mezzo.
Prendiamo l’MSCI ACWI.
Abbiamo detto che il CAPE Ratio è 28.
Il forward p/e ratio è invece circa 19 — ed un dato che si trova facilmente per esempio sul factsheet dell’indice
Molto semplicemente:
uno diviso 27 + 19 diviso 2 fa circa 4,35%
Vediamo AQR con la loro mega formula a che numero erano arrivati:
Va beh, dai, ci siamo andati molto vicini.
Comunque questa cosa è irrilevante, non è che dobbiamo calcolarla noi.
Possiamo usare un metodo alla buona così se vogliamo, come c’è nel file condiviso, altrimenti prendete le Capital Market Assumptions di società come AQR, Elm, oppure anche Vanguard, JP Morgan e così via e usate le loro.
Quindi diciamo che il rendimento reale atteso di lungo termine per l’MSCI ACWI è circa 4,3-4,4%.
SECONDO STEP: a noi interessa il rendimento in eccesso, quindi dobbiamo togliere il rendimento reale senza rischio.
Solitamente come stima del rendimento reale a lungo termine senza rischio si usano i TIPS americani, cioè i titoli di stato indicizzati all’inflazione.
Ma noi non stiamo investendo solo negli Stati uniti e negli altri Paesi il rendimento azionario in eccesso sarà legato al tasso senza rischio del proprio mercato.
Se facciamo una media ponderata tra il rendimento reale dei titoli di stato decennali americani, tedeschi, giapponesi e degli altri titoli di stato ad alto rating, in proporzione alla composizione geografica dell’MSCI ACWI, grosso modo esce fuori circa 1%.
Potremmo anche fare semplicemente TIPS meno i bund indicizzati all’inflazione e viene sempre fuori circa 1%. Ecco allora che abbiamo il rendimento in eccesso reale per il nostro asset rischioso, per l’azioni. 4,35-MENO 1% fa circa 3,35%. Facciamo che questo 3,4% è il valore che mettiamo al numeratore nella formula di Merton.
DETERMINARE IL RISCHIO OGGETTIVO
TERZO STEP: ci serve il rischio. Come sappiamo in finanza si usa la deviazione standard come misura del rischio. Molto semplicemente possiamo tornare alla scheda informativa dell’MSCI ACWI e vediamo che la deviazione standard degli ultimi 10 anni è stata intorno al 15%.
In realtà però nella formula di Merton al denominatore non ci va la deviazione standard, ma la varianza, cioè la deviazione standard al quadrato. Il motivo è tecnico e poco interessante, riguarda come è stata derivata la formula, però possiamo dire che il fatto intuitivo è questo.
Se io dico:
– Investo 30% del mio risparmio in azioni otterrò un certo rendimento; se investo il 60%, quindi il doppio, otterrò il doppio del rendimento;
– Ma se investo il doppio in azioni, il rischio non raddoppia, ma quadruplica, perché l’impatto sulla mia utilità marginale non è simmetrico: le perdite mi danneggiano di più dei guadagni.
Ok la spiegazione non è rigorosa, ma quella rigorosa ha un smitragliata di equazioni differenziali alle derivate parziali e non mi sembra il caso…
15% al quadrato fa 0,0225.
3,4% sopra come rendimento in eccesso reale e 0,0225 al denominatore come valore per il rischio. manca l’ultimo fondamentale passaggio, che è il
DETERMINARE IL NOSTRO PROFILO DI RISCHIO
QUARTO STEP: ossia determinare il quanto siamo avversi al rischio.
In pratica l’altro valore al denominatore, gamma, è un valore soggettivo che dice quanto diventa rischioso per me, singolo investitore e in base alle mie preferenze, investire in azioni.
Come dire: investire una certa quota del mio risparmio in un asset rischioso come le azioni non è rischioso solo per la loro volatilità, ma anche per le mie esigenze personali.
Anche qui, ci sarebbe tutta una disamina matematica da fare, ma in buona sostanza i valori più sensati da attribuire a gamma sono compresi tra 2 e 5, perché gli altri valori farebbero venir fuori delle quote azionarie o esageratamente sopra 100 o incredibilmente basse.
Vi mostro per esempio questa tabella che ho ricostruito io con la quota di azioni suggerita dalla formula per diversi rendimenti attesi e diversi valori di avversione al rischio, tenendo ferma la deviazione standard del 15% altrimenti dovevo fare un cubo di rubik.
Vedete che per valori inferiori a 2 praticamente uno dovrebbe investire con una leva esagerata in qualunque condizione di mercato.
Invece per valori superiori a 5 i portafogli diventano iperconservativi e più i valori sono alti, meno cambia.
Come facciamo però a sapere quale valore è giusto per me? Vi ricordate che diciamo sempre che il rischio ha tre facce:
– Il rischio che voglio prendermi, in base a quando lo sopporto psicologicamente;
– Il rischio che posso prendermi, in base al mio orizzonte temporale e infine
– Il rischio che devo prendermi, in base al rendimento che voglio ottenere per i miei obiettivi.
Io posso assegnare un valore da 2 a 5 a ciascuno di questi tre, dove 2 vuol dire: massima propensione al rischio e 5 minima propensione al rischio. Faccio la media ed ecco che ho anche l’ultimo elemento della mia formula.
– Sopporto bene anche un drawdown del 40-50%: metto 2; mi cago addosso se il portafoglio si muove del 10%? Metto 4 o 5;
– Ho un orizzonte temporale di vent’anni? 2; devo comprare casa tra 3 anni? 5;
– Ho bisogno di massimizzare il rendimento per i miei obiettivi? 2; preferisco spingere su reddito e risparmio? 5.
E tutte le varie vie di mezzo.
Mettendo tutto insieme, i valori che escono con coefficienti di avversione al rischio tra 2 e 5 sono grosso modo questi.
Ci sono alcuni valori sopra 100% e questo è possibilissimo perché nessuno vieta di investire a leva.
Ovviamente sono casi un po’ limite.
La formula suggerisce di andare oltre il 100% quando il rendimento reale in eccesso atteso è molto elevato, tipo durante una crisi economica importante o a seguito di un severo bear market e che allo stesso tempo l’investitore sia molto propenso a prendermi rischi.
È chiaro: a febbraio 2009, con il mondo in fiamme e i prezzi delle azioni sottoterra, chi aveva un lavoro solido, zero debiti e uno stomaco de fero avrebbe dovuto certamente investire anche ben più del 100% dei propri risparmi in azioni.
Oggi sarebbe ricco da fare schifo.
Ma quando il rendimento reale atteso è molto alto, solitamente nel mondo reale, fuori dai fogli excel, sta succedendo il finimondo e solo pochissimi se la sentono davvero di rischiare più di quello che hanno.
E qui veniamo all’ultimo punto.
Merton non ha pensato questa formula per trovare un’alternativa più ganza alla teoria del portafoglio di Markowitz.
Lui voleva trovare un metodo per modellare il portafoglio affinché massimizzasse la crescita della ricchezza lungo tutte le fasi della nostra vita, non semplicemente il rendimento per il rischio.
Nei paper successivi, come ad esempio,
E soprattutto in questo monumentale lavoro di John Campbell e Luis Viceira
IL RUOLO DEL CAPITALE UMANO
Si è cercato aggiungere il pezzo che mancava.
Diciamo solo che ci sarebbe un secondo pezzo da aggiungere alla formula di merton che, giusto per curiosità di qualche fanatico, si chiama intertemporal hedging demand, che è un’altra supercazzola matematica gigante per dire: ok io oggi ho la mia bella asset allocation, che so, 65% in azioni, buona lì. Ma come faccio a tenere conto di possibili variazioni future di alcuni fattori che sono determinanti per decidere quale sarà la forma ottimale del mio portafoglio?
Soprattutto Campbell e Viceira hanno provato a tirar fuori delle formule spaziali che tengano conto per esempio delle future variazioni dei tassi di interesse o di altre variabili macroeconomiche.
La cosa però davvero importante, e che Campbell aveva puntualizzato anche nell’intervista con noi era l’aspetto non finanziario del nostro capitale umano.
Questa cosa la accenno qui e basta perché come dicevo poi ci faremo episodi molto importanti più dettagliati.
Molto semplicemente il punto è:
– Con la formula di Merton trova il tuo punto di partenza;
– Poi però considera anche altri aspetti per capire se devi correggere al rialzo o al ribasso la tua quota di azioni in portafoglio:
– Caso migliore: sei giovane, con un lavoro stabile e poco debito, quindi il tuo capitale umano, il valore presente del tuo reddito netto futuro è molto alto. È come se avessi già un gigantesco bond. Spingi di più sulle azioni di quello che Merton direbbe.
– Caso peggiore: sei più avanti con l’età, hai un lavoro di natura imprenditoriale e un debito elevato. Praticamente la quota azionaria non è quella del portafoglio, ma è la tua vita reale. Il tuo portafoglio dovrebbe essere meno rischioso di quel che merton direbbe.
– Nei casi intermedi varranno correzioni soggettive
Questo è un aspetto molto importante e proveremo a dedicare una serie di episodi per capire come adattare in pratica il nostro portafoglio agli aspetti non finanziari della nostra vita.
Intuitivamente però si capisce già che il nostro reddito e il nostro debito deve sempre essere considerato nelle scelte di asset allocation.
QUANDO VARIARE IL PORTAFOGLIO IN BASE AI RENDIMENTI ATTESI
A sto punto chiudiamo con il discorso che avevo accennato all’inizio.
Ma mi conviene avere un asset allocation statica, tipo 60/40 per tutta la vita, o un’allocation dinamica, in cui di volta in volta decido il peso dell’azionario in base al rendimento atteso?
La risposta a questa domanda dipende dalla risposta ad una domanda che sta a monte e che nessuno ha dettagliato meglio di Antti Illmanen, di cui tra l’altro vi straconsiglio la bellissima serie di 7 paper che ha appena scritto sul tema del rendimento atteso e che si intitola Understanding Return Expectations.
Lui dice: ci sono due modi di guardare ai rendimenti futuri:
– Se pensiamo che il premio al rischio sia fisso, allora la nostra aspettativa dei rendimenti futuri di lungo termine non si discosterà molto dai rendimenti storici. Se l’azionario ha reso dal 5 al 7% reale un po’ in tutti i mercati sviluppati, allora continuerà a dare 5-7% reale anche in futuro, purché il mio orizzonte di investimento sia abbastanza lungo. Quasi nessuno però la pensa così e i dati empirici sembrano suggerire l’altra opzione, ossia che
– Il premio al rischio sia variabile nel tempo. In questo secondo caso non ha senso che guardi più di tanto ai rendimenti passati. Conviene guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi di oggi, ossia dal rapporto tra gli utili e i prezzi delle azioni, dall’earnings yield, comunque lo si voglia calcolare.
In pratica, l’idea è quella di considerare le azioni come se fossero dei bond.
Più i tassi di sconto scendono, ossia scendono i rendimenti richiesti dagli investitori, più i rendimenti futuri saranno inferiori, esattamente come succede con i bond mano che i tassi di interesse vanno giù.
Se così stanno le cose, un adattamento lento e progressivo della mia asset allocation in base a come si muovono i rendimenti attesi avrebbe certamente senso per massimizzare l’utilità complessiva del mio portafoglio.
Ovviamente è un modello lontanissimo dalla perfezione.
E come dicevamo all’inizio richiede moltissima pazienza e disciplina, perché in alcuni momenti va tendenzialmente in controtendenza.
Il mercato americano, nel momento che in cui sto registrando, continua a segnare un massimo dopo l’altro e io però al contrario considero di ridurre la mia quota azionaria invece che aumentarla.
È un approccio “contrarian” che mi aspetto possa pagare nel lungo termine, anche magari a costo di avere qualche grosso rimpianto nel breve.
È vero che la tipica obiezione è:
– I prezzi delle azioni americane sono molto alti perché le società americane, soprattutto quelle tech, generano fantastiliardi di dollari di profitto;
– Quelle europee, giapponesi, cinesi e così via invece costano poco perché sono profittevoli.
Però se è vero, come sembra dimostrato dalla ricerca accademica, che i mercati sono guidati per un terzo dalle variazioni nelle aspettative sugli utili e per due terzi, forse di più, dalle variazioni dei rendimenti attesi, dei tassi di sconto, allora a quell’obiezione si può rispondere così:
– negli Stati Uniti i prezzi sono così alti, perché sicuramente gli utili attesi nel futuro sono elevati, ma soprattutto perché i tassi di sconto oggi sono bassi, investire su quelle società è visto come poco rischioso e quindi gli investitori accettano un rendimento inferiore. Almeno fino alla prossima crisi.
– Al contrario, in Europa, Giappone e ancor di più nei Mercati emergenti i prezzi sono bassi sicuramente perché gli utili attesi sono inferiori, ma soprattutto perché i tassi di sconto sono più alti, investire lì oggi è visto come PIU’ rischioso e quindi gli investitori pretendono un rendimento superiore — cioè di pagare meno.
Se partiamo dall’assunzione che i mercati sono generalmente efficienti — o comunque più efficienti che no — le aspettative di crescita sono già in buona parte incorporate nei prezzi.
Quello che cambia, soprattutto, sono appunto i rendimenti futuri.
– Prezzi alti oggi vuol dire soprattutto ritorni più bassi domani
– E prezzi bassi oggi vuol dire soprattutto ritorno più alti domani.
Poi, che ciò sia dovuto a delle variazioni razionali nel livello di avversione al rischio del mercato, come direbbe Fama, o a delle aspettative irrazionali sugli utili futuri, come direbbero gli economisti comportamentali, questo è difficile da dire.
Però in effetti possiamo anche fregarcene del motivo, tenere buono il fatto che questa correlazione c’è e che eventualmente possiamo trarne delle conseguenze.
Vi avevo promesso un file però, no?
Eccolo qua.
Ho semplificato un file che avevo già condiviso mesi fa nel podcast, così da renderlo più intuitivo.
I valori da inserire sono tutti nelle celle gialle nella colonna B.
Basta inserire il forward P/E e il CAPE ratio del mercato di riferimento — e di default ho messo il mercato globale — e automaticamente il rendimento reale atteso viene calcolato facendo uno diviso la media ponderata dei due valori.
Anche il tasso risk-free reale è modificabile e il rendimento in eccesso delle azioni sarà il risultato di rendimento reale atteso meno tasso senza rischio.
La deviazione standard è impostata di default su 15%, ma ovviamente mettete quella che ritenete più opportuna.
Infine ci sono tre menu a tendina per scegliere i valori di gamma, in un range da 2 a 5 per ciascuno dei tre significati.
In automatico si compila l’asset allocation.
Non ho messo un campo specifico per il discorso del capitale umano.
Per il momento suggerisco di adattare i valori di gamma tenendo presente se il vostro reddito famigliare sia stabile o precario e se il valore presente netto del vostro reddito futuro è elevato o contenuto.
Ho infine messo la tabellina che vi ho mostrato prima per mostrarvi le diverse allocation per diversi valori di gamma e per diversi livelli di rendimento atteso.
Di default prende la deviazione standard che avete inserito nella cella B9.
That’s it.
Buon divertimento.
Un dubbio che potrebbe emergere è: ma se io voglio investire meno negli Stati Uniti e di più in altri mercati, non dovrei considerare diversi rendimenti attesi?
Teoricamente se voglio investire di più in Europa e Paesi emergenti, la mia esposizione azionaria dovrebbe essere maggiore.
Sì e no.
– Dal punto di vista teorico il modello di Merton parte dal portafoglio di mercato, quindi comunque sarebbe corretto partire da un indice market cap weighted che ne è la più vicina rappresentazione;
– Dal punto di vista matematico poi bisognerebbe calcolare la varianza tenendo conto anche della correlazione tra i vari mercati, che complica notevolmente il tutto;
– Infine, più a livello logico, se investo in mercati con maggior rendimento atteso, teoricamente anche il mio rischio atteso aumenta.
Come istruzione di massima direi:
– Determinare la quota di azioni partendo da un indice globale pesato per capitalizzazione e poi
– Adattare l’esposizione ai diversi mercati come uno preferisce.
CONCLUSIONI
Bene, tiriamo un po’ le somme dell’episodio che è stato bello intenso.
Takeaway di oggi:
– NUMERO UNO: portafolio lazy, set it and forget it, va benissimo e serve benissimo il 90% delle esigenze dell’investitore medio — e all’inizio abbiamo spiegato i 4 casi in cui ciò è la scelta di default.
– NUMERO DUE: per chi invece non rientra in quei 4 casi è possibile considerare un adattamento dinamico del portafoglio che tenga conto di regole sistematiche come la regola di Merton, senza per questo invocare il market timing o violare il quadro generale dell’efficienza del mercato.
– NUMERO TRE: se si considera che il premio al rischio del mercato varia nel tempo — qualunque sia il motivo — e che è soggetto a cicli di regressioni verso la media, allora più che guardare i rendimenti passati, ha senso guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi attuali e adattare l’esposizione azionaria di conseguenza. Valutazioni elevate implicano rendimenti futuri inferiori. Valutazioni più basse preludono, in teoria, a rendimenti futuri superiori. Il tutto a condizione di accettare il rischio che ciò implica e di avere molta pazienza e disciplina.
Come tutti i modelli, la formula di Merton è tutt’altro che perfetta — e ancora meno lo è quella di The Bull.
Ma credo sia un modello decisionale molto comodo per allineare il proprio portafoglio a criteri di buon senso, senza la pretesa di fare alcuna previsione di breve termine, ma adattando piuttosto la quantità di rischio assunto in base alla compensazione che ci si può aspettare di ottenere e alle esigenze della nostra vita.
Bene care amiche e cari amici di The Bull, spero che quest’episodio vi sia piaciuto, soprattutto a chi era tormentato dal dubbio che fare qualunque cosa di diverso rispetto ad avere il FTSE All World sarebbe stata un’infrazione delle supreme leggi dell’efficienza di mercato.
Scaricate il file, modificatelo a vostra uso e consumo e fatemi sapere che ne pensate.
Torneremo presto a parlarne anche con tanti altri ospiti.
Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare le notifiche per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che rispondono alle domande più importanti di tutte anche se magari nemmeno ve l’eravate poste sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi rivediamo nei prossimi video di questa playlist dedicata ai temi più importanti di asset allocation e portafogli, sempre qui, naturalmente con The Bull — il tuo podcast di finanza personale.
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale
Se dovessi dire qual è il video che contiene il concetto più importante di tutti per un investitore — diciamo — fatto e finito, beh direi che il video è questo.
Quindi: fortunelli che lo state guardando.
Non che senza di esso tutto il resto non starebbe in piedi.
LA DOMANDA FONDAMENTALE
Però c’è una domanda a cui bisogna rispondere prima di cominciare ad investire che è molto più importante di qualunque altra — ossia: QUANTO DEL MIO RISPARMIO VOGLIO, POSSO, DEVO INVESTIRE IN AZIONI?
Con un po’ di esagerazione potremmo dire che tutte le decisioni di asset allocation, tutto ciò che mi porta a dire “il mio portafoglio avrà un po’ di questo, un po’ di quello e un po’ di quell’altro” è una conseguenza di questa prima decisione fondamentale.
In altri termini la domanda delle domande è: quanto del mio risparmio posso permettermi di mettere a rischio per massimizzare l’utilità della mia ricchezza nel tempo.
Il problema però è che questa si può prendere usando due approcci:
– Uno statico, cioè prendo un portafoglio e lo tengo più o meno stabile nel tempo, adattandolo magari unicamente all’avanzare dell’età — quando andò via via a ridurre la quota di azioni
– L’altro invece è dinamico, è si base sull’idea che il nostro portafoglio dovrebbe massimizzare la nostra esposizione alla sua parte più rischiosa nel continuum della nostra vita, durante la quale ci sono tante variabili che cambiano:
– Alcune riguardano il mercato, come ed esempio i rendimenti attesi o i tassi di interesse;
– Alcune sono invece soggettive, come la nostra tolleranza al rischio e all’orizzonte temporale die nostri obiettivi;
– Altre ancora hanno a che fare con aspetto non strettamente finanziari, ma per esempio con il nostro capitale umano e la nostra salute.
Questo secondo approccio, chiaramente più complesso, mira però a costruire un portafoglio che cerca di ottimizzare non solo il rendimento aggiustato per il rischio in un certo momento x, come nella teoria finanziaria classica, ma di ottimizzare la mia creazione di ricchezza nel tempo in relazione alle esigenze di consumo a lungo termine della mia vita e in base a come cambiano le variabili che dicevamo prima.
Sì lo so sembra che sto facendo una supercazzola ma, tranquilli, tra meno di mezz’ora sarà tutto perfettamente chiaro e molto molto pratico — con tanto di file da scaricare.
APPROCCIO STATICO
Mettiamola così.
Quando si inizia a comprendere il mondo della finanza personale, non c’è niente di meglio del framework classico dell’investimento passivo, quello portato avanti da mostri sacri come Burton Malkiel, Charles Ellis, Rick Ferri, William Bernstein, Jason Zweig, Jeremy Siegel e via dicendo.
In quello che dicono questi giganti c’è già compreso forse il 90% di quel che è opportuno sapere sull’investimento di buon senso:
– Usa strumenti indicizzati a basso costo come index fund e ETF
– Adatta l’asset allocation al tuo profilo di rischio e generalmente all’età
– Continua a investire in maniera costante in tutte le condizioni di mercato per tutta la vita
– Ribilancia periodicamente per mantenere l’asset allocation allineata alla tua pianificazione evitando che il portafoglio drifti troppo, tipicamente verso l’azionario.
Se schiatto domani, fate scrivere questo sulla mia lapide a futura memoria.
Faccio fatica ad immaginarmi una serie di consigli generali più di buon senso.
Per quale investitore va bene quest’approccio?
Diciamo che quello che ho appena detto è probabilmente tutto ciò che vi serve sapere se rientrate in uno di questi 4 casi:
– Se vuoi dedicare al tuo portafoglio il minor tempo possibile;
– Se hai un capitale investito ancora piuttosto contenuto, di poche decine di migliaia di euro;
– Se la quota di investimento mensile incide ancora tanto sul capitale totale — e quindi conta di più quanto risparmi e investi di quanto sia ben ottimizzato il portafoglio; o infine
Attenzione che questo è il discorso si fa un filo più tecnico — ma è il cuore di tutto
– Se non rientri in uno dei tre casi sopra ma pensi che il premio al rischio del mercato azionario sia costante, cioè che il rendimento in eccesso delle azioni rispetto ad esempio ai titoli di stato ad alto rating come Bund o Treasuries, sia uniforme nel tempo — ecco allora che un portafoglio statico, tipo 60/40, golden butterfly o quello che volete, catturerà in media tutto il rendimento che c’è da prendersi sul mercato.
Se invece si pensa che il premio al rischio vari nel tempo, nel corso delle diverse fasi dei cicli di mercato, allora le cose cambiano perché io investitore vorrò sempre adattare la quantità di rischio a cui mi espongo investendo in azioni in base ai rendimenti attesi nel futuro; per fare questo sarò portato ad adottare un’asset allocation dinamica.
Attenzione che questa non è una pippa teorica per soddisfare i perversi desideri di chi come me si emoziona leggendo un paper di finanza — no no no! — in base al punto di vista su questo argomento cambierà in maniera significativa il modo in cui gestirai il tuo portafoglio.
Attenzione però a non cadere in un facile fraintendimento: l’idea di gestire in maniera dinamica l’asset allocation del portafoglio non ha nulla a che fare con il market timing.
– Market timing si basa su decisioni idiosincratiche, specifiche, che presuppongono il fatto che il mercato stia prezzando male qualcosa e quindi che io ne possa approfittare. Ma ciò richiede che io sappia qualcosa che il mercato non sa o che sia mediamente più smart della media degli altri investitori. Breve memorandum: la maggior parte delle persone NON E’ meglio della media. Pensi di essere meglio della media degli investitori? Forse sì, ma la probabilità di base è che non lo sei. Senza offesa eh…
– Gestione dinamica significa invece prendere decisioni sistematiche, basate su regole, che riflettono la variazione dei rendimenti attesi nel futuro. Questo non richiede essere più smart della media, ma assumere una prospettiva di lungo termine e un atteggiamento che il più delle volte non sarà quello dell’investitore medio. In qualche modo — come capiremo a breve — l’approccio dinamico richiede più pazienza, più disciplina, una qualche comprensione della teoria finanziaria e soprattutto molta resistenza alle mode che in certe fasi dilagano sui mercati.
Come dire: se la gestione dinamica dà un vantaggio in termini di rendimento atteso del portafoglio, questo vantaggio non è gratis, ma il prezzo è soprattutto comportamentale.
Cmq teniamo buona solo la prima parte del concetto, cioè Gestione dinamica del portafoglio NON E’ market timing.
APPROCCIO DINAMICO
La spiegazione arriva tra poco.
Come abbiamo citato i sostenitori del passive investing duro e puro, cito alcuni eminenti personaggi di spicco che invece credono fermamente, supportati dai dati, che il premio al rischio sia variabile e che quindi abbia senso una gestione dinamica del portafoglio. Alcuni esempi sono Cliff Asness e Antti Ilmanen di AQR, Victor Haghani, Meb Faber, Rob Arnott e se andiamo nel mondo accademico abbiamo i nostri amici John Cochrane e John Campbell, Robert Shiller, Richard Thaler, Andrei Shleifer e, per certi versi, lo stesso Gene Fama.
LA “PREVEDIBILITÀ DEI RENDIMENTI FUTURI”
Già in un paper del 1988 Fama e French mostrarono che il rapporto tra prezzi e dividendi (o tra prezzi e utili) è inversamente correlato con i rendimenti futuri.
Nello stesso numero del Journal of Finance del 1988, Poterba e Summers mostrarono che
Le variazioni nel rapporto tra prezzi e utili “predicono”, tra molte virgolette, che nel breve termine i mercati tendono a seguire dei trend, cioè sono autocorrelati positivamente: se sono cresciuti continuano a crescere per un po’, se sono scesi continuano a scendere per unpo’, mentre nel lungo termine sono autocorrelati negativamente: dopo anni di rendimenti elevati seguono anni di rendimenti mediocri e viceversa.
È stata poi decisiva la ricerca di John Campbell, Robert Shiller e John Cochrane, per citare i più importanti, che ha chiarito una cosa fondamentale: quando noi investiamo in un asset, un’azione, un’obbligazione o quant’altro che produce flussi di reddito, l’andamento futuro del suo prezzo sarà determinato sempre da due componenti:
– Da come variano appunto i flussi di cassa che riceverà l’investitore, come per esempio quanti dividendi mi aspetto di ricevere in futuro grazie ai profitti che farà la società e
– Da come variano i tassi di sconto — o per dirla in un modo più semplice: da come variano i rendimenti richiesti dagli investitori per accettare di investire in quella roba lì a un certo determinato prezzo.
Se vi ricordate, se ci chiediamo, quanto “vale” un’azione?
Noi in realtà ci stiamo chiedendo: quanto sono disposto a pagare una certa azione in cambio del flusso di redditi che mi promette.
La risposta astratta è sempre questa
Ma che poi in pratica vuol dire che devo prendere i flussi di reddito che mi aspetto di ricevere nel futuro e “scontarli” nel presente, cioè dire: quanto valgono OGGI quei soldi che FORSE, assumendomi un certo rischio più o meno grande, riceverò domani?
Fino agli anni ’80 si pensava che i prezzi delle azioni sui mercati si muovessero soprattutto in base a come cambiavano le aspettative degli investitori rispetto ai flussi di cassa futuri.
La società farà più utili? Bene, allora sarò disposto a pagarla di più.
La società farà meno utili? Mmmh, non bene per acquistare la sua azione voglio pagarla di meno.
Giusto? Ha senso no?
Cioè si pensava che fossero le variazioni nella capacità di una certa società di generare utili nel futuro — e quindi di pagare dividendi — che determinava le variazioni dei prezzi.
Cioè il numeratore della formula
In realtà è poi saltato fuori che questa cosa incide molto poco.
Quello che conta molto di più è invece il denominatore, il tasso di sconto
Cioè quello che muove davvero i mercati non è tanto quanto pagherà una certa azienda in dividendi nel futuro, ma quanto vale OGGI un certo flusso di dividendi futuri.
E questa roba si può tradurre con: qual è il rendimento medio richiesto dagli investitori OGGI per investire in un certo asset.
Perché a volte vale di più e a volte di meno?
Perché a volte i prezzi salgono e altre volte scendono?
Ci sono varie interpretazioni, alcune più razionali, altre più comportamentali.
In generale diciamo che è un mix delle due cose:
– Quando gli investitori sono molto ottimisti, percepiscono un basso rischio nell’investire o semplicemente sono tutti pecoroni e seguono la moda del momento, allora i prezzi salgono perché il rendimento richiesto per investire diminuisce: accetterò di pagare di più per lo stesso flusso di redditi futuri.
– Quando invece sono pessimisti, percepiscono un alto rischio o sono sempre pecoroni però al contrario, se la fanno tutti sotto uno più dell’altro, allora i prezzi scendono perché il rendimento richiesto per investire aumenta: accetterò un certo flusso di redditi ad un prezzo inferiore.
Guardate questo grafico
La linea azzurra è l’andamento dell’S&P 500 negli ultimi 10 anni.
Quella nera è l’andamento degli utili attesi nei 12 mesi successivi in ciascun punto.
Vedete che vanno ovviamente nella stessa direzione, ma il prezzo dell’S&P 500 si muove molto di più.
Sono i tassi di sconto, ossia le variazioni nei rendimenti attesi, dei rendimenti richiesti dalla media degli investitori in ogni fase di mercato a determinare l’andamento del mercato stesso, non tanto le variazioni degli utili futuri.
Ora, che ci frega di tutta sta roba potreste chiedermi?
Beh, questa roba in realtà fondamentale perché ci dice due cose molto importanti:
– La prima è che i rendimenti attesi dell’investimento azionario variano nel tempo, non sono fissi;
– La seconda è che variano in maniera relativamente prevedibile — perlomeno su cicli lunghi. Gli utili futuri generati dalle società quotate non è che variano così tanto. Noi sappiamo invece che variano di parecchio i tassi di sconto, i rendimenti richiesti, e che lo fanno secondo uno schema ricorrente:
– Nel breve hanno un’autocorrelazione positiva, cioè creano dei trend di crescita o di declino;
– Nel medio-lungo termine hanno invece un’autocorrelazione negativa, cioè regrediscono verso la media.
I prezzi salgono salgono salgono sempre di più finché il rendimento atteso diventa bassissimo e poi ad un certo punto puff, per qualche motivo iniziano a scendere scendere scendere sempre di più finché il rendimento atteso diventa altissimo e via con un nuovo giro.
La storia dei mercati è la storia di quest’alternanza.
E il Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio inventato da Bob Shiller e da John Campbell negli anni ’80 spiega questa cosa molto bene.
Vedete?
Man mano che i prezzi rispetto agli utili salgono — che è la linea arancione — minori sono i rendimenti dei 10 anni successivi (linea blu). E viceversa.
Ovviamente per far venire la stessa forma ai due andamenti ho messo i rendimenti futuri al contrario, negativi in alto e positivi in basso.
Regia facciamo vedere un’altra volta il grafico.
Ok visto?
La parte a destra è al contrario.
Alla fine degli anni ’80 i prezzi erano bassi e i rendimenti degli anni 90 sono stati pazzeschi. Nel 1999 i prezzi erano folli e i rendimenti degli anni 2000 sono stati un disastro, addirittura negativi. I prezzi poi nel 2009 sono tornati di nuovo molto bassi e i rendimenti degli anni 2010 fantastici.
Oggi?
Boh…
Oggi con le azioni americane siamo qui
Non ancora al picco del 2000 ma poco ci manca.
Questo non vuol dire assolutamente né che non si possa superare quel picco, né che ci aspetta un decennio perduto.
Ma ci dice semplicemente che i rendimenti futuri saranno probabilmente più bassi, perché molto banalmente i prezzi sono via via cresciuti di più di quanto non siano cresciuti i profitti.
Ora, in questo podcast noi professiamo in lungo e in largo l’utilizzo di strumenti indicizzati, passivi tra molte virgolette, come gli ETF.
Strumenti che copiano il mercato.
E da qui non si scappa.
Ma un conto è usare uno strumento passivo.
Un conto è prendere decisioni su: a quali mercati ci esponiamo e quanto.
È questa invece non è un’adozione passiva, ma una decisione dinamica basata su regole perlopiù indipendenti dal nostro punto di vista soggettivo.
L’approccio dinamico alla costruzione del portafoglio si basa quindi sull’utilizzo di regole sistematiche per adattare l’asset allocation nel tempo.
LA FORMULA DI MERTON
Se ci pensate, già due anni fa, quando introdussi la formula di The Bull già c’era questa idea dietro.
Cosa dice la regola di The bull?
Durante la fase di accumulo investi in azioni una percentuale del portafoglio equivalente a
125 — i tuoi anni — il tasso risk-free moltiplicato per 5
L’idea era aumentare l’esposizione azionaria con tassi bassi e alzarla con tassi alti, perché intuitivamente mi sembrava più sensato che il premio al rischio fosse variabile nel tempo e che quindi avesse senso adattare il portafoglio di conseguenza.
La regola di The Bull è però incompleta perché non tiene conto di due cose:
– Di come variano i rendimenti attesi del mercato azionario (o meglio, ne tiene conto solo in parte considerando i tassi di interesse che salgono e scendono);
– E poi non tiene conto del mio profilo di rischio soggettivo che ha un ruolo importante nelle mie decisioni di asset allocation.
Nel 1969 il premio Nobel Rober Merton pubblicò questo paper
e arrivò ad una bellissima formula di asset allocation che superava i limiti della teoria moderna del portafoglio e del CAPM, che erano modelli molto astratti e generici, e forniva un modello per ottimizzare l’asset allocation dell’investitore tenendo conto delle tre variabili che dicevamo prima:
– Il rendimento atteso dal mercato azionario, aggiustato per il rischio
– Il mio personale profilo di rischio e
– Il valore della parte non finanziaria del mio capitale, ossia il mio capitale umano.
Attenzione che l’obiettivo non era ottimizzare il rendimento del portafoglio, ma ottimizzare il portafoglio in modo continuo nel tempo per massimizzare la sua utilità per me come investitore nel corso della vita.
E ovviamente per fare questo bisogna anche tenere in considerazione aspetti soggettivi che determinano quanto rischio posso permettermi di prendere in ciascuna fase.
La bellissima formula è questa qua:
che però poi è più generalmente nota così
Quanto dovremmo voler investire in azioni è dunque direttamente proporzionale al rendimento atteso dalle azioni in eccesso al tasso senza rischio e inversamente proporzionale al rischio del mercato azionario e al mio profilo di rischio soggettivo, aggiustato per gli aspetti non finanziari della mia vita, come il mio reddito, i miei debiti e il mio capitale umano
Adesso spieghiamo come funziona tutto l’ambaradan, poi alla fine vi faccio vedere come funziona un File in Google Sheet in cui potete divertirvi da soli a creare il vostro portafoglio ottimizzato a la Merton.
Come sempre, non mandatemi la richiesta di diventare editor, ogni volta che metto un file in condivisione ne ricevo centinaia.
Dovete scaricare una copia del file e poi lavorarci sopra.
Qual era l’idea della formula?
Adesso senza diventare pazzi con la parte matematica il ragionamento intuitivo dietro la formula per calcolare quanto della propria ricchezza totale è da investire in azioni è fatto di questo 4 step, ammettendo per esempio per semplicità che il nostro asset rischioso sia l’MSCI ACWI:
DETERMINARE I RENDIMENTI ATTESI
PRIMO STEP: qual è il rendimento atteso a lungo termine dell’MSCI ACWI? Ci sono tanti modi per stimarlo, ma un punto di partenza piuttosto comune è l’inverso del CAPE Ratio, noto come Cyclically Adjusted Earnings Yield (CAEY).
Se oggi il CAPE ratio dell’MSCI ACWI è un po’ più di 27, il suo inverso è 1/27 uguale 3,7%.
Questo dovrebbe essere il rendimento reale atteso futuro.
Ciò però presuppone un’assunzione semplificativa: corrisponderebbe al rendimento reale nel futuro se tutti gli utili venissero distribuiti come dividendi o se la parte non distribuita venisse reinvestita allo stesso tasso di rendimento.
In realtà tanti studi, come questo di Victor hagahni e James White
hanno mostrato che questo metodo tende a sottostimare i rendimenti attesi perché sottostima la capacità degli utili reinvestiti di far crescere i profitti della società nel tempo.
Va beh, non è importante capire più di tanto sta roba, il punto è sapere che è una metrica un po’ conservativa.
Ognuno si è inventato poi il suo metodo più o meno complicato per stimare i rendimenti futuri.
Per esempio uno dei più grandi hedge fund del mondo AQR usa questa formula
Ok non si capisce niente, anche se è più semplice di quel che sembra.
Però a noi frega il giusto essere così precisi, quindi facciamola breve.
Il rapporto prezzo utili possiamo guardarlo in tre modi:
– Uno è il rapporto tra il prezzo di oggi e gli utili degli ultimi 12 mesi, chiamato trailing P/E ratio — che però non se lo incla mai nessuno;
– Un altro è appunto il CAPE ratio, che fa prezzo diviso la media degli utili degli ultimi 12 anni aggiustata per inflazione, quindi è una metrica che guarda indietro nel passato; e
– Infine c’è il forward P/E ratio, cioè prezzo di oggi diviso gli utili attesi nei prossimi 12 mesi, che ovviamente è una misura che guarda al futuro.
Il CAPE, abbiamo, detto è conservativo per quel motivo tecnico di cui sopra.
Il forward P/E è invece solitamente molto ottimistico, perché gli analisti che stimano gli utili futuri sparano sempre un po’ troppo in alto.
Farei una salomonica via di mezzo.
Prendiamo l’MSCI ACWI.
Abbiamo detto che il CAPE Ratio è 28.
Il forward p/e ratio è invece circa 19 — ed un dato che si trova facilmente per esempio sul factsheet dell’indice
Molto semplicemente:
uno diviso 27 + 19 diviso 2 fa circa 4,35%
Vediamo AQR con la loro mega formula a che numero erano arrivati:
Va beh, dai, ci siamo andati molto vicini.
Comunque questa cosa è irrilevante, non è che dobbiamo calcolarla noi.
Possiamo usare un metodo alla buona così se vogliamo, come c’è nel file condiviso, altrimenti prendete le Capital Market Assumptions di società come AQR, Elm, oppure anche Vanguard, JP Morgan e così via e usate le loro.
Quindi diciamo che il rendimento reale atteso di lungo termine per l’MSCI ACWI è circa 4,3-4,4%.
SECONDO STEP: a noi interessa il rendimento in eccesso, quindi dobbiamo togliere il rendimento reale senza rischio.
Solitamente come stima del rendimento reale a lungo termine senza rischio si usano i TIPS americani, cioè i titoli di stato indicizzati all’inflazione.
Ma noi non stiamo investendo solo negli Stati uniti e negli altri Paesi il rendimento azionario in eccesso sarà legato al tasso senza rischio del proprio mercato.
Se facciamo una media ponderata tra il rendimento reale dei titoli di stato decennali americani, tedeschi, giapponesi e degli altri titoli di stato ad alto rating, in proporzione alla composizione geografica dell’MSCI ACWI, grosso modo esce fuori circa 1%.
Potremmo anche fare semplicemente TIPS meno i bund indicizzati all’inflazione e viene sempre fuori circa 1%. Ecco allora che abbiamo il rendimento in eccesso reale per il nostro asset rischioso, per l’azioni. 4,35-MENO 1% fa circa 3,35%. Facciamo che questo 3,4% è il valore che mettiamo al numeratore nella formula di Merton.
DETERMINARE IL RISCHIO OGGETTIVO
TERZO STEP: ci serve il rischio. Come sappiamo in finanza si usa la deviazione standard come misura del rischio. Molto semplicemente possiamo tornare alla scheda informativa dell’MSCI ACWI e vediamo che la deviazione standard degli ultimi 10 anni è stata intorno al 15%.
In realtà però nella formula di Merton al denominatore non ci va la deviazione standard, ma la varianza, cioè la deviazione standard al quadrato. Il motivo è tecnico e poco interessante, riguarda come è stata derivata la formula, però possiamo dire che il fatto intuitivo è questo.
Se io dico:
– Investo 30% del mio risparmio in azioni otterrò un certo rendimento; se investo il 60%, quindi il doppio, otterrò il doppio del rendimento;
– Ma se investo il doppio in azioni, il rischio non raddoppia, ma quadruplica, perché l’impatto sulla mia utilità marginale non è simmetrico: le perdite mi danneggiano di più dei guadagni.
Ok la spiegazione non è rigorosa, ma quella rigorosa ha un smitragliata di equazioni differenziali alle derivate parziali e non mi sembra il caso…
15% al quadrato fa 0,0225.
3,4% sopra come rendimento in eccesso reale e 0,0225 al denominatore come valore per il rischio. manca l’ultimo fondamentale passaggio, che è il
DETERMINARE IL NOSTRO PROFILO DI RISCHIO
QUARTO STEP: ossia determinare il quanto siamo avversi al rischio.
In pratica l’altro valore al denominatore, gamma, è un valore soggettivo che dice quanto diventa rischioso per me, singolo investitore e in base alle mie preferenze, investire in azioni.
Come dire: investire una certa quota del mio risparmio in un asset rischioso come le azioni non è rischioso solo per la loro volatilità, ma anche per le mie esigenze personali.
Anche qui, ci sarebbe tutta una disamina matematica da fare, ma in buona sostanza i valori più sensati da attribuire a gamma sono compresi tra 2 e 5, perché gli altri valori farebbero venir fuori delle quote azionarie o esageratamente sopra 100 o incredibilmente basse.
Vi mostro per esempio questa tabella che ho ricostruito io con la quota di azioni suggerita dalla formula per diversi rendimenti attesi e diversi valori di avversione al rischio, tenendo ferma la deviazione standard del 15% altrimenti dovevo fare un cubo di rubik.
Vedete che per valori inferiori a 2 praticamente uno dovrebbe investire con una leva esagerata in qualunque condizione di mercato.
Invece per valori superiori a 5 i portafogli diventano iperconservativi e più i valori sono alti, meno cambia.
Come facciamo però a sapere quale valore è giusto per me? Vi ricordate che diciamo sempre che il rischio ha tre facce:
– Il rischio che voglio prendermi, in base a quando lo sopporto psicologicamente;
– Il rischio che posso prendermi, in base al mio orizzonte temporale e infine
– Il rischio che devo prendermi, in base al rendimento che voglio ottenere per i miei obiettivi.
Io posso assegnare un valore da 2 a 5 a ciascuno di questi tre, dove 2 vuol dire: massima propensione al rischio e 5 minima propensione al rischio. Faccio la media ed ecco che ho anche l’ultimo elemento della mia formula.
– Sopporto bene anche un drawdown del 40-50%: metto 2; mi cago addosso se il portafoglio si muove del 10%? Metto 4 o 5;
– Ho un orizzonte temporale di vent’anni? 2; devo comprare casa tra 3 anni? 5;
– Ho bisogno di massimizzare il rendimento per i miei obiettivi? 2; preferisco spingere su reddito e risparmio? 5.
E tutte le varie vie di mezzo.
Mettendo tutto insieme, i valori che escono con coefficienti di avversione al rischio tra 2 e 5 sono grosso modo questi.
Ci sono alcuni valori sopra 100% e questo è possibilissimo perché nessuno vieta di investire a leva.
Ovviamente sono casi un po’ limite.
La formula suggerisce di andare oltre il 100% quando il rendimento reale in eccesso atteso è molto elevato, tipo durante una crisi economica importante o a seguito di un severo bear market e che allo stesso tempo l’investitore sia molto propenso a prendermi rischi.
È chiaro: a febbraio 2009, con il mondo in fiamme e i prezzi delle azioni sottoterra, chi aveva un lavoro solido, zero debiti e uno stomaco de fero avrebbe dovuto certamente investire anche ben più del 100% dei propri risparmi in azioni.
Oggi sarebbe ricco da fare schifo.
Ma quando il rendimento reale atteso è molto alto, solitamente nel mondo reale, fuori dai fogli excel, sta succedendo il finimondo e solo pochissimi se la sentono davvero di rischiare più di quello che hanno.
E qui veniamo all’ultimo punto.
Merton non ha pensato questa formula per trovare un’alternativa più ganza alla teoria del portafoglio di Markowitz.
Lui voleva trovare un metodo per modellare il portafoglio affinché massimizzasse la crescita della ricchezza lungo tutte le fasi della nostra vita, non semplicemente il rendimento per il rischio.
Nei paper successivi, come ad esempio,
E soprattutto in questo monumentale lavoro di John Campbell e Luis Viceira
IL RUOLO DEL CAPITALE UMANO
Si è cercato aggiungere il pezzo che mancava.
Diciamo solo che ci sarebbe un secondo pezzo da aggiungere alla formula di merton che, giusto per curiosità di qualche fanatico, si chiama intertemporal hedging demand, che è un’altra supercazzola matematica gigante per dire: ok io oggi ho la mia bella asset allocation, che so, 65% in azioni, buona lì. Ma come faccio a tenere conto di possibili variazioni future di alcuni fattori che sono determinanti per decidere quale sarà la forma ottimale del mio portafoglio?
Soprattutto Campbell e Viceira hanno provato a tirar fuori delle formule spaziali che tengano conto per esempio delle future variazioni dei tassi di interesse o di altre variabili macroeconomiche.
La cosa però davvero importante, e che Campbell aveva puntualizzato anche nell’intervista con noi era l’aspetto non finanziario del nostro capitale umano.
Questa cosa la accenno qui e basta perché come dicevo poi ci faremo episodi molto importanti più dettagliati.
Molto semplicemente il punto è:
– Con la formula di Merton trova il tuo punto di partenza;
– Poi però considera anche altri aspetti per capire se devi correggere al rialzo o al ribasso la tua quota di azioni in portafoglio:
– Caso migliore: sei giovane, con un lavoro stabile e poco debito, quindi il tuo capitale umano, il valore presente del tuo reddito netto futuro è molto alto. È come se avessi già un gigantesco bond. Spingi di più sulle azioni di quello che Merton direbbe.
– Caso peggiore: sei più avanti con l’età, hai un lavoro di natura imprenditoriale e un debito elevato. Praticamente la quota azionaria non è quella del portafoglio, ma è la tua vita reale. Il tuo portafoglio dovrebbe essere meno rischioso di quel che merton direbbe.
– Nei casi intermedi varranno correzioni soggettive
Questo è un aspetto molto importante e proveremo a dedicare una serie di episodi per capire come adattare in pratica il nostro portafoglio agli aspetti non finanziari della nostra vita.
Intuitivamente però si capisce già che il nostro reddito e il nostro debito deve sempre essere considerato nelle scelte di asset allocation.
QUANDO VARIARE IL PORTAFOGLIO IN BASE AI RENDIMENTI ATTESI
A sto punto chiudiamo con il discorso che avevo accennato all’inizio.
Ma mi conviene avere un asset allocation statica, tipo 60/40 per tutta la vita, o un’allocation dinamica, in cui di volta in volta decido il peso dell’azionario in base al rendimento atteso?
La risposta a questa domanda dipende dalla risposta ad una domanda che sta a monte e che nessuno ha dettagliato meglio di Antti Illmanen, di cui tra l’altro vi straconsiglio la bellissima serie di 7 paper che ha appena scritto sul tema del rendimento atteso e che si intitola Understanding Return Expectations.
Lui dice: ci sono due modi di guardare ai rendimenti futuri:
– Se pensiamo che il premio al rischio sia fisso, allora la nostra aspettativa dei rendimenti futuri di lungo termine non si discosterà molto dai rendimenti storici. Se l’azionario ha reso dal 5 al 7% reale un po’ in tutti i mercati sviluppati, allora continuerà a dare 5-7% reale anche in futuro, purché il mio orizzonte di investimento sia abbastanza lungo. Quasi nessuno però la pensa così e i dati empirici sembrano suggerire l’altra opzione, ossia che
– Il premio al rischio sia variabile nel tempo. In questo secondo caso non ha senso che guardi più di tanto ai rendimenti passati. Conviene guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi di oggi, ossia dal rapporto tra gli utili e i prezzi delle azioni, dall’earnings yield, comunque lo si voglia calcolare.
In pratica, l’idea è quella di considerare le azioni come se fossero dei bond.
Più i tassi di sconto scendono, ossia scendono i rendimenti richiesti dagli investitori, più i rendimenti futuri saranno inferiori, esattamente come succede con i bond mano che i tassi di interesse vanno giù.
Se così stanno le cose, un adattamento lento e progressivo della mia asset allocation in base a come si muovono i rendimenti attesi avrebbe certamente senso per massimizzare l’utilità complessiva del mio portafoglio.
Ovviamente è un modello lontanissimo dalla perfezione.
E come dicevamo all’inizio richiede moltissima pazienza e disciplina, perché in alcuni momenti va tendenzialmente in controtendenza.
Il mercato americano, nel momento che in cui sto registrando, continua a segnare un massimo dopo l’altro e io però al contrario considero di ridurre la mia quota azionaria invece che aumentarla.
È un approccio “contrarian” che mi aspetto possa pagare nel lungo termine, anche magari a costo di avere qualche grosso rimpianto nel breve.
È vero che la tipica obiezione è:
– I prezzi delle azioni americane sono molto alti perché le società americane, soprattutto quelle tech, generano fantastiliardi di dollari di profitto;
– Quelle europee, giapponesi, cinesi e così via invece costano poco perché sono profittevoli.
Però se è vero, come sembra dimostrato dalla ricerca accademica, che i mercati sono guidati per un terzo dalle variazioni nelle aspettative sugli utili e per due terzi, forse di più, dalle variazioni dei rendimenti attesi, dei tassi di sconto, allora a quell’obiezione si può rispondere così:
– negli Stati Uniti i prezzi sono così alti, perché sicuramente gli utili attesi nel futuro sono elevati, ma soprattutto perché i tassi di sconto oggi sono bassi, investire su quelle società è visto come poco rischioso e quindi gli investitori accettano un rendimento inferiore. Almeno fino alla prossima crisi.
– Al contrario, in Europa, Giappone e ancor di più nei Mercati emergenti i prezzi sono bassi sicuramente perché gli utili attesi sono inferiori, ma soprattutto perché i tassi di sconto sono più alti, investire lì oggi è visto come PIU’ rischioso e quindi gli investitori pretendono un rendimento superiore — cioè di pagare meno.
Se partiamo dall’assunzione che i mercati sono generalmente efficienti — o comunque più efficienti che no — le aspettative di crescita sono già in buona parte incorporate nei prezzi.
Quello che cambia, soprattutto, sono appunto i rendimenti futuri.
– Prezzi alti oggi vuol dire soprattutto ritorni più bassi domani
– E prezzi bassi oggi vuol dire soprattutto ritorno più alti domani.
Poi, che ciò sia dovuto a delle variazioni razionali nel livello di avversione al rischio del mercato, come direbbe Fama, o a delle aspettative irrazionali sugli utili futuri, come direbbero gli economisti comportamentali, questo è difficile da dire.
Però in effetti possiamo anche fregarcene del motivo, tenere buono il fatto che questa correlazione c’è e che eventualmente possiamo trarne delle conseguenze.
Vi avevo promesso un file però, no?
Eccolo qua.
Ho semplificato un file che avevo già condiviso mesi fa nel podcast, così da renderlo più intuitivo.
I valori da inserire sono tutti nelle celle gialle nella colonna B.
Basta inserire il forward P/E e il CAPE ratio del mercato di riferimento — e di default ho messo il mercato globale — e automaticamente il rendimento reale atteso viene calcolato facendo uno diviso la media ponderata dei due valori.
Anche il tasso risk-free reale è modificabile e il rendimento in eccesso delle azioni sarà il risultato di rendimento reale atteso meno tasso senza rischio.
La deviazione standard è impostata di default su 15%, ma ovviamente mettete quella che ritenete più opportuna.
Infine ci sono tre menu a tendina per scegliere i valori di gamma, in un range da 2 a 5 per ciascuno dei tre significati.
In automatico si compila l’asset allocation.
Non ho messo un campo specifico per il discorso del capitale umano.
Per il momento suggerisco di adattare i valori di gamma tenendo presente se il vostro reddito famigliare sia stabile o precario e se il valore presente netto del vostro reddito futuro è elevato o contenuto.
Ho infine messo la tabellina che vi ho mostrato prima per mostrarvi le diverse allocation per diversi valori di gamma e per diversi livelli di rendimento atteso.
Di default prende la deviazione standard che avete inserito nella cella B9.
That’s it.
Buon divertimento.
Un dubbio che potrebbe emergere è: ma se io voglio investire meno negli Stati Uniti e di più in altri mercati, non dovrei considerare diversi rendimenti attesi?
Teoricamente se voglio investire di più in Europa e Paesi emergenti, la mia esposizione azionaria dovrebbe essere maggiore.
Sì e no.
– Dal punto di vista teorico il modello di Merton parte dal portafoglio di mercato, quindi comunque sarebbe corretto partire da un indice market cap weighted che ne è la più vicina rappresentazione;
– Dal punto di vista matematico poi bisognerebbe calcolare la varianza tenendo conto anche della correlazione tra i vari mercati, che complica notevolmente il tutto;
– Infine, più a livello logico, se investo in mercati con maggior rendimento atteso, teoricamente anche il mio rischio atteso aumenta.
Come istruzione di massima direi:
– Determinare la quota di azioni partendo da un indice globale pesato per capitalizzazione e poi
– Adattare l’esposizione ai diversi mercati come uno preferisce.
CONCLUSIONI
Bene, tiriamo un po’ le somme dell’episodio che è stato bello intenso.
Takeaway di oggi:
– NUMERO UNO: portafolio lazy, set it and forget it, va benissimo e serve benissimo il 90% delle esigenze dell’investitore medio — e all’inizio abbiamo spiegato i 4 casi in cui ciò è la scelta di default.
– NUMERO DUE: per chi invece non rientra in quei 4 casi è possibile considerare un adattamento dinamico del portafoglio che tenga conto di regole sistematiche come la regola di Merton, senza per questo invocare il market timing o violare il quadro generale dell’efficienza del mercato.
– NUMERO TRE: se si considera che il premio al rischio del mercato varia nel tempo — qualunque sia il motivo — e che è soggetto a cicli di regressioni verso la media, allora più che guardare i rendimenti passati, ha senso guardare i rendimenti attesi a partire dai prezzi attuali e adattare l’esposizione azionaria di conseguenza. Valutazioni elevate implicano rendimenti futuri inferiori. Valutazioni più basse preludono, in teoria, a rendimenti futuri superiori. Il tutto a condizione di accettare il rischio che ciò implica e di avere molta pazienza e disciplina.
Come tutti i modelli, la formula di Merton è tutt’altro che perfetta — e ancora meno lo è quella di The Bull.
Ma credo sia un modello decisionale molto comodo per allineare il proprio portafoglio a criteri di buon senso, senza la pretesa di fare alcuna previsione di breve termine, ma adattando piuttosto la quantità di rischio assunto in base alla compensazione che ci si può aspettare di ottenere e alle esigenze della nostra vita.
Bene care amiche e cari amici di The Bull, spero che quest’episodio vi sia piaciuto, soprattutto a chi era tormentato dal dubbio che fare qualunque cosa di diverso rispetto ad avere il FTSE All World sarebbe stata un’infrazione delle supreme leggi dell’efficienza di mercato.
Scaricate il file, modificatelo a vostra uso e consumo e fatemi sapere che ne pensate.
Torneremo presto a parlarne anche con tanti altri ospiti.
Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare le notifiche per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che rispondono alle domande più importanti di tutte anche se magari nemmeno ve l’eravate poste sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi rivediamo nei prossimi video di questa playlist dedicata ai temi più importanti di asset allocation e portafogli, sempre qui, naturalmente con The Bull — il tuo podcast di finanza personale.
Recensioni
Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!
Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!
Massimiliano, 29 Mag 2024Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.
Giulia N., 11 Ago 2025Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai
Francesca B., 6 Apr 2024Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai
Matteo C., 3 Set 2025Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva
Gianluca G., 11 Set 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!
Luca G. 10 Ott 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente
Amalia A., 17 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.
Lorenzo, 13 Mar 2025Non sono solito a mettere recensioni e specialmente non ascolto podcast, ma da quando ho iniziato questo, faccio fatica a staccarmi, e quasi non posso più fare a meno di ascoltare e arricchirmi culturalmente.
Andrea V., 22 Set 2025