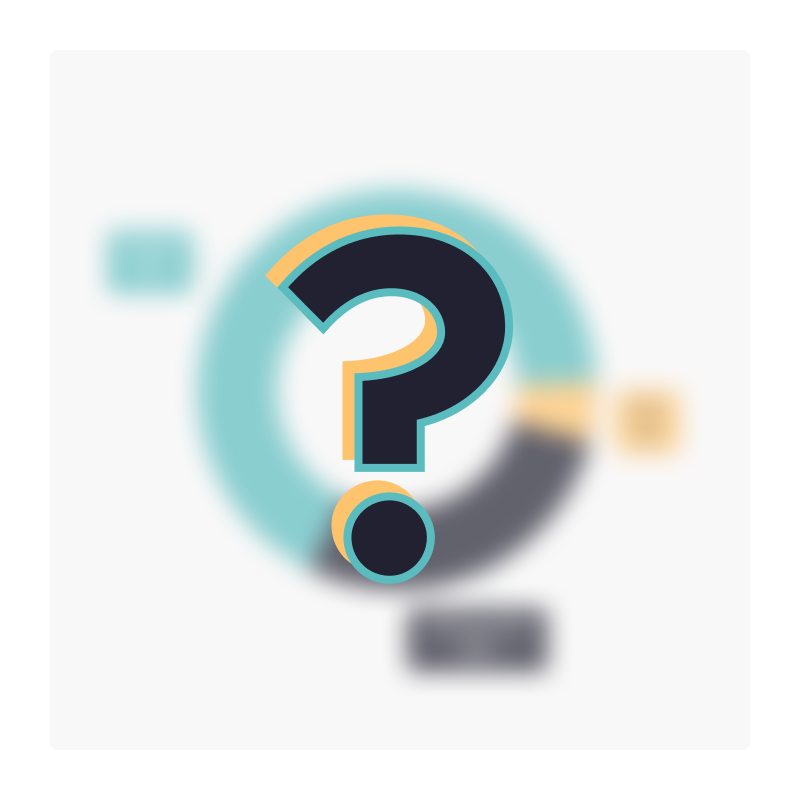185. Il mio Portafoglio d’Investimento. Asset allocation e Scelte strategiche.
Risorse
Punti Chiave
L'episodio dettaglia il portafoglio personale (67% azioni, 28% obbligazioni, 5% oro) e le logiche di asset allocation basate su Merton, The Bull e obiettivi.
Analizza la parte azionaria (geografia, fattori Momentum, Quality, Value) e obbligazionaria (duration, tipi) con riflessioni su diversificazione e rischio.
Fonti
The Great RotationTrascrizione Episodio
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.
Nel giugno del 2023 veniva alla luce questo podcast che per molti tra voi è diventato un bislacco compagno di viaggio lungo il percorso che nel frattempo avete deciso di intraprendere nei meandri della finanza.
Da allora al momento in cui sto registrando quest’episodio, oltre 350.000 persone l’hanno ascoltato almeno una volta e oltre 100.000 hanno attivato il follow tra Spotify, Apple Podcast, YouTube e gli altri.
Questa partecipazione oceanica mi ha messo in contatto con tantissimi tra voi, che mi avete scritto al profilo instagram di thebull_finance, su LinkedIn, qualcuno ha trovato e-mail personali, professionali e altre più colorite forme di comunicazione.
Mal contati, solo su Instagram ho risposto ad oltre 20.000 messaggi su pressoché qualunque argomento più o meno collegato a temi di finanza.
Ma ce n’è uno, un argomento che sopra ogni altro è al primissimo posto indiscusso nella classifica dei più gettonati, ossia: com’è fatto il mio portafoglio.
Personalmente non l’ho mai ritenuto un argomento così interessante, anche perché sarei folle se dicessi nel podcast delle cose e poi investissi diversamente.
Tuttavia, visto che l’argomento interessa, penso che oggi non si corra più il rischio di dare impulsi sbagliati, poiché dopo 185 episodi sono ragionevolmente certo che ciascuno di voi abbia maturato uno spirito critico finanziario sufficientemente solido per non farsi troppo condizionare da quello che dirò.
Oggi parlerò di come è fatto il mio portafoglio.
Ma per rendere la cosa più interessante, diciamo che raccontare la mia asset allocation è più che altro un modo per raccontarvi come ragiono io rispetto a quelli che ritengo siano i temi più rilevanti in questo momento:
– Sia dal punto di vista del contesto di mercato;
– Sia dal punto di vista di ciò che ritengo utile per la vita della mia famiglia.
Istruzioni per l’uso:
– NUMERO UNO: non vi darò i codici ISIN degli strumenti che ho nel portafoglio, perché sarebbe un’informazione alla meglio inutile e alla peggio fuorviante; vi darò le percentuali di allocazione nelle varie asset class, così poi se volete andrete a cercarvi autonomamente gli strumenti che meglio servono l’allocation che vi interessa;
– NUMERO DUE: il mio portafoglio non è statico. Sono ancora pienamente nella mia fase di accumulo, quindi certe cose non ci sono sempre state, altre non ci sono più e altre ancora ci saranno o non ci saranno nel futuro. Quella che vi do oggi è una fotografia aggiornata a febbraio del 2025 del mio portafoglio. È molto simile a come era nel febbraio del 2024 e ritengo sarà piuttosto simile al febbraio del 2026. Però non prendete quello che vi dirò come un’impostazione rigida, ma come ciò che oggi risponde meglio alle mie esigenze e al mio pensiero.
– NUMERO TRE — e questa è la più importante: this is not financial advice. E soprattutto non c’è nessun motivo per cui dobbiate pensare che quel che faccio io sia ottimale in senso assoluto. Quello che faccio con il mio portafoglio è ciò che penso vada bene per me ma sono certo che se facessi vedere il mio portafoglio a Eugene Fama, Christine Benz, Meb Faber, Ed Yardeni e agli altri ospiti che verranno a breve a trovarci, ciascuno di loro potrebbe trovare qualcosa di migliorabile.
Fair enough.
Non esiste un portafoglio giusto.
Esiste solo il portafoglio che ritengo sia giusto per me considerando:
– I miei obiettivi;
– Il mio orizzonte temporale;
– La mia tolleranza al rischio; e soprattutto
– Il punto di vista di mia moglie.
Quindi prendete tutto quello che dico come roba molto soggettiva, adatta — penso — al mio caso e non necessariamente al vostro e partite dal presupposto che su qualunque cosa io possa essere in errore.
Comunque, non vi darò solo la composizione tale e quale, ma cercherò di argomentare ogni decisione.
Questo sarebbe un classico contenuto da fare video, ma per ora per visualizzare il portafoglio utilizzeremo il miglior processore grafico che mai Nvidia riuscirà ad eguagliare: la nostra fantasia.
Ah, ovviamente non parlerò di valori assoluti.
Non vi dirò quanti soldi sono investiti.
Parlerò solo di percentuali.
Che vanno benissimo sia per 100.000 € che per 10 milioni.
Alla vostra immaginazione stimare dove mi trovai.
(indizio: non dalla parte dei 10 milioni).
Bene.
Partiamo però dalle cose più basi che male non fa.
Quanto investo dei miei soldi?
Praticamente tutto tranne:
– Circa 3 mesi di spese;
– Circa 9 mesi di fondo di emergenza;
– Tutti i soldi che dovrò allegramente versare al fisco italiano tra giugno e novembre, oltre chiaramente all’IVA ogni trimestre.
Dove sono questi soldi:
Beh, i 3 mesi di spese sono sui conti corrente.
I 9 mesi di fondo di emergenza sono invece distribuiti più o meno a metà tra un conto deposito svincolabile con scadenza 2026 che offriva Illimity con interesse al 5% e un ETF monetario.
Se vi chiedete perché 9 mesi e non 6 è perché non essendo più un sereno dipendente a tempo indeterminato ma un, boh, come mi dovrei definire, imprenditore? Lavoratore autonomo, partita IVA, insomma, non avendo più la certezza che ogni mese mi arrivi uno stipendio, ho ritenuto più opportuno allungare un po’ il fondo di emergenza.
Forse dovrei portarlo a 12 in effetti, visto che la professione del podcaster non esattamente così stabile come quella dell’idraulico.
Comunque appunto qui abbiamo un rendimento del 5% all’anno sul conto deposito e un po’ meno del 3% sul fondo monetario.
Dato che il 5% non è composto e che la tassazione è piena, mentre nel fondo monetario c’è una tassazione prevalentemente al 12,5%, più o meno possiamo dire che sul fondo di emergenza da qui a un paio d’anni ho un rendimento tra il 3 e il 4% all’anno.
Oggi non esistono depositi al 5%, perché ovviamente i tassi in Europa sono scesi e il risk-free rate è più basso.
Però il 3% circa è un rendimento a cui si può ambire facilmente utilizzando ETF monetari, ETF obbligazionari ultrashort, o forse anche obbligazionari 1-3 anni.
Non sono tecnicamente uno strumento monetario, ma la loro sensibilità ai tassi di interesse è estremamente bassa.
Per quanto riguarda invece tutto il divertentissimo discorso tasse ho diviso la cosa in due.
Una parte è accantonata in obbligazioni governative europee (principalmente tedesche, francesi e italiane) con scadenza a giugno e novembre 2025, cioè quando si versano il saldo irpef e l’acconto dell’anno successivo.
Il resto è in un altro fondo monetario.
Anche qui, c’è circa un 3% di rendimento annualizzato che mi porto a casa nell’attesa di sborsare tutto quanto all’erario quest’estate e in autunno.
That’s it.
Veniamo alla parte più interessante: il portafoglio.
Prima di addentrarci nella sua struttura, quest’episodio è realizzato in collaborazione con Fineco, che è il broker che utilizzo dal primo anno in cui ho cominciato ad investire i miei primi risparmi e su cui ora c’è la maggior parte del mio portafoglio.
Per chi desiderasse aprire un conto con Fineco, sia un conto completo con tutti i servizi bancari, sia un conto trading dedicato esclusivamente agli investimenti, può trovare un link in descrizione con un codice promozionale che permette di avere le prime 60 operazioni gratuite da effettuare nei primi 6 mesi.
Partiamo dall’asset allocation in generale.
Chi ha seguito lo scorso episodio e ha scaricato il file ha trovato lì preimpostata una cosa molto simile alla mia vera asset allocation.
Vi rifaccio qui il ragionamento che ho fatto nella mia vita reale, usando i tre metodi che ora tutti voi ben conoscete:
– La regola di The Bull;
– La regola di Merton;
– La regola “Goal Based”, in base agli obiettivi.
Ho 39 anni, ahimé, ultimo giro di giostra prima dell’inesorabile ingresso negli anta.
E questa è facile.
Ora invece bisogna trovare il risk-free rate più giusto per me.
Quant’è il tasso senza rischio in questo momento?
E qui la questione si complica perché ho diverse opzioni:
– Prima Opzione: sono in Europa, prendo l’Euro Short-Term Rate, no?, quello replicato da un fondo monetario, che mentre sto registrano è circa 2,7%, leggermente più basso del tasso di rifinanziamento principale della BCE.
– Però il mio portafoglio, come facilmente prevedibile, è più esposto agli Stati Uniti che all’Europa, quindi il comportamento delle azioni americane dipende di più dal risk-free rate americano che non da quello europeo.
– Inoltre come dicevamo l’altra volta c’è il tema della duration. Cosa considero come asset risk free? Uno strumento monetario o titoli di stato decennali?
Oggi non è un particolare tema, perché i rendimenti a breve e quelli a lungo termine sono ancora piuttosto vicini.
Il Treasury Bill a 3 mesi rende circa 4,3%, mentre il Treasury decennale meno di 4,5%.
Il rendimento dei Bund invece va da 2,3% a 3 mesi a 2,4% a 10 anni.
Se prendo un indice azionario globale fatto al 70% da Stati Uniti e 30% da Europa, Giappone e altri Paesi sviluppati, suppongo che una ragionevole approssimazione del risk-free rate a cui sono esposto possa una media ponderata di Treasury e Bund.
E’ vero il rendimento dei titoli decennali giapponesi è più basso, però quello dei Gilt Inglesi è più alto, più o meno siamo lì.
Viene fuori un risk-free rate di riferimento leggermente sotto 4%, però diciamo 4% per semplicità, tanto stiamo guardando il mio portafoglio, non stiamo cercando il bosone di Higgs.
Veniamo alle tre formule.
– La formula di The Bull è la più immediata: 125 — 39 — 4per5 venti UGUALE 66, 66% di azionario, il resto in bond.
– Vediamo invece la formula di Merton, che richiede qualche passaggio in più. Ricordiamoci, per chi si fosse perso l’ultimo episodio, che con la formula di Merton bisogna ci servono il rendimento atteso della parte azionaria, la deviazione standard (cioè il suo livello di volatilità) e poi c’è quel coefficiente chiamato gamma che è il livello di rischio che vogliamo assumerci.
Andiamo con ordine:
– Rendimento atteso: Come benchmark uso l’MSCI World, anche se in realtà investo anche nei paesi emergenti. Qual è il motivo? Il motivo è che se usassi l’MSCI All Country avrei un rapporto prezzo utili inferiori e quindi la formula mi suggerirebbe un’esposizione azionaria maggiore. Siccome però ritengo che investire negli emergenti abbia una certe componente di rischio specifico preferisco stare più basso.
Abbiamo detto nell’ultimo episodio che calcoliamo il rendimento atteso reale facendo l’inverso del rapporto tra prezzo e utili attesi dei prossimi 12 mesi.
Quindi 1/circa 19 e mezzo che fa un po’ più del 5%.
Da questo bisogna togliere il risk-free rate reale; ricordiamoci, reale perché il rendimento obbligazionario è nominale, altrimenti facciamo mele MENO pere.
Teniamo per buona un’inflazione del 2,5%, quindi partivamo da 4, 4 MENO 2,5 fa 1,5%.
Il rendimento reale in eccesso al risk-free rate sarà quindi 5% MENO 1,5% UGUALE 3,5%.
E questo è ciò che va al numeratore della formula di Merton.
– Al denominatore invece ci serve la deviazione standard, che per l’MSCI World negli ultimi anni è stata 15% circa.
– Infine bisogna decidere quanto rischio voglio prendermi e sappiamo tutti bene che il rischio ha tre facce: il rischio che voglio prendermi (quindi la mia tolleranza), il rischio che posso prendermi (in base al mio orizzonte temporale) e il rischio che devo prendermi (rispetto ai miei obiettivi).
Abbiamo detto la volta scorsa che bisogna assegnare valori da 2 a 5, dove 2 vuol dire massima propensione al rischio, 5 minima.
Nel mio caso cosa ho scelto:
– Il rischio che voglio, cioè la mia tolleranza, è massima, quindi 2;
– Il rischio che posso prendermi è altrettanto elevato, dato che il mio orizzonte temporale è piuttosto lungo e i soldi del mio portafoglio non mi servono per nessuna spesa prevedibile per i prossimi anni, quindi ancora 2 (ma volendo potrei anche mettere 3);
– Il rischio che devo prendermi, invece, non è necessariamente così elevato, qui posso accettare sicuramente 3.
Perfetto, ora che abbiamo tutti i dati, li metto nella formula del file che potete scaricare dall’episodio precedente quello che stavo ascoltando è viene fuori, anche qui, circa 68% di azioni, molto allineato alla formula di The Bull.
– Il doublecheck finale lo faccio con il terzo metodo, quello in base agli obiettivi, e anche su questo trovate tutto nel medesimo file o in quello scaricabile all’episodio 175.
Vi salto tutto il pippone sui miei obiettivi che chissenefrega, comunque tra obiettivi a breve, medio, lungo e lunghissimo termine, salta fuori che anche qui la mia esposizione azionaria più o meno sensata è intorno al 68%.
Se invece fosse successo qualcosa di diverso, chiaramente avrei fatto altre considerazioni.
Invece i tre metodi più o meno confluiscono nell’idea che 2/3 del mio portafoglio possa andare in asset rischiosi, in azioni in questo caso, e il resto in asset meno rischiosi, che per convenzione facciamo coincidere con le obbligazioni.
Perfetto, nel mio portafoglio ci sono circa 66-67% di azioni.
Cosa c’è dentro?
Partiamo dall’allocazione geografica della parte di equity.
Adesso dirò delle percentuali, ma chiaramente sono le percentuali relative alla sola parte azionaria.
Quindi il totale farà 100%.
Ovviamente dominano gli Stati Uniti, con il 56%.
58% vuol dire che rispetto ad un indice globale come l’MSCI All Country, nel quale gli Stati Uniti pesano ben il 66,5%, sono sottopesato.
Non di tantissimo, però appunto 8% in meno.
Perché questa decisione?
3 motivi:
– UNO: le valutazioni sono estremamente elevate. Sappiamo bene che non hanno alcun valore predittivo da un anno con l’altro. Ma nel lungo termine il prezzo a cui conta un asset è il fattore più importante sul rendimento che ottieni. Howard Marks spiega sempre questa cosa molto bene.
Attenzione, sono uno Eugene Fama Boy, quindi per me i prezzi sono giusti e il mercato è generalmente efficiente.
Ma detto questo è altrettanto possibile che si verifichi un po’ di mean reversion nel futuro per quanto riguarda il peso degli Stati Uniti. In fondo il 100% delle previsioni a lungo termine di qualunque istituzione finanziaria dice: nei prossimi 10-20 anni è più probabile che il rendimento degli altri paesi sviluppati sia superiore a quello americano.
Sappiamo che le previsioni lasciano il tempo che trovano, quindi questo non è un buon motivo per fare all in sul resto del mondo.
Ma diciamo che mi tengo un margine se questa cosa dovesse accadere.
(poi, non vale niente, ma nel primo mese dell’anno l’Europa ha più che doppiato l’S&P 500).
– SECONDA MOTIVAZIONE: fin dal primo giorno o quasi di questo podcast vi ho smartellato i cosiddetti sull’importanza della diversificazione e sul perché gli ETF sono fighissimi per questo scopo. Certo è che se l’indice è fatto di 2.600 società, ma 10 aziende pesano per un quarto, ecco indubbiamente l’elevata concentrazione nelle big fa venir meno un po’ di diversificazione.
In quest’ottica, ridurre un po’ gli Stati Uniti nel mio portafoglio mi dà l’idea di essere maggiormente diversificato rispetto a singoli rischi idiosincratici.
Niente di che eh? Perché quanto il mercato viene giù sappiamo bene che aumenta la correlazione tra le azioni. Come si dice: la diversificazione viene meno proprio nel momento in cui ti serve di più. Ma in termini di gestione del rischio, non di rendimento atteso, una maggiore diversificazione mi fa stare meglio.
– TERZA MOTIVAZIONE: ho trovato diversi studi, tra cui uno che citai tempo fa di Daniel Rasmussen di Verdad che vi rimetto in descrizione se vi interessa, che spiegano che gli Stati Uniti hanno questo peso perché gli investitori hanno attribuito aspettative maggiori alla crescita delle società Americane rispetto agli altri paesi sviluppati e anche perché il flottante negli Stati Uniti è maggiore che in Europa.
Cosa vuol dire quest’ultima cosa.
Vuol dire che le aziende americane hanno più azioni in circolazione che possono essere scambiate, rispetto a Europa e Giappone.
Se invece escludiamo questi due fattori e considerassimo solo gli utili che vengono generati, secondo Verdad un portafoglio realmente Market Cap Weighted dovrebbe essere 55% Stati Uniti e 45% Paesi Sviluppati, che è abbastanza in linea con il mio portafoglio.
Prima di vedere il resto, diciamo due cose.
– La prima: dovreste seguire quello che sto facendo? Assolutamente no. O meglio: boh. Non lo so. Non so se sia giusto sottopesare gli Stati Uniti. Il mio amico Ed Yardeni, così come altri illustri analisti che seguo, è super bullish sulle large cap americane, anche se ultimamente sta parlando spesso del fatto che le 493 società dell’S&P che non fanno parte del gruppo delle Magnifiche potrebbero tornare a dire la loro.
L’altro mio amico Meb Faber, invece, come sapete è super fan della diversificazione internazionale. Per lui metà Stati Uniti e metà resto del mondo.
Nessuno ha la risposta naturalmente.
Ma nel mio caso, trovo quest’impostazione equilibrata rispetto ai rischi di futuri rimorsi e rimpianti. Quindi per me va bene così.
Però se uno pensa che l’AI spaccherà tutto, l’america dominerà fino a diventare il nuovo impero Romano d’occidente o quello che vi pare, queste tesi non sarebbero affatto infondate e concentrare tanto sugli Stati Uniti potrebbe essere una scelta giusta.
– La seconda cosa che volevo dire prima di proseguire è che non mi sono limitato a ridurre il peso degli Stati Uniti, ma ho cercato di ridurre gli effetti della concentrazione delle Magnifiche 7 anche in un altro modo, ma ve ne parlo alla fine della parte azionaria, perché non riguarda solo gli Stati Uniti.
Andiamo avanti un po’ più spediti, perché chiaramente questo 58% di Stati Uniti richiedeva un po’ di discussione.
Il secondo blocco per grandezza nel mio portafoglio azionario è rappresentato dai paesi sviluppati extra Unione Europa, con il 18%.
Parliamo prevalentemente di Giappone, Regno Unito, Svizzera, Danimarca, Canada, Australia, Taiwan e Hong Kong.
Danimarca e Taiwan praticamente solo per 2 società: Novo Nordisk e Taiwan Semiconductors.
Questo 18% è ottenuto con un mix di ETF su MSCI World, Stoxx 600 e MSCI Japan.
Il Giappone è il più pesante del gruppo.
Siamo intorno al 7-8% della parte azionaria, che è significativamente di più del 5% che occupa nell’MSCI ACWI.
Ovviamente se riduci gli Stati Uniti, altri Paesi acquistano peso.
Il Giappone è un mercato che gode di prospettive piuttosto interessanti perché ha fatto importanti riforme che vanno nella direzione di agevolare le perfomance societarie, oltre al fatto che le valutazioni generalmente economiche e uno Yen che potrebbe rafforzarsi se la Bank of Japan continuerà ad alzare pian piano i tassi di interesse che lì incredibilmente sono ancora vicini a zero, ecco, queste sono tutte cose che mi rendono felice di avere un piede bello piantato in Giappone.
Gli altri Paesi invece sono leggermente sovrappesati, ma solo perché appunto sono stato un po’ indietro sugli Stati Uniti, non ho preso invece alcuna decisione specifica.
Il terzo blocco è invece l’Eurozona.
Nell’indice MSCI ACWI il blocco formato soprattutto da Francia, Germania, Italia, Spagna e Olanda non arriva neanche al 10%.
Io ho circa il 12% ottenuto aggiungendo un ETF sull’Eurostoxx 50.
Anche qui: in parte la percentuale è superiore sempre perché ci sono meno Stati Uniti.
In parte ho dato io un piccolo tilt, scegliendo di sovrappesare solo le grandi società Europee sin dai tempi in cui si parlava tanto delle Granolas, vi ricordate?
Era stata Goldman Sachs un po’ di anni fa a parlare delle Magnifiche d’Europa.
Granolas sta per: GSK, Roche, ASML, Novartis, L’oreal, Astrazeneca, Nestlé, Sap e Sanofi.
Con l’Eurostoxx 50 in realtà si va a prendere solo 4 di queste, perché le altre 5 sono inglesi e svizzere, che però comunque sono già ben rappresentate nello Stoxx 600.
Insomma.
L’Europa non è un mercato esuberante.
Però ci sono ancora dei colossi che hanno un peso rilevante a livello internazionale.
Nell’Eurozona abbiamo colossi del lusso come Hermes, LVMH e la nostra Ferrari.
Colossi finanziari come BNP Paribas, Santander e la nostra Intesa.
E non dimentichiamoci che praticamente il 90% degli aerei su cui tutti noi viaggiamo sono fatti da due sole compagnie: Airbus, Franco Tedesca, e Boing, Americana.
Come sapete bene, a furia di perdere pezzi durante i voli, Boing sta vivendo un periodo nero che dura ormai da diversi anni.
Dal 2016 ad oggi, l’azione di Airbus è cresciuta di oltre il 200%, quella di Boeing, appena del 35%.
Insomma, qua mi è andata un po’ di culo, però in effetti da dopo il Covid l’indice delle blue chip dell’eurozona è andato nettamente meglio dello Stoxx 600, circa 62% di crescita in 5 anni contro 47%.
Certo, nello stesso periodo l’S&P ha fatto +104%… ma questa è un’altra storia.
Diciamo che volevo due cose:
– Volevo avere un minimo di azionario in valuta domestica, in Euro, ma mi sentivo più sereno a stare sulle Large cap. Se prendiamo invece l’MSCI EMU, che contiene anche le Mid e Small Cap dell’eurozona, non sarebbe andata altrettanto bene.
– Inoltre, avendo tantissimo tech con gli Stati Uniti, questo mi ha dato un tilt fattoriale implicito verso realtà più tipicamente Value, vista la predominanza di settori tradizionali in Europa rispetto agli Stati Uniti e alle valutazioni generalmente basse.
Ultimo pezzetto di azionario, almeno a livello di ripartizione geografico, mercati emergenti.
Qui ho leggermente meno del 12%.
Non è un’esposizione bassissima, perché rispetto all’MSCI ACWI ho probabilmente 2-3 punti percentuali in più.
Però non credo faccia una differenza sostanziale.
Sugli Emergenti ho una posizione abbastanza agnostica.
Non ho intenzione di spingere particolarmente, sono un po’ frenato dal rischio specifico soprattutto di natura geopolitica e non sono uno di quelli che è convinto che un domani Cina e India saranno il nuovo centro del mondo.
In Cina avrò sì e no il 3% della componente azionaria.
Ogni tanto ha delle fiammate, soprattutto alimentate da interventi pubblici, ma resta pur sempre un paese con enormi limiti a livello giuridico, cosa che la rende un mercato difficilmente investibile.
È vero, ha un PIL che si sta avvicinando a quello degli Stati Uniti, ma in un mondo post globalizzato dovrà fare i conti con una nuova era in cui non so fino a che punto resterà la grande fabbrica dell’economia globale.
E sappiamo anche tutti i problemi interni che ha: demografia stagnante, disoccupazione giovanile (presunta, visto che per risolvere il problema l’anno scorso il governo ha deciso di non pubblicare più il dato, out of sight out of mind) e poi c’è quella terribile crisi immobiliare latente che ha devastato la ricchezza privata di milioni di cinesi.
Semi parafrasando Winston Churchill, la democrazia e il capitalismo sono i peggiori sistemi che esistono. Tranne tutti gli altri.
E su questi due punti, la Cina ha degli enormi limiti.
Anche sugli altri Paesi, boh.
Tanti parlano dell’India, pochi si ricordano che il mercato azionario indiano è più costoso di quello Americano.
Messico, Brasile, Arabia Saudita sono tutti Paesi che possono certamente crescere di peso nei prossimi anni.
Ma è altrettanto possibile che si manifestino delle fragilità strutturali.
Con buona pace del mio amico Paolo Coletti che tanto ama Tacos e Burritos, se Trump applica il 25% di dazi sulle importazioni Messicane fondamentalmente la sua economia dura come il famigerato gatto in tangenziale.
Il fatto che Sheldon mi stia rompendo da un’ora perché vuole mangiare è del tutto irrilevante nella formulazione di quest’ultima metafora.
Comunque, dicevo, 12% scarso negli Emergenti, se un domani crescono bene, un piede ce l’ho. Se continuano a rimanere un’eterna promessa come il Godot dei mercati finanziari globali, poco male, il danno al portafoglio non sarà clamoroso.
Ora, prima di chiudere con la parte azionaria, devo aggiungere una cosa, come dicevo prima.
Come avrete capito nei mesi, episodio dopo episodio, sono certamente convinto convinto che i mercati siano efficienti e che nessuno possa consapevolmente dire che siamo in una bolla.
Eugene Fama ce lo disse con grande chiarezza. Per essere una bolla devi poterla prevedere. Altrimenti non è una bolla, è solo variazione nei prezzi.
Quindi non si può dire che siamo in una bolla.
Si può dire che si stanno vedendo tanti comportamenti tipici di un periodo in cui si gonfiano le bolle, è nessuno meglio di Owen Lamont ha descritto questa cosa in un articolo divertentissimo, come tutti i suoi articoli, dal titolo “There are idiots. Look around”.
La frase sarebbe dell’ex segretario del tesoro Larry Summers e in generale si riferisce a comportamenti sui mercati difficilmente riconciliabili con i fondamentali che in ultima istanza “potrebbero”, condizionale d’obbligo, creare delle distorsioni a lungo termine nei prezzi.
– Eugene Fama direbbe: non è vero perché le azioni degli idioti verrebbero compensate dalle azioni degli investitori informati;
– Grossmann e Stiglitz, padri del famoso paradosso, direbbero: sì distorcono i prezzi, ma ciò crea un incentivo per tutti gli altri investitori informati a fare ricerca e analisi per prezzare correttamente gli asset quotati e quindi fare soldi a spese degli idioti;
– Richard Thaler e tutti quelli della Behavioral Finance, direbbero: sì, ci sono idioti, gli idioti gonfiano le bolle perché il mercato finisce per incorporare nei prezzi atteggiamenti irrazionali.
Scegliete voi da che orate volete stare.
Comunque dicevo, non tra quelli “ehi c’è una bolla scappiamo tutti”.
I miei pensieri sono un po’ quelli nella media.
Mercato con valutazioni molto elevate, in America perlomeno.
Elevata concentrazione in un manipolo di mega aziende tech.
Elevata correlazione.
Queste cose, attenzione, non sono né positive né negative.
Nel senso che, come ha dimostrato Moubussin in uno studio che abbiamo citato più volte, anche questo in descrizione se volete, durante i bull market tendono a salire tre cose:
– Le valutazioni;
– Le concentrazioni;
– Le correlazioni.
Quindi, possiamo discutere se siamo arrivati a livelli eccessivi.
Ma resta il fatto che queste cose, da un punto di vista qualitativo, sono più che altro una conseguenza del fatto che il mercato stia correndo da 15 anni più o meno ininterrottamente.
It’s a feature, not a bug.
Detto questo, il mercato è anche fatto di cicli.
Per un certo periodo di tempo è trend-following, cioè continua a seguire la strada tracciata.
Ma dopo un po’ diventa mean reverting, cioè tende a regredire verso i suoi valori medi.
Impossibile dire quando, ma è probabile che i cicli si alternino e che ciò che è andato su tanto ad una certa torna giù.
Ci sono tonnellate di paper, di cui uno anche di Fama e French, che dimostrano che società che hanno avuto crescite abnormi non hanno mai mantenuto questi ritmi per più di 10-15 anni.
Più spesso che no i vincitori di oggi saranno i perdenti di domani.
Comunque, senza sconfinare nella divinazione di scenari futuri imperscrutabili, veniamo al punto.
Sappiamo che, in teoria, se io investo in un indice market-cap-weighted il fattore a cui sono principalmente esposto è il Beta, che in questo caso è il mercato stesso, perlomeno secondo il modello del CAPM di William Sharpe.
Negli anni, però, Fama e French, Jegadeesh e Titman e tanti altri hanno messo in evidenza il ruolo sistematico di altri fattori, che tendono ad essere persistenti, benché su singoli periodi storici abbiano comportamenti molto diversi.
Dei mille fattori che sono stati più o meno scovati, quelli che sembrano più accreditati e su cui c’è maggior consenso sono, direi, quattro:
– Momentum,
– Value
– Quality
– Size
Ci sarebbe anche Low Volatilty, per qualcuno anche Dividend è un fattore, nel modello a 5 fattori di Fama e French c’erano Profitability e Investment che in parte sono confluiti in quello che oggi si chiama Quality, grazie forse soprattutto al contributo dell’allievo di French Cliff Asness e così via.
Però, Momentum, Value, Quality e Size possono serenamente essere considerati i big 4.
Momentum è il fattore che espone alle società che sono cresciute di più negli ultimi 12 mesi.
Value, società con basso prezzo rispetto al valore patrimoniale.
Quality, società con elevati ritorno sull’equity, basso indebitamento e crescita stabile delgi utili.
Size infine espone a società small cap, secondo l’idea che storicamente le small cap incorporano un rischio maggiore e quindi pagano un premio superiore a chi ci investe.
Ad un certo punto ho voluto dare un tilt al portafoglio per espormi a 3 di questi 4 fattori.
3, perché ho scelto di non avere esposizione alle small cap.
Sono un investitore da Large Cap.
Non c’è una buona motivazione finanziaria dietro.
Semplicemente sono felice di prendermi il rischio di investire in azioni di grandi aziende, meno di prendermi del rischio ulteriore per investire in azioni di piccole società.
Sono fatto così.
Alla fine uno investe anche in base a come è fatto.
Però mi attirava molto l’idea di avere, diciamo così, delle specifiche concentrazioni del portafoglio che andassero ad aggiungere un po’ di rischio sistematico, ma combinando tra di loro diverse dinamiche.
Sappiamo bene che un ETF fattoriale in parte fa quello che ci aspettiamo, in parte è una mezza marchetta degli emittenti di ETF, che ti fanno pagare di più questi ETF nella tua speranza di avere un maggior rendimento.
Ma come investitore retail non è che abbia molte altre opportunità per crearmi delle esposizioni fattoriali, quindi ho tagliato la testa al toro è ho investito in tre ETF fattoriali su MSCI World Momentum, Quality e Value, più o meno in parti uguali.
In totale circa un quinto della mia quota azionaria è su questi fattoriali.
Quando prima vi ho dato le percentuali geografiche avevo già tenuto conto anche del peso delle varie regioni dentro questi ETF, quindi questo 20% è un di cui di quello che ho detto prima.
Soffermiamoci un secondo su questi tre.
Negli ultimi 10 anni è facile immaginare come siano andate le cose:
– Momentum ha dominato, crescendo di oltre il 320%;
– Quality ha fatto molto bene, 250%, circa un 10 punti percentuali in più dell’MSCI World classico;
– Value, comprensibilmente, è rimasto indietro: +120%, metà dell’MSCI World.
Momentum e Quality hanno una composizione geografica simile, con gli Stati uniti che pesano il 70% in entrambi.
Value invece no. Qui gli Stati Uniti hanno meno del 40% del peso e ben il 23% è attribuito al Giappone.
Se andiamo a prendere le prime 10 posizioni di ciascun indice, troviamo in effetti cose che non troveremmo tra i top 10 holding dell’MSCI World classico.
– in Momentum abbiamo per esempio società come Walmart, Berkshire Hathaway, Costco e Netflix;
– in Quality troviamo: Vista, Mastercard e l’olandese ASML;
– in Value invece tutte le prime 10 non si trovano tra le prime 10 dell’MSCI World: Cisco, IBM, Qualcomm, Toyota, AT&T, Intel, Verizon, HSBC, Comcast, British American Tobacco.
Rispetto ai primi due, qui c’è una maggior concentrazione di realtà nel settore industriale, finanziario, media e nella tecnologia più tradizionale, come Cisco, Intel e IBM.
Una differenza abissale è anche nel rapporto tra prezzi e utili attesi:
– Momentum e Quality intorno a 22;
– Value 10.
Ricordiamoci sempre che investire in società con un rapporto tra prezzi e utili basso è più rischioso, non meno rischioso, perché sto scommettendo, sempre per usare un esempio efficace, che il Real Madrid non schianterà il Salisburgo.
Ma se penso che ad un certo punto le valutazioni alte avranno un impatto negativo sui rendimenti futuri, anche qui, un piedino su Value mi piaceva averlo.
Fine della parte azionaria.
Scusate se vi aspettavate qualcosa di più frizzante.
Ma come dicevo uno investe così com’è.
E io sono piuttosto noioso.
Ora, ero tentato di dividere in due l’episodio, per poi parlare in grande dettaglio anche del resto del portafoglio, ma poi ho pensato che il “ne parleremo nel prossimo episodio” fa sempre un po’ girare le palle.
Quando da piccolo ero uno sfegatato fan di quel terribile telefilm sui Power Rangers, quando facevano gli episodi divisi in due parti mi rovinavano il pomeriggio.
Quindi, portate pazienza ancora qualche minuto che vediamo il resto.
Abbiamo detto che il 67% circa del portafoglio è in Azioni.
Andiamo ora a vedere come è composto il restante 33%.
28% è in obbligazioni, 5% è in oro.
Sì, qui ho un po’ barato.
Fino a qualche mese fa erano solo obbligazioni, di cui però circa 5% erano High Yield.
Poi cos’è stato, forse subito dopo l’elezione di Trump l’oro ha avuto un momento di ripiego, passando da 2.800 $ l’oncia a 2.560 mi sembra.
Siccome, lo ammetto, non amo l’oro e come investimento mi sta pure un po’ antipatico e se Warren Buffett vedesse il mio portafoglio disapproverebbe, però dall’altra parte un po’ mi rodeva continuare a vederlo correre così tanto, mi ero detto: ora o mai più.
Una mattina a metà novembre l’oro era ancora sotto i 2.600, gli High Yield ormai hanno un costo folle perché rendono solo leggermente di più di un Treasury nonostante il rischio molto più alto che teoricamente incorporano, quindi via High Yield e ho comprato l’equivalente di circa il 5% del mio portafoglio di oro.
Da allora è cresciuto di circa un 12-13%, ma il suo peso non è cambiato perché nel frattempo ho continuato ad investire in altre cose.
5% non sposta molto.
Forse, se proprio devo avere l’oro per fargli fare quello che dall’oro ti aspetteresti, quindi protezione, inflation hedge, rischio geopolitico, solite cose, magari avrebbe più senso averne un po’ di più o non averne affatto.
5% è un po’ vorrei ma non posso, magari in futuro valuterò.
Obbligazioni, le vostre amate obbligazioni.
In realtà qui molto easy.
Il grosso sono obbligazioni governative europee, un po’ meno di 2/3 del totale.
Il resto sono fondamentalmente treasury e qualcos’altro sempre di paesi sviluppati.
Non voglio avere debito di paesi emergenti.
Perché?
Forse perché lo capisco poco, non ne ho mai approfondito le dinamiche.
Non ci vedo comunque una particolare opportunità nell’averlo in pancia.
Circa un 20% del blocco obbligazionario sono corporate investment grade.
Sulle obbligazioni, comunque, val la pena secondo me considerarle divise in due macroblocchi, in base alla duration.
Infatti ho due terzi in obbligazioni a scadenza intermedia, con duration intorno a 6, e un terzo in obbligazioni governative europee a lunga scadenza, con duration media intorno a 16.
Non ho obbligazioni a lunga scadenza in valute diverse dall’Euro perché già con le lunghe scadenze mi prendo il rischio duration e non volevo sommargli anche il rischio valuta.
Anche qui, è tutto piuttosto banale e non ci sono idee geniali.
Le obbligazioni intermedie sono la quota, tra molte virgolette, risk-free del portafoglio, ciò che va a togliere un po’ di volatilità generale.
Le obbligazioni a lungo termine, invece, che tra l’altro avevo comprato piuttosto bene, del tutto casualmente, nell’ottobre del 2023, quando praticamente avevano toccato il fondo dopo 2 anni, dicevo queste mi aspetto che non vadano più o meno da nessuna parte in questi anni di tassi ancora piuttosto alti e crescita sostenuta, anche se nell’ultimo anno, comunque, un 5% se lo sono portati a casa, ma che però dicano la loro se dovesse verificarsi un brusco tracollo economico con conseguente sforbiciata mostre dei tassi.
Ovvio che hanno anche un rischio opposto: ossia in caso di un nuovo picco di inflazione, questi van giù più delle azioni.
Però insomma, è normale che ci siano sempre parti del portafoglio che funzionano meglio e altre meno.
In questo momento è tutto bello perché ogni singola riga del portafoglio è in verde, con alcune situazioni, come ad esempio un ETF sull’S&P 500, che ovviamente ha accumulato negli ultimi anni una crescita disumana.
In futuro non sarà sempre così e arriveranno momenti in cui le azioni soffriranno e magari alcune obbligazioni, o l’oro, o le materie prime o altre cose ancora avranno la loro ribalta.
Ora, prima di chiedere, 3 considerazioni.
PRIMA CONSIDERAZIONE: qual è il livello di rischio del mio portafoglio?
Probabilmente ha un livello di rischio sistematico è superiore a quello che avrebbe un portafoglio con la stessa asset allocation ma più, diciamo, plain vanilla e market cap weighted.
Quali sono gli elementi che lo rendono più rischio?
– I fattoriali, per definizione se tilti un portafoglio verso un fattore, l’eventuale, e sottolineo eventuale, extrarendimento viene al costo di un extra rischio (certo).
– Il fatto di sovrappesare leggermente alcuni mercati con bassi prezzi.
– E infine le obbligazioni a lunga scadenza.
Penso però che questo maggiore rischio sistematico abbia anche un beneficio in termini di riduzione di alcuni rischi specifici.
Ho un’esposizione leggermente inferiore a Stati Uniti in generale elle Magnifiche 7 in particolare.
Ho un’esposizione leggermente più bilanciato rispetto a settori diversi dal tech.
Ho una forte dipendenza dal dollaro sulla parte azionaria, ma una predominanza dell’euro su quella obbligazionaria.
Dopo tanto ragionarci sopra, ho deciso che mi sta bene.
SECONDA CONSIDERAZIONE: cosa manca?
Ci sono delle cose che, volendo, colmerebbero delle lacune nel portafoglio.
– Per esempio, dato che ho un po’ barato sull’asset allocation partendo dalle varie formule, perché ho messo l’oro al posto delle obbligazioni, forse potrei pensare di mitigare un po’ di rischio sostituendo un 5-10% di azioni con altrettante obbligazioni corporate. Il bloomberg global aggregate corporate, quindi obbligazioni societarie globali investement grade, ha in questo momento uno yield to maturity medio del 5% con duration intorno a 6 anni e mezzo.
Questo non vuol dire che il 5% sia garantito, anche perché va considerato l’impatto del cambio valutario, però se Goldman Sachs ha ragione a pensare che i rendimenti futuri americani saranno miseri, questa decisione non sarebbe del tutto fuori luogo.
– Un’altra cosa che manca sono le materie prime. Da un lato non mi piacciono. Investire in materie prime è investire contro l’ingegno umano, che farà sempre di tutto per ridurre il più possibile la sua dipendenza da madre natura. D’altra parte le materie prime hanno sempre un loro perché soprattutto nelle fasi con inflazione crescente.
– Per lo stesso motivo, mancano forse quelli che Meb Faber chiama real assets. Oltre alle materie prime, non ci sono obbligazioni indicizzate all’inflazione e manca anche una focalizzazione specifica verso azioni di società legate alle materie prime o alla realizzazione di infrastrutture. Così come non ho REIT, fondi real estate.
Non ho una particolare passione per il mondo immobiliare, forse perché un po’ il declino demografico mi spaventa a lungo termine. Non lo so. Però non ci ho mai trovato una particolare opportunità ad investire in un settore che comunque è fortemente correlato all’azionario ma è meno efficiente. Quindi passo.
Forse invece un 5% di obbligazioni inflation linked potrebbero avere senso. Le ho sempre però viste più come qualcosa di molto sensato in un portafoglio conservativo, orientato a generare income, che non in un portafoglio destinato ancora a lungo alla crescita.
TERZA e ULTIMA CONSIDERAZIONE: come investo?
Allora per quanto riguarda, diciamo, il core del portafoglio, ho attivo un PAC mensile con il piano Replay di Fineco su 5 ETF:
– 3 azionari, che coprono Stati Uniti, Europa e Emergenti e
– 2 obbligazionari, uno sulle scadenze intermedie e uno su quelle lunghe.
Alcuni di questi ETF sono tra quelli che Fineco offre a zero commissioni emessi da iShares, Amundi e Xtrackers e complessivamente spendo circa 3€ al mese per il PAC.
Sugli altri invece faccio acquisti episodici, a seconda di quanto ho surplus di risparmio o se faccio dei ribilanciamenti.
Dato che, ormai mi conoscete, ho le braccina corte che avrei fatto invidia a un T-rex, cerco di spendere sempre meno possibile sulle commissioni e per esempio gli ETF fattoriali che utilizzo sono disponibili a zero commissioni con tutti e tre gli emittenti, quindi sia iShares che Amundi che Xtrackers.
Se state cercando la piattaforma più completa che esista in Italia per investire, con regime amministrato e accesso ad una gamma sterminata di soluzioni di investimento, in descrizione trovate un link per aprire un conto con Fineco e un codice per avere 60 operazioni gratuite nei primi 6 mesi.
Questo contenuto è sponsorizzato da Fineco e il sottoscritto riceverà gargantuesche commissioni da Fineco se aprite un conto tramite il suo link.
Bene cari miei, credo che ci siamo detti un po’ tutto.
Oggi abbiamo fatto la radiografia al mio portafoglio e spero che al di là delle decisioni che ho preso io, che contano come il proverbiale due di picche a briscola, tutto ciò stato utile per condividere dei ragionamenti che magari potreste valutare di fare con i vostri portafogli e che potrebbero portarvi a scelte diverse ma più adatte a ciascuna specifica situazione.
Fatemi sapere che ne pensate e se volete potete contattarmi tramite il mio profilo instagram thebull_finance.
Prima di lasciarci vi invito come sempre a mettere segui e attivare le notifiche su spotify, apple podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che ogni tanto continueranno a raccontarvi come investo i miei soldi ma consigliandovi anche di fare i compiti a casa e non copiare sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi invece ci risentiamo domenica prossima con un episodio spettacolare con una altro straordinario ospite più volte citato in questo posto: investitore milionario, autore di oltre 18 libri di finanza personale e autorità indiscussa di ciò che potremmo chiamare buon investimento basato sui fatti e non sulle opinioni, il grandissimo Larry Swedroe, sempre qui naturalmente, con The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Bentornati a The Bull — il tuo podcast di finanza personale.
Nel giugno del 2023 veniva alla luce questo podcast che per molti tra voi è diventato un bislacco compagno di viaggio lungo il percorso che nel frattempo avete deciso di intraprendere nei meandri della finanza.
Da allora al momento in cui sto registrando quest’episodio, oltre 350.000 persone l’hanno ascoltato almeno una volta e oltre 100.000 hanno attivato il follow tra Spotify, Apple Podcast, YouTube e gli altri.
Questa partecipazione oceanica mi ha messo in contatto con tantissimi tra voi, che mi avete scritto al profilo instagram di thebull_finance, su LinkedIn, qualcuno ha trovato e-mail personali, professionali e altre più colorite forme di comunicazione.
Mal contati, solo su Instagram ho risposto ad oltre 20.000 messaggi su pressoché qualunque argomento più o meno collegato a temi di finanza.
Ma ce n’è uno, un argomento che sopra ogni altro è al primissimo posto indiscusso nella classifica dei più gettonati, ossia: com’è fatto il mio portafoglio.
Personalmente non l’ho mai ritenuto un argomento così interessante, anche perché sarei folle se dicessi nel podcast delle cose e poi investissi diversamente.
Tuttavia, visto che l’argomento interessa, penso che oggi non si corra più il rischio di dare impulsi sbagliati, poiché dopo 185 episodi sono ragionevolmente certo che ciascuno di voi abbia maturato uno spirito critico finanziario sufficientemente solido per non farsi troppo condizionare da quello che dirò.
Oggi parlerò di come è fatto il mio portafoglio.
Ma per rendere la cosa più interessante, diciamo che raccontare la mia asset allocation è più che altro un modo per raccontarvi come ragiono io rispetto a quelli che ritengo siano i temi più rilevanti in questo momento:
– Sia dal punto di vista del contesto di mercato;
– Sia dal punto di vista di ciò che ritengo utile per la vita della mia famiglia.
Istruzioni per l’uso:
– NUMERO UNO: non vi darò i codici ISIN degli strumenti che ho nel portafoglio, perché sarebbe un’informazione alla meglio inutile e alla peggio fuorviante; vi darò le percentuali di allocazione nelle varie asset class, così poi se volete andrete a cercarvi autonomamente gli strumenti che meglio servono l’allocation che vi interessa;
– NUMERO DUE: il mio portafoglio non è statico. Sono ancora pienamente nella mia fase di accumulo, quindi certe cose non ci sono sempre state, altre non ci sono più e altre ancora ci saranno o non ci saranno nel futuro. Quella che vi do oggi è una fotografia aggiornata a febbraio del 2025 del mio portafoglio. È molto simile a come era nel febbraio del 2024 e ritengo sarà piuttosto simile al febbraio del 2026. Però non prendete quello che vi dirò come un’impostazione rigida, ma come ciò che oggi risponde meglio alle mie esigenze e al mio pensiero.
– NUMERO TRE — e questa è la più importante: this is not financial advice. E soprattutto non c’è nessun motivo per cui dobbiate pensare che quel che faccio io sia ottimale in senso assoluto. Quello che faccio con il mio portafoglio è ciò che penso vada bene per me ma sono certo che se facessi vedere il mio portafoglio a Eugene Fama, Christine Benz, Meb Faber, Ed Yardeni e agli altri ospiti che verranno a breve a trovarci, ciascuno di loro potrebbe trovare qualcosa di migliorabile.
Fair enough.
Non esiste un portafoglio giusto.
Esiste solo il portafoglio che ritengo sia giusto per me considerando:
– I miei obiettivi;
– Il mio orizzonte temporale;
– La mia tolleranza al rischio; e soprattutto
– Il punto di vista di mia moglie.
Quindi prendete tutto quello che dico come roba molto soggettiva, adatta — penso — al mio caso e non necessariamente al vostro e partite dal presupposto che su qualunque cosa io possa essere in errore.
Comunque, non vi darò solo la composizione tale e quale, ma cercherò di argomentare ogni decisione.
Questo sarebbe un classico contenuto da fare video, ma per ora per visualizzare il portafoglio utilizzeremo il miglior processore grafico che mai Nvidia riuscirà ad eguagliare: la nostra fantasia.
Ah, ovviamente non parlerò di valori assoluti.
Non vi dirò quanti soldi sono investiti.
Parlerò solo di percentuali.
Che vanno benissimo sia per 100.000 € che per 10 milioni.
Alla vostra immaginazione stimare dove mi trovai.
(indizio: non dalla parte dei 10 milioni).
Bene.
Partiamo però dalle cose più basi che male non fa.
Quanto investo dei miei soldi?
Praticamente tutto tranne:
– Circa 3 mesi di spese;
– Circa 9 mesi di fondo di emergenza;
– Tutti i soldi che dovrò allegramente versare al fisco italiano tra giugno e novembre, oltre chiaramente all’IVA ogni trimestre.
Dove sono questi soldi:
Beh, i 3 mesi di spese sono sui conti corrente.
I 9 mesi di fondo di emergenza sono invece distribuiti più o meno a metà tra un conto deposito svincolabile con scadenza 2026 che offriva Illimity con interesse al 5% e un ETF monetario.
Se vi chiedete perché 9 mesi e non 6 è perché non essendo più un sereno dipendente a tempo indeterminato ma un, boh, come mi dovrei definire, imprenditore? Lavoratore autonomo, partita IVA, insomma, non avendo più la certezza che ogni mese mi arrivi uno stipendio, ho ritenuto più opportuno allungare un po’ il fondo di emergenza.
Forse dovrei portarlo a 12 in effetti, visto che la professione del podcaster non esattamente così stabile come quella dell’idraulico.
Comunque appunto qui abbiamo un rendimento del 5% all’anno sul conto deposito e un po’ meno del 3% sul fondo monetario.
Dato che il 5% non è composto e che la tassazione è piena, mentre nel fondo monetario c’è una tassazione prevalentemente al 12,5%, più o meno possiamo dire che sul fondo di emergenza da qui a un paio d’anni ho un rendimento tra il 3 e il 4% all’anno.
Oggi non esistono depositi al 5%, perché ovviamente i tassi in Europa sono scesi e il risk-free rate è più basso.
Però il 3% circa è un rendimento a cui si può ambire facilmente utilizzando ETF monetari, ETF obbligazionari ultrashort, o forse anche obbligazionari 1-3 anni.
Non sono tecnicamente uno strumento monetario, ma la loro sensibilità ai tassi di interesse è estremamente bassa.
Per quanto riguarda invece tutto il divertentissimo discorso tasse ho diviso la cosa in due.
Una parte è accantonata in obbligazioni governative europee (principalmente tedesche, francesi e italiane) con scadenza a giugno e novembre 2025, cioè quando si versano il saldo irpef e l’acconto dell’anno successivo.
Il resto è in un altro fondo monetario.
Anche qui, c’è circa un 3% di rendimento annualizzato che mi porto a casa nell’attesa di sborsare tutto quanto all’erario quest’estate e in autunno.
That’s it.
Veniamo alla parte più interessante: il portafoglio.
Prima di addentrarci nella sua struttura, quest’episodio è realizzato in collaborazione con Fineco, che è il broker che utilizzo dal primo anno in cui ho cominciato ad investire i miei primi risparmi e su cui ora c’è la maggior parte del mio portafoglio.
Per chi desiderasse aprire un conto con Fineco, sia un conto completo con tutti i servizi bancari, sia un conto trading dedicato esclusivamente agli investimenti, può trovare un link in descrizione con un codice promozionale che permette di avere le prime 60 operazioni gratuite da effettuare nei primi 6 mesi.
Partiamo dall’asset allocation in generale.
Chi ha seguito lo scorso episodio e ha scaricato il file ha trovato lì preimpostata una cosa molto simile alla mia vera asset allocation.
Vi rifaccio qui il ragionamento che ho fatto nella mia vita reale, usando i tre metodi che ora tutti voi ben conoscete:
– La regola di The Bull;
– La regola di Merton;
– La regola “Goal Based”, in base agli obiettivi.
Ho 39 anni, ahimé, ultimo giro di giostra prima dell’inesorabile ingresso negli anta.
E questa è facile.
Ora invece bisogna trovare il risk-free rate più giusto per me.
Quant’è il tasso senza rischio in questo momento?
E qui la questione si complica perché ho diverse opzioni:
– Prima Opzione: sono in Europa, prendo l’Euro Short-Term Rate, no?, quello replicato da un fondo monetario, che mentre sto registrano è circa 2,7%, leggermente più basso del tasso di rifinanziamento principale della BCE.
– Però il mio portafoglio, come facilmente prevedibile, è più esposto agli Stati Uniti che all’Europa, quindi il comportamento delle azioni americane dipende di più dal risk-free rate americano che non da quello europeo.
– Inoltre come dicevamo l’altra volta c’è il tema della duration. Cosa considero come asset risk free? Uno strumento monetario o titoli di stato decennali?
Oggi non è un particolare tema, perché i rendimenti a breve e quelli a lungo termine sono ancora piuttosto vicini.
Il Treasury Bill a 3 mesi rende circa 4,3%, mentre il Treasury decennale meno di 4,5%.
Il rendimento dei Bund invece va da 2,3% a 3 mesi a 2,4% a 10 anni.
Se prendo un indice azionario globale fatto al 70% da Stati Uniti e 30% da Europa, Giappone e altri Paesi sviluppati, suppongo che una ragionevole approssimazione del risk-free rate a cui sono esposto possa una media ponderata di Treasury e Bund.
E’ vero il rendimento dei titoli decennali giapponesi è più basso, però quello dei Gilt Inglesi è più alto, più o meno siamo lì.
Viene fuori un risk-free rate di riferimento leggermente sotto 4%, però diciamo 4% per semplicità, tanto stiamo guardando il mio portafoglio, non stiamo cercando il bosone di Higgs.
Veniamo alle tre formule.
– La formula di The Bull è la più immediata: 125 — 39 — 4per5 venti UGUALE 66, 66% di azionario, il resto in bond.
– Vediamo invece la formula di Merton, che richiede qualche passaggio in più. Ricordiamoci, per chi si fosse perso l’ultimo episodio, che con la formula di Merton bisogna ci servono il rendimento atteso della parte azionaria, la deviazione standard (cioè il suo livello di volatilità) e poi c’è quel coefficiente chiamato gamma che è il livello di rischio che vogliamo assumerci.
Andiamo con ordine:
– Rendimento atteso: Come benchmark uso l’MSCI World, anche se in realtà investo anche nei paesi emergenti. Qual è il motivo? Il motivo è che se usassi l’MSCI All Country avrei un rapporto prezzo utili inferiori e quindi la formula mi suggerirebbe un’esposizione azionaria maggiore. Siccome però ritengo che investire negli emergenti abbia una certe componente di rischio specifico preferisco stare più basso.
Abbiamo detto nell’ultimo episodio che calcoliamo il rendimento atteso reale facendo l’inverso del rapporto tra prezzo e utili attesi dei prossimi 12 mesi.
Quindi 1/circa 19 e mezzo che fa un po’ più del 5%.
Da questo bisogna togliere il risk-free rate reale; ricordiamoci, reale perché il rendimento obbligazionario è nominale, altrimenti facciamo mele MENO pere.
Teniamo per buona un’inflazione del 2,5%, quindi partivamo da 4, 4 MENO 2,5 fa 1,5%.
Il rendimento reale in eccesso al risk-free rate sarà quindi 5% MENO 1,5% UGUALE 3,5%.
E questo è ciò che va al numeratore della formula di Merton.
– Al denominatore invece ci serve la deviazione standard, che per l’MSCI World negli ultimi anni è stata 15% circa.
– Infine bisogna decidere quanto rischio voglio prendermi e sappiamo tutti bene che il rischio ha tre facce: il rischio che voglio prendermi (quindi la mia tolleranza), il rischio che posso prendermi (in base al mio orizzonte temporale) e il rischio che devo prendermi (rispetto ai miei obiettivi).
Abbiamo detto la volta scorsa che bisogna assegnare valori da 2 a 5, dove 2 vuol dire massima propensione al rischio, 5 minima.
Nel mio caso cosa ho scelto:
– Il rischio che voglio, cioè la mia tolleranza, è massima, quindi 2;
– Il rischio che posso prendermi è altrettanto elevato, dato che il mio orizzonte temporale è piuttosto lungo e i soldi del mio portafoglio non mi servono per nessuna spesa prevedibile per i prossimi anni, quindi ancora 2 (ma volendo potrei anche mettere 3);
– Il rischio che devo prendermi, invece, non è necessariamente così elevato, qui posso accettare sicuramente 3.
Perfetto, ora che abbiamo tutti i dati, li metto nella formula del file che potete scaricare dall’episodio precedente quello che stavo ascoltando è viene fuori, anche qui, circa 68% di azioni, molto allineato alla formula di The Bull.
– Il doublecheck finale lo faccio con il terzo metodo, quello in base agli obiettivi, e anche su questo trovate tutto nel medesimo file o in quello scaricabile all’episodio 175.
Vi salto tutto il pippone sui miei obiettivi che chissenefrega, comunque tra obiettivi a breve, medio, lungo e lunghissimo termine, salta fuori che anche qui la mia esposizione azionaria più o meno sensata è intorno al 68%.
Se invece fosse successo qualcosa di diverso, chiaramente avrei fatto altre considerazioni.
Invece i tre metodi più o meno confluiscono nell’idea che 2/3 del mio portafoglio possa andare in asset rischiosi, in azioni in questo caso, e il resto in asset meno rischiosi, che per convenzione facciamo coincidere con le obbligazioni.
Perfetto, nel mio portafoglio ci sono circa 66-67% di azioni.
Cosa c’è dentro?
Partiamo dall’allocazione geografica della parte di equity.
Adesso dirò delle percentuali, ma chiaramente sono le percentuali relative alla sola parte azionaria.
Quindi il totale farà 100%.
Ovviamente dominano gli Stati Uniti, con il 56%.
58% vuol dire che rispetto ad un indice globale come l’MSCI All Country, nel quale gli Stati Uniti pesano ben il 66,5%, sono sottopesato.
Non di tantissimo, però appunto 8% in meno.
Perché questa decisione?
3 motivi:
– UNO: le valutazioni sono estremamente elevate. Sappiamo bene che non hanno alcun valore predittivo da un anno con l’altro. Ma nel lungo termine il prezzo a cui conta un asset è il fattore più importante sul rendimento che ottieni. Howard Marks spiega sempre questa cosa molto bene.
Attenzione, sono uno Eugene Fama Boy, quindi per me i prezzi sono giusti e il mercato è generalmente efficiente.
Ma detto questo è altrettanto possibile che si verifichi un po’ di mean reversion nel futuro per quanto riguarda il peso degli Stati Uniti. In fondo il 100% delle previsioni a lungo termine di qualunque istituzione finanziaria dice: nei prossimi 10-20 anni è più probabile che il rendimento degli altri paesi sviluppati sia superiore a quello americano.
Sappiamo che le previsioni lasciano il tempo che trovano, quindi questo non è un buon motivo per fare all in sul resto del mondo.
Ma diciamo che mi tengo un margine se questa cosa dovesse accadere.
(poi, non vale niente, ma nel primo mese dell’anno l’Europa ha più che doppiato l’S&P 500).
– SECONDA MOTIVAZIONE: fin dal primo giorno o quasi di questo podcast vi ho smartellato i cosiddetti sull’importanza della diversificazione e sul perché gli ETF sono fighissimi per questo scopo. Certo è che se l’indice è fatto di 2.600 società, ma 10 aziende pesano per un quarto, ecco indubbiamente l’elevata concentrazione nelle big fa venir meno un po’ di diversificazione.
In quest’ottica, ridurre un po’ gli Stati Uniti nel mio portafoglio mi dà l’idea di essere maggiormente diversificato rispetto a singoli rischi idiosincratici.
Niente di che eh? Perché quanto il mercato viene giù sappiamo bene che aumenta la correlazione tra le azioni. Come si dice: la diversificazione viene meno proprio nel momento in cui ti serve di più. Ma in termini di gestione del rischio, non di rendimento atteso, una maggiore diversificazione mi fa stare meglio.
– TERZA MOTIVAZIONE: ho trovato diversi studi, tra cui uno che citai tempo fa di Daniel Rasmussen di Verdad che vi rimetto in descrizione se vi interessa, che spiegano che gli Stati Uniti hanno questo peso perché gli investitori hanno attribuito aspettative maggiori alla crescita delle società Americane rispetto agli altri paesi sviluppati e anche perché il flottante negli Stati Uniti è maggiore che in Europa.
Cosa vuol dire quest’ultima cosa.
Vuol dire che le aziende americane hanno più azioni in circolazione che possono essere scambiate, rispetto a Europa e Giappone.
Se invece escludiamo questi due fattori e considerassimo solo gli utili che vengono generati, secondo Verdad un portafoglio realmente Market Cap Weighted dovrebbe essere 55% Stati Uniti e 45% Paesi Sviluppati, che è abbastanza in linea con il mio portafoglio.
Prima di vedere il resto, diciamo due cose.
– La prima: dovreste seguire quello che sto facendo? Assolutamente no. O meglio: boh. Non lo so. Non so se sia giusto sottopesare gli Stati Uniti. Il mio amico Ed Yardeni, così come altri illustri analisti che seguo, è super bullish sulle large cap americane, anche se ultimamente sta parlando spesso del fatto che le 493 società dell’S&P che non fanno parte del gruppo delle Magnifiche potrebbero tornare a dire la loro.
L’altro mio amico Meb Faber, invece, come sapete è super fan della diversificazione internazionale. Per lui metà Stati Uniti e metà resto del mondo.
Nessuno ha la risposta naturalmente.
Ma nel mio caso, trovo quest’impostazione equilibrata rispetto ai rischi di futuri rimorsi e rimpianti. Quindi per me va bene così.
Però se uno pensa che l’AI spaccherà tutto, l’america dominerà fino a diventare il nuovo impero Romano d’occidente o quello che vi pare, queste tesi non sarebbero affatto infondate e concentrare tanto sugli Stati Uniti potrebbe essere una scelta giusta.
– La seconda cosa che volevo dire prima di proseguire è che non mi sono limitato a ridurre il peso degli Stati Uniti, ma ho cercato di ridurre gli effetti della concentrazione delle Magnifiche 7 anche in un altro modo, ma ve ne parlo alla fine della parte azionaria, perché non riguarda solo gli Stati Uniti.
Andiamo avanti un po’ più spediti, perché chiaramente questo 58% di Stati Uniti richiedeva un po’ di discussione.
Il secondo blocco per grandezza nel mio portafoglio azionario è rappresentato dai paesi sviluppati extra Unione Europa, con il 18%.
Parliamo prevalentemente di Giappone, Regno Unito, Svizzera, Danimarca, Canada, Australia, Taiwan e Hong Kong.
Danimarca e Taiwan praticamente solo per 2 società: Novo Nordisk e Taiwan Semiconductors.
Questo 18% è ottenuto con un mix di ETF su MSCI World, Stoxx 600 e MSCI Japan.
Il Giappone è il più pesante del gruppo.
Siamo intorno al 7-8% della parte azionaria, che è significativamente di più del 5% che occupa nell’MSCI ACWI.
Ovviamente se riduci gli Stati Uniti, altri Paesi acquistano peso.
Il Giappone è un mercato che gode di prospettive piuttosto interessanti perché ha fatto importanti riforme che vanno nella direzione di agevolare le perfomance societarie, oltre al fatto che le valutazioni generalmente economiche e uno Yen che potrebbe rafforzarsi se la Bank of Japan continuerà ad alzare pian piano i tassi di interesse che lì incredibilmente sono ancora vicini a zero, ecco, queste sono tutte cose che mi rendono felice di avere un piede bello piantato in Giappone.
Gli altri Paesi invece sono leggermente sovrappesati, ma solo perché appunto sono stato un po’ indietro sugli Stati Uniti, non ho preso invece alcuna decisione specifica.
Il terzo blocco è invece l’Eurozona.
Nell’indice MSCI ACWI il blocco formato soprattutto da Francia, Germania, Italia, Spagna e Olanda non arriva neanche al 10%.
Io ho circa il 12% ottenuto aggiungendo un ETF sull’Eurostoxx 50.
Anche qui: in parte la percentuale è superiore sempre perché ci sono meno Stati Uniti.
In parte ho dato io un piccolo tilt, scegliendo di sovrappesare solo le grandi società Europee sin dai tempi in cui si parlava tanto delle Granolas, vi ricordate?
Era stata Goldman Sachs un po’ di anni fa a parlare delle Magnifiche d’Europa.
Granolas sta per: GSK, Roche, ASML, Novartis, L’oreal, Astrazeneca, Nestlé, Sap e Sanofi.
Con l’Eurostoxx 50 in realtà si va a prendere solo 4 di queste, perché le altre 5 sono inglesi e svizzere, che però comunque sono già ben rappresentate nello Stoxx 600.
Insomma.
L’Europa non è un mercato esuberante.
Però ci sono ancora dei colossi che hanno un peso rilevante a livello internazionale.
Nell’Eurozona abbiamo colossi del lusso come Hermes, LVMH e la nostra Ferrari.
Colossi finanziari come BNP Paribas, Santander e la nostra Intesa.
E non dimentichiamoci che praticamente il 90% degli aerei su cui tutti noi viaggiamo sono fatti da due sole compagnie: Airbus, Franco Tedesca, e Boing, Americana.
Come sapete bene, a furia di perdere pezzi durante i voli, Boing sta vivendo un periodo nero che dura ormai da diversi anni.
Dal 2016 ad oggi, l’azione di Airbus è cresciuta di oltre il 200%, quella di Boeing, appena del 35%.
Insomma, qua mi è andata un po’ di culo, però in effetti da dopo il Covid l’indice delle blue chip dell’eurozona è andato nettamente meglio dello Stoxx 600, circa 62% di crescita in 5 anni contro 47%.
Certo, nello stesso periodo l’S&P ha fatto +104%… ma questa è un’altra storia.
Diciamo che volevo due cose:
– Volevo avere un minimo di azionario in valuta domestica, in Euro, ma mi sentivo più sereno a stare sulle Large cap. Se prendiamo invece l’MSCI EMU, che contiene anche le Mid e Small Cap dell’eurozona, non sarebbe andata altrettanto bene.
– Inoltre, avendo tantissimo tech con gli Stati Uniti, questo mi ha dato un tilt fattoriale implicito verso realtà più tipicamente Value, vista la predominanza di settori tradizionali in Europa rispetto agli Stati Uniti e alle valutazioni generalmente basse.
Ultimo pezzetto di azionario, almeno a livello di ripartizione geografico, mercati emergenti.
Qui ho leggermente meno del 12%.
Non è un’esposizione bassissima, perché rispetto all’MSCI ACWI ho probabilmente 2-3 punti percentuali in più.
Però non credo faccia una differenza sostanziale.
Sugli Emergenti ho una posizione abbastanza agnostica.
Non ho intenzione di spingere particolarmente, sono un po’ frenato dal rischio specifico soprattutto di natura geopolitica e non sono uno di quelli che è convinto che un domani Cina e India saranno il nuovo centro del mondo.
In Cina avrò sì e no il 3% della componente azionaria.
Ogni tanto ha delle fiammate, soprattutto alimentate da interventi pubblici, ma resta pur sempre un paese con enormi limiti a livello giuridico, cosa che la rende un mercato difficilmente investibile.
È vero, ha un PIL che si sta avvicinando a quello degli Stati Uniti, ma in un mondo post globalizzato dovrà fare i conti con una nuova era in cui non so fino a che punto resterà la grande fabbrica dell’economia globale.
E sappiamo anche tutti i problemi interni che ha: demografia stagnante, disoccupazione giovanile (presunta, visto che per risolvere il problema l’anno scorso il governo ha deciso di non pubblicare più il dato, out of sight out of mind) e poi c’è quella terribile crisi immobiliare latente che ha devastato la ricchezza privata di milioni di cinesi.
Semi parafrasando Winston Churchill, la democrazia e il capitalismo sono i peggiori sistemi che esistono. Tranne tutti gli altri.
E su questi due punti, la Cina ha degli enormi limiti.
Anche sugli altri Paesi, boh.
Tanti parlano dell’India, pochi si ricordano che il mercato azionario indiano è più costoso di quello Americano.
Messico, Brasile, Arabia Saudita sono tutti Paesi che possono certamente crescere di peso nei prossimi anni.
Ma è altrettanto possibile che si manifestino delle fragilità strutturali.
Con buona pace del mio amico Paolo Coletti che tanto ama Tacos e Burritos, se Trump applica il 25% di dazi sulle importazioni Messicane fondamentalmente la sua economia dura come il famigerato gatto in tangenziale.
Il fatto che Sheldon mi stia rompendo da un’ora perché vuole mangiare è del tutto irrilevante nella formulazione di quest’ultima metafora.
Comunque, dicevo, 12% scarso negli Emergenti, se un domani crescono bene, un piede ce l’ho. Se continuano a rimanere un’eterna promessa come il Godot dei mercati finanziari globali, poco male, il danno al portafoglio non sarà clamoroso.
Ora, prima di chiudere con la parte azionaria, devo aggiungere una cosa, come dicevo prima.
Come avrete capito nei mesi, episodio dopo episodio, sono certamente convinto convinto che i mercati siano efficienti e che nessuno possa consapevolmente dire che siamo in una bolla.
Eugene Fama ce lo disse con grande chiarezza. Per essere una bolla devi poterla prevedere. Altrimenti non è una bolla, è solo variazione nei prezzi.
Quindi non si può dire che siamo in una bolla.
Si può dire che si stanno vedendo tanti comportamenti tipici di un periodo in cui si gonfiano le bolle, è nessuno meglio di Owen Lamont ha descritto questa cosa in un articolo divertentissimo, come tutti i suoi articoli, dal titolo “There are idiots. Look around”.
La frase sarebbe dell’ex segretario del tesoro Larry Summers e in generale si riferisce a comportamenti sui mercati difficilmente riconciliabili con i fondamentali che in ultima istanza “potrebbero”, condizionale d’obbligo, creare delle distorsioni a lungo termine nei prezzi.
– Eugene Fama direbbe: non è vero perché le azioni degli idioti verrebbero compensate dalle azioni degli investitori informati;
– Grossmann e Stiglitz, padri del famoso paradosso, direbbero: sì distorcono i prezzi, ma ciò crea un incentivo per tutti gli altri investitori informati a fare ricerca e analisi per prezzare correttamente gli asset quotati e quindi fare soldi a spese degli idioti;
– Richard Thaler e tutti quelli della Behavioral Finance, direbbero: sì, ci sono idioti, gli idioti gonfiano le bolle perché il mercato finisce per incorporare nei prezzi atteggiamenti irrazionali.
Scegliete voi da che orate volete stare.
Comunque dicevo, non tra quelli “ehi c’è una bolla scappiamo tutti”.
I miei pensieri sono un po’ quelli nella media.
Mercato con valutazioni molto elevate, in America perlomeno.
Elevata concentrazione in un manipolo di mega aziende tech.
Elevata correlazione.
Queste cose, attenzione, non sono né positive né negative.
Nel senso che, come ha dimostrato Moubussin in uno studio che abbiamo citato più volte, anche questo in descrizione se volete, durante i bull market tendono a salire tre cose:
– Le valutazioni;
– Le concentrazioni;
– Le correlazioni.
Quindi, possiamo discutere se siamo arrivati a livelli eccessivi.
Ma resta il fatto che queste cose, da un punto di vista qualitativo, sono più che altro una conseguenza del fatto che il mercato stia correndo da 15 anni più o meno ininterrottamente.
It’s a feature, not a bug.
Detto questo, il mercato è anche fatto di cicli.
Per un certo periodo di tempo è trend-following, cioè continua a seguire la strada tracciata.
Ma dopo un po’ diventa mean reverting, cioè tende a regredire verso i suoi valori medi.
Impossibile dire quando, ma è probabile che i cicli si alternino e che ciò che è andato su tanto ad una certa torna giù.
Ci sono tonnellate di paper, di cui uno anche di Fama e French, che dimostrano che società che hanno avuto crescite abnormi non hanno mai mantenuto questi ritmi per più di 10-15 anni.
Più spesso che no i vincitori di oggi saranno i perdenti di domani.
Comunque, senza sconfinare nella divinazione di scenari futuri imperscrutabili, veniamo al punto.
Sappiamo che, in teoria, se io investo in un indice market-cap-weighted il fattore a cui sono principalmente esposto è il Beta, che in questo caso è il mercato stesso, perlomeno secondo il modello del CAPM di William Sharpe.
Negli anni, però, Fama e French, Jegadeesh e Titman e tanti altri hanno messo in evidenza il ruolo sistematico di altri fattori, che tendono ad essere persistenti, benché su singoli periodi storici abbiano comportamenti molto diversi.
Dei mille fattori che sono stati più o meno scovati, quelli che sembrano più accreditati e su cui c’è maggior consenso sono, direi, quattro:
– Momentum,
– Value
– Quality
– Size
Ci sarebbe anche Low Volatilty, per qualcuno anche Dividend è un fattore, nel modello a 5 fattori di Fama e French c’erano Profitability e Investment che in parte sono confluiti in quello che oggi si chiama Quality, grazie forse soprattutto al contributo dell’allievo di French Cliff Asness e così via.
Però, Momentum, Value, Quality e Size possono serenamente essere considerati i big 4.
Momentum è il fattore che espone alle società che sono cresciute di più negli ultimi 12 mesi.
Value, società con basso prezzo rispetto al valore patrimoniale.
Quality, società con elevati ritorno sull’equity, basso indebitamento e crescita stabile delgi utili.
Size infine espone a società small cap, secondo l’idea che storicamente le small cap incorporano un rischio maggiore e quindi pagano un premio superiore a chi ci investe.
Ad un certo punto ho voluto dare un tilt al portafoglio per espormi a 3 di questi 4 fattori.
3, perché ho scelto di non avere esposizione alle small cap.
Sono un investitore da Large Cap.
Non c’è una buona motivazione finanziaria dietro.
Semplicemente sono felice di prendermi il rischio di investire in azioni di grandi aziende, meno di prendermi del rischio ulteriore per investire in azioni di piccole società.
Sono fatto così.
Alla fine uno investe anche in base a come è fatto.
Però mi attirava molto l’idea di avere, diciamo così, delle specifiche concentrazioni del portafoglio che andassero ad aggiungere un po’ di rischio sistematico, ma combinando tra di loro diverse dinamiche.
Sappiamo bene che un ETF fattoriale in parte fa quello che ci aspettiamo, in parte è una mezza marchetta degli emittenti di ETF, che ti fanno pagare di più questi ETF nella tua speranza di avere un maggior rendimento.
Ma come investitore retail non è che abbia molte altre opportunità per crearmi delle esposizioni fattoriali, quindi ho tagliato la testa al toro è ho investito in tre ETF fattoriali su MSCI World Momentum, Quality e Value, più o meno in parti uguali.
In totale circa un quinto della mia quota azionaria è su questi fattoriali.
Quando prima vi ho dato le percentuali geografiche avevo già tenuto conto anche del peso delle varie regioni dentro questi ETF, quindi questo 20% è un di cui di quello che ho detto prima.
Soffermiamoci un secondo su questi tre.
Negli ultimi 10 anni è facile immaginare come siano andate le cose:
– Momentum ha dominato, crescendo di oltre il 320%;
– Quality ha fatto molto bene, 250%, circa un 10 punti percentuali in più dell’MSCI World classico;
– Value, comprensibilmente, è rimasto indietro: +120%, metà dell’MSCI World.
Momentum e Quality hanno una composizione geografica simile, con gli Stati uniti che pesano il 70% in entrambi.
Value invece no. Qui gli Stati Uniti hanno meno del 40% del peso e ben il 23% è attribuito al Giappone.
Se andiamo a prendere le prime 10 posizioni di ciascun indice, troviamo in effetti cose che non troveremmo tra i top 10 holding dell’MSCI World classico.
– in Momentum abbiamo per esempio società come Walmart, Berkshire Hathaway, Costco e Netflix;
– in Quality troviamo: Vista, Mastercard e l’olandese ASML;
– in Value invece tutte le prime 10 non si trovano tra le prime 10 dell’MSCI World: Cisco, IBM, Qualcomm, Toyota, AT&T, Intel, Verizon, HSBC, Comcast, British American Tobacco.
Rispetto ai primi due, qui c’è una maggior concentrazione di realtà nel settore industriale, finanziario, media e nella tecnologia più tradizionale, come Cisco, Intel e IBM.
Una differenza abissale è anche nel rapporto tra prezzi e utili attesi:
– Momentum e Quality intorno a 22;
– Value 10.
Ricordiamoci sempre che investire in società con un rapporto tra prezzi e utili basso è più rischioso, non meno rischioso, perché sto scommettendo, sempre per usare un esempio efficace, che il Real Madrid non schianterà il Salisburgo.
Ma se penso che ad un certo punto le valutazioni alte avranno un impatto negativo sui rendimenti futuri, anche qui, un piedino su Value mi piaceva averlo.
Fine della parte azionaria.
Scusate se vi aspettavate qualcosa di più frizzante.
Ma come dicevo uno investe così com’è.
E io sono piuttosto noioso.
Ora, ero tentato di dividere in due l’episodio, per poi parlare in grande dettaglio anche del resto del portafoglio, ma poi ho pensato che il “ne parleremo nel prossimo episodio” fa sempre un po’ girare le palle.
Quando da piccolo ero uno sfegatato fan di quel terribile telefilm sui Power Rangers, quando facevano gli episodi divisi in due parti mi rovinavano il pomeriggio.
Quindi, portate pazienza ancora qualche minuto che vediamo il resto.
Abbiamo detto che il 67% circa del portafoglio è in Azioni.
Andiamo ora a vedere come è composto il restante 33%.
28% è in obbligazioni, 5% è in oro.
Sì, qui ho un po’ barato.
Fino a qualche mese fa erano solo obbligazioni, di cui però circa 5% erano High Yield.
Poi cos’è stato, forse subito dopo l’elezione di Trump l’oro ha avuto un momento di ripiego, passando da 2.800 $ l’oncia a 2.560 mi sembra.
Siccome, lo ammetto, non amo l’oro e come investimento mi sta pure un po’ antipatico e se Warren Buffett vedesse il mio portafoglio disapproverebbe, però dall’altra parte un po’ mi rodeva continuare a vederlo correre così tanto, mi ero detto: ora o mai più.
Una mattina a metà novembre l’oro era ancora sotto i 2.600, gli High Yield ormai hanno un costo folle perché rendono solo leggermente di più di un Treasury nonostante il rischio molto più alto che teoricamente incorporano, quindi via High Yield e ho comprato l’equivalente di circa il 5% del mio portafoglio di oro.
Da allora è cresciuto di circa un 12-13%, ma il suo peso non è cambiato perché nel frattempo ho continuato ad investire in altre cose.
5% non sposta molto.
Forse, se proprio devo avere l’oro per fargli fare quello che dall’oro ti aspetteresti, quindi protezione, inflation hedge, rischio geopolitico, solite cose, magari avrebbe più senso averne un po’ di più o non averne affatto.
5% è un po’ vorrei ma non posso, magari in futuro valuterò.
Obbligazioni, le vostre amate obbligazioni.
In realtà qui molto easy.
Il grosso sono obbligazioni governative europee, un po’ meno di 2/3 del totale.
Il resto sono fondamentalmente treasury e qualcos’altro sempre di paesi sviluppati.
Non voglio avere debito di paesi emergenti.
Perché?
Forse perché lo capisco poco, non ne ho mai approfondito le dinamiche.
Non ci vedo comunque una particolare opportunità nell’averlo in pancia.
Circa un 20% del blocco obbligazionario sono corporate investment grade.
Sulle obbligazioni, comunque, val la pena secondo me considerarle divise in due macroblocchi, in base alla duration.
Infatti ho due terzi in obbligazioni a scadenza intermedia, con duration intorno a 6, e un terzo in obbligazioni governative europee a lunga scadenza, con duration media intorno a 16.
Non ho obbligazioni a lunga scadenza in valute diverse dall’Euro perché già con le lunghe scadenze mi prendo il rischio duration e non volevo sommargli anche il rischio valuta.
Anche qui, è tutto piuttosto banale e non ci sono idee geniali.
Le obbligazioni intermedie sono la quota, tra molte virgolette, risk-free del portafoglio, ciò che va a togliere un po’ di volatilità generale.
Le obbligazioni a lungo termine, invece, che tra l’altro avevo comprato piuttosto bene, del tutto casualmente, nell’ottobre del 2023, quando praticamente avevano toccato il fondo dopo 2 anni, dicevo queste mi aspetto che non vadano più o meno da nessuna parte in questi anni di tassi ancora piuttosto alti e crescita sostenuta, anche se nell’ultimo anno, comunque, un 5% se lo sono portati a casa, ma che però dicano la loro se dovesse verificarsi un brusco tracollo economico con conseguente sforbiciata mostre dei tassi.
Ovvio che hanno anche un rischio opposto: ossia in caso di un nuovo picco di inflazione, questi van giù più delle azioni.
Però insomma, è normale che ci siano sempre parti del portafoglio che funzionano meglio e altre meno.
In questo momento è tutto bello perché ogni singola riga del portafoglio è in verde, con alcune situazioni, come ad esempio un ETF sull’S&P 500, che ovviamente ha accumulato negli ultimi anni una crescita disumana.
In futuro non sarà sempre così e arriveranno momenti in cui le azioni soffriranno e magari alcune obbligazioni, o l’oro, o le materie prime o altre cose ancora avranno la loro ribalta.
Ora, prima di chiedere, 3 considerazioni.
PRIMA CONSIDERAZIONE: qual è il livello di rischio del mio portafoglio?
Probabilmente ha un livello di rischio sistematico è superiore a quello che avrebbe un portafoglio con la stessa asset allocation ma più, diciamo, plain vanilla e market cap weighted.
Quali sono gli elementi che lo rendono più rischio?
– I fattoriali, per definizione se tilti un portafoglio verso un fattore, l’eventuale, e sottolineo eventuale, extrarendimento viene al costo di un extra rischio (certo).
– Il fatto di sovrappesare leggermente alcuni mercati con bassi prezzi.
– E infine le obbligazioni a lunga scadenza.
Penso però che questo maggiore rischio sistematico abbia anche un beneficio in termini di riduzione di alcuni rischi specifici.
Ho un’esposizione leggermente inferiore a Stati Uniti in generale elle Magnifiche 7 in particolare.
Ho un’esposizione leggermente più bilanciato rispetto a settori diversi dal tech.
Ho una forte dipendenza dal dollaro sulla parte azionaria, ma una predominanza dell’euro su quella obbligazionaria.
Dopo tanto ragionarci sopra, ho deciso che mi sta bene.
SECONDA CONSIDERAZIONE: cosa manca?
Ci sono delle cose che, volendo, colmerebbero delle lacune nel portafoglio.
– Per esempio, dato che ho un po’ barato sull’asset allocation partendo dalle varie formule, perché ho messo l’oro al posto delle obbligazioni, forse potrei pensare di mitigare un po’ di rischio sostituendo un 5-10% di azioni con altrettante obbligazioni corporate. Il bloomberg global aggregate corporate, quindi obbligazioni societarie globali investement grade, ha in questo momento uno yield to maturity medio del 5% con duration intorno a 6 anni e mezzo.
Questo non vuol dire che il 5% sia garantito, anche perché va considerato l’impatto del cambio valutario, però se Goldman Sachs ha ragione a pensare che i rendimenti futuri americani saranno miseri, questa decisione non sarebbe del tutto fuori luogo.
– Un’altra cosa che manca sono le materie prime. Da un lato non mi piacciono. Investire in materie prime è investire contro l’ingegno umano, che farà sempre di tutto per ridurre il più possibile la sua dipendenza da madre natura. D’altra parte le materie prime hanno sempre un loro perché soprattutto nelle fasi con inflazione crescente.
– Per lo stesso motivo, mancano forse quelli che Meb Faber chiama real assets. Oltre alle materie prime, non ci sono obbligazioni indicizzate all’inflazione e manca anche una focalizzazione specifica verso azioni di società legate alle materie prime o alla realizzazione di infrastrutture. Così come non ho REIT, fondi real estate.
Non ho una particolare passione per il mondo immobiliare, forse perché un po’ il declino demografico mi spaventa a lungo termine. Non lo so. Però non ci ho mai trovato una particolare opportunità ad investire in un settore che comunque è fortemente correlato all’azionario ma è meno efficiente. Quindi passo.
Forse invece un 5% di obbligazioni inflation linked potrebbero avere senso. Le ho sempre però viste più come qualcosa di molto sensato in un portafoglio conservativo, orientato a generare income, che non in un portafoglio destinato ancora a lungo alla crescita.
TERZA e ULTIMA CONSIDERAZIONE: come investo?
Allora per quanto riguarda, diciamo, il core del portafoglio, ho attivo un PAC mensile con il piano Replay di Fineco su 5 ETF:
– 3 azionari, che coprono Stati Uniti, Europa e Emergenti e
– 2 obbligazionari, uno sulle scadenze intermedie e uno su quelle lunghe.
Alcuni di questi ETF sono tra quelli che Fineco offre a zero commissioni emessi da iShares, Amundi e Xtrackers e complessivamente spendo circa 3€ al mese per il PAC.
Sugli altri invece faccio acquisti episodici, a seconda di quanto ho surplus di risparmio o se faccio dei ribilanciamenti.
Dato che, ormai mi conoscete, ho le braccina corte che avrei fatto invidia a un T-rex, cerco di spendere sempre meno possibile sulle commissioni e per esempio gli ETF fattoriali che utilizzo sono disponibili a zero commissioni con tutti e tre gli emittenti, quindi sia iShares che Amundi che Xtrackers.
Se state cercando la piattaforma più completa che esista in Italia per investire, con regime amministrato e accesso ad una gamma sterminata di soluzioni di investimento, in descrizione trovate un link per aprire un conto con Fineco e un codice per avere 60 operazioni gratuite nei primi 6 mesi.
Questo contenuto è sponsorizzato da Fineco e il sottoscritto riceverà gargantuesche commissioni da Fineco se aprite un conto tramite il suo link.
Bene cari miei, credo che ci siamo detti un po’ tutto.
Oggi abbiamo fatto la radiografia al mio portafoglio e spero che al di là delle decisioni che ho preso io, che contano come il proverbiale due di picche a briscola, tutto ciò stato utile per condividere dei ragionamenti che magari potreste valutare di fare con i vostri portafogli e che potrebbero portarvi a scelte diverse ma più adatte a ciascuna specifica situazione.
Fatemi sapere che ne pensate e se volete potete contattarmi tramite il mio profilo instagram thebull_finance.
Prima di lasciarci vi invito come sempre a mettere segui e attivare le notifiche su spotify, apple podcast o dove ci ascoltate e a lasciare una recensione a 5 stelle per supportarci e permetterci di continuare a produrre contenuti che ogni tanto continueranno a raccontarvi come investo i miei soldi ma consigliandovi anche di fare i compiti a casa e non copiare sempre nuovi.
Per questo episodio invece è davvero tutto e noi invece ci risentiamo domenica prossima con un episodio spettacolare con una altro straordinario ospite più volte citato in questo posto: investitore milionario, autore di oltre 18 libri di finanza personale e autorità indiscussa di ciò che potremmo chiamare buon investimento basato sui fatti e non sulle opinioni, il grandissimo Larry Swedroe, sempre qui naturalmente, con The Bull il tuo podcast di finanza personale.
Recensioni
Quando capisci come funziona la finanza… ti viene voglia di raccontarla!
Veramente interessante, chiaro e conciso. Cambia la vita finanziaria di chiunque.. da ascoltare assolutamente anche per chi di finanza non vuole occuparsi mai
Francesca B., 6 Apr 2024Dovrebbero ascoltarlo buona parte degli italiani e io avrei dovuto scoprirlo con qualche anno in anticipo ma meglio tardi che mai
Matteo C., 3 Set 2025Ho seguito tutte le puntate! Grazie veramente
Amalia A., 17 Set 2025Podcast che dà sempre spunti interessanti che personalmente mi ha fatto appassionare alla finanza personale spingendomi ad approfondire in prima persona.
Lorenzo, 13 Mar 2025Ho acquistato e letto il suo libro e l' ho trovato. Esprime i concetti economici in modo semplice e chiaro. Sentirlo parlare conferma che è un professionista del settore.
Giulia N., 11 Ago 2025Veramente veramente raccomandato! la finanza personale riassunta alla perfezione! e spiegata partendo dall'ABC! Ottimo anche da ascoltare a velocita 1,5x!
Giorgia R., 23 Gen 2025Podcast piacevole, scorre veloce ma in modo estremamente chiaro, spiega i concetti chiave per gestire le proprie finanze, fornendo la classica cassetta degli attrezzi. Complimenti, davvero ben fatto!
Massimiliano, 29 Mag 2024Da quando l'ho scoperto in 15 gg mi sono ascoltato 150 puntate senza fermarmi, ho annullato gli altri podcast per portarmi alla pari ed ascoltare tutte le precedenti puntate, ben fatto, esattamente il livello di informazione che mi serviva
Gianluca G., 11 Set 2025La mia ignoranza in materia mi ha sempre creato dei dubbi, ma grazie a un amico ho iniziato ad ascoltare il podcast. Per fortuna che ho 24 anni e un po' di tempo e soldi da dedicarmi a imparare le varie nozioni per me stesso. Grazie mille!
Luca G. 10 Ott 2025